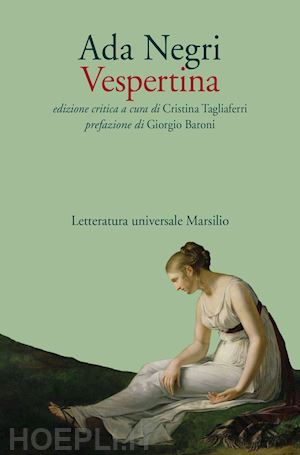Autore dell’opera: Ada Negri (Lodi, 1870 – Milano, 1945)
Titolo dell’opera: Vespertina
Ambito cronologico: età contemporanea / secolo XX
Ambito linguistico: Italiano
Tipologia di trasmissione dell’opera: a stampa con edizioni d’autore e non d’autore
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione: manoscritti autografi, edizioni a stampa
Titolo edizione: Vespertina
Curatore edizione: Cristina Tagliaferri
Tipologia di edizione: edizione critica
Sede di pubblicazione: Venezia, Marsilio Editori
Anno di pubblicazione: 2020
Lingua di pubblicazione: Italiano
Dati bibliografici completi: Ada Negri, Vespertina, a cura di Cristina Tagliaferri, prefazione di Giorgio Baroni, Venezia, Marsilio, 2020, collana «Letteratura universale Marsilio», ISBN 978-88- 297-0727-0, pp. 216
Autore recensione/scheda: Ginevra Rosa
Tipologia di contributo: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda: OEC
Informazioni aggiuntive: questa scheda è parte del lavoro richiesto agli studenti per l’esame di Filologia editoriale (a.a. 2023/24), di cui è titolare la prof.ssa Virna Brigatti
1.
• prima edizione dell’opera*:
Ada Negri, Vespertina, Milano, Mondadori, 1931 (ma novembre 1930), collana «Poesia» (M31): «stampata il 30 novembre 1930, ma pubblicata con l’indicazione del gennaio 1931 a seguito di un’edizione speciale a tiratura limitata […] uscita nel mese di dicembre. Fra le due non si riscontrano difformità testuali» (p. 32).
• successive edizioni vivente l’autore
- Ada Negri, Vespertina, Milano, Mondadori, 1931, collana «Poesia»: non presenta difformità testuali rispetto alla prima edizione.
- Ada Negri, Vespertina, Milano, Mondadori, 1934, collana «Poesia»: non presenta difformità testuali rispetto alle precedenti edizioni.
- Ada Negri, Vespertina, in Vespertina. Il dono, Milano, Mondadori, 1940, collana «Le Pleiadi» (M40).
- Ada Negri, Vespertina, in Vespertina. Il dono, Milano, Mondadori, 1943, collana «Le Pleiadi» (M43).
• per le edizioni qui sopra elencate il testo è stato rivisto dall’autore o da altro soggetto riconosciuto (se questa informazione è nota)?
Sì, dall’autore
• edizioni postume:
Ada Negri, Vespertina, in A. negri, Poesie, Milano, Mondadori, 1948, collana «I classici contemporanei italiani» (M48): presenta «una marcata peculiarità rispetto ai testimoni che lo precedono, quantomeno per la presenza di numerose varianti paragrafematiche e formali […] non direttamente riconducibili alle intenzioni della poetessa» (p. 31).
• edizione corrente e testo su cui si basa
Ada Negri, Vespertina, in A. negri, Poesie, Milano, Mondadori, 1948, collana «I classici contemporanei italiani» (M48)
• primi testimoni noti dell’opera*:
a) pubblicazioni in rivista: «Almanacco letterario», Milano (AL), «Il convegno. Rivista di letteratura e di arte», Milano (C), «La Festa. Rivista settimanale della famiglia italiana», Milano (F), «La Fiera letteraria. Giornale settimanale di lettere scienze ed arti», Milano (FL), «Nuova Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti», Roma (NA), «Rassegna Nazionale», Roma (RN), «Il Secolo XX. Rivista popolare illustrata», Milano (S). Queste «ospitano un gruppo di testi di Ada Negri nel periodo che precede la loro prima stampa in volume (novembre 1930), per un totale di diciassette componimenti» (p. 32).
b) primo testimone autografo noto: Canti di Villasanta (CV). I componimenti apparsi in rivista «vengono ripresi e rimaneggiati in CV […] stesura ancora preparatoria del libro di poesie, dove all’attività di rifacimento si affianca un intenso lavoro di composizione dettato da una nuova fase di ispirazione creativa» (p. 32).
c) secondo testimone autografo: Stella Vespertina (SV), che attesta l’evoluzione di CV, «fra scelte e soppressioni destinate a incidere significativamente sulla forma ultima della raccolta, sebbene in via non ancora definitiva. […] Questo secondo manoscritto […] riflette l’ultima volontà dell’autrice prima di affidare le poesie alla mediazione editoriale» (p. 32)
2.
• precedente edizione critica del testo*: NO
• precedente edizione scientifica di riferimento*: NO
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
Nella Nota al testo la curatrice spiega di aver deciso di porre a testo le poesie di Ada Negri «secondo la lezione tratta dall’ultima edizione sovraintesa dall’autrice (M43), riprodotta nella sua forma originale» (p. 31). Si è attuata questa scelta ecdotica in quanto M48 aveva rappresentato fino ad allora l’edizione di riferimento nella tradizione degli studi su Ada Negri, nonostante «questo presenti una marcata peculiarità rispetto ai testimoni che lo precedono, quantomeno per la presenza di numerose varianti paragrafematiche e formali […] non direttamente riconducibili alle intenzioni della poetessa» (p. 31).
4.
• criteri di edizione*
Nella Nota al testo la curatrice afferma che «l’apparato genetico è costituito da un’unica fascia a eccezione di tre poesie per le quali si rende preferibile una doppia articolazione» (p. 36). I criteri d’organizzazione dell’apparato sono quelli normalmente in uso:
a) La lezione del testo soggetta a variazione è riferita col numero del verso o dei versi in cui ricorre, ed è delimitata da una parentesi quadra chiusa […]
b) La variante segue alla parentesi quadra chiusa ed è individuata dalla sigla del testimone, o dei testimoni concordi nel riferirla.
c) Gli esponenti numerici progressivi in corrispondenza di una serie di varianti ne marcano la successione» (p. 36).
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Nell’Introduzione – in particolare alle pp. 11 e 12 – la curatrice spiega che l’origine della raccolta di poesie Vespertina potrebbe risalire ai quattro o cinque anni precedenti la sua pubblicazione, avvenuta nel 1930. Infatti, intorno al ’26 Ada Negri parlava, in una sua lettera conservata presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, di un volume di poesie composte da endecasillabi sciolti, che lei stessa chiama «un vero e proprio poema lirico». Sappiamo che un nucleo circoscritto di queste poesie nacque in realtà per entrare nell’editoria periodica, infatti alcuni componimenti sono comparsi anzitutto in rivista (cfr. punto 1 – primi testimoni noti dell’opera): in questo modo, l’autrice poteva anche testare «le prime impressioni di lettori e critici, con la possibilità di meditare sull’efficacia di alcune scelte creative, ripensandole» (p. 11). La curatrice, citando le parole che la stessa autrice scriveva in una lettera del maggio 1928, spiega che il lavoro condotto da Ada Negri per costruire questo volume di poesie è stato molto sofferto, laborioso ed impegnativo: «ore ed ore a mutare, a limare, a correggere e mi esaspero sulle pagine. Non so che cosa ne salterà fuori» (p. 12). Le tappe di questo grande laboratorio creativo sono attestate nei testimoni manoscritti e a stampa che sono stati studiati dalla curatrice per allestire questa edizione critica. La curatrice spiega anche che tutto ciò testimonia un cambiamento nel modus scribendi dell’autrice: infatti era la stessa Ada Negri ad affermare, nel 1905, che le sue poesie si dispiegavano sulla pagina come «l’emergere improvviso, nella sua mente, dell’“idea di una poesia”, talmente imperiosa e definita nella forma da non dover quasi mai richiedere un faticoso lavoro di lima» (p. 12).
6.
• fonti archivistiche consultate dal curatore*
- Fondazione Banca Popolare di Lodi (FBPL), Lodi, Fondo Ada Negri: presenza di CV.
b. Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, AME, Segreteria editoriale autori italiani – sez. Manoscritti, fasc. Ada Negri: presenza di SV e del primo e del secondo fascicolo delle prove di stampa (PS1 e PS2).
7.
• tipo di apparato/i*: genetico, orizzontale
• posizione dell’apparato*: a fondo volume nella sezione Commento ai testi e apparato delle varianti
8.
• presenza di note / commento al testo*: Sì
• tipo di note / commento*: la curatrice fornisce un dettagliato commento personale per ognuna delle poesie in volume. I commenti si concentrano sulle espressioni linguistiche dell’autrice, sulle costanti stilistiche, sulle figure retoriche, sul significato generale e sull’interpretazione dei testi.
• posizione delle note / commento*: fondo volume nella sezione Commento ai testi e apparato delle varianti
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
a) Prefazione: il volume presenta una prefazione scritta da Giorgio Baroni, in cui troviamo una breve presentazione di Ada Negri, poetessa intorno alla quale è sorto negli anni un oblio che ha portato ad accantonare la sua produzione. Baroni ritiene quindi un fatto molto positivo «la rivalutazione critica, in atto da qualche anno, di tutti i suoi scritti, a partire ora da una riedizione, filologicamente curata» (p. 9). L’autore espone poi un’essenziale interpretazione del volume di poesie, affermando la presenza di due elementi di coesione tra i vari componimenti: il sentimento del tempo (e quindi le idee di morte e di eternità) e la tensione verso Dio. Infine, Baroni dichiara che ciò che davvero motiva l’opera è «l’impegno della poetessa a svolgere la propria funzione artistica come dono di sé» (p. 10).
b) Introduzione: il volume presenta un’introduzione scritta dalla curatrice dello stesso, Cristina Tagliaferri. Qui si attesta brevemente la genesi della silloge di Ada Negri, rendendo conto del lungo e laborioso impegno profuso in questa operazione autoriale, nonché delle insicurezze dell’autrice, sia in relazione al titolo da conferire al volume, sia in relazione a quella che sarebbe stata l’accoglienza della critica e dei lettori. La curatrice rende poi conto del grande successo che la silloge ha fatto guadagnare alla poetessa, seppur sia stato relativamente effimero, forse anche in relazione al suo legame con il Regime fascista: Ada Negri venne infatti pubblicamente elogiata dal Duce stesso e insignita del Premio Mussolini, nonché ammessa, come prima e unica donna, nell’Accademia d’Italia. Probabilmente «anche questo capitolo della vita di Ada Negri […] peserà sull’oblio intervenuto a oscurarne la presenza e il valore» (p. 15). Segue poi un’analisi essenziale delle poesie, a livello testuale e di significato, con cui la curatrice intende presentare l’evoluzione autoriale e poetica di Ada Negri. Un commento molto più approfondito di ogni singolo componimento si trova poi nel capitolo dedicato Commento ai testi e apparato delle varianti.
c) Descrizione dei testimoni con varianti manoscritte: in questa sezione la curatrice descrive i manoscritti che ha consultato presso la FBPL e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, ovvero: il manoscritto dei Canti di Villasanta, quello di Stella Vespertina e il primo e il secondo fascicolo di prove di stampa. Si tratta di descrizioni fisico-materiali, cioè indicazione di numero e dimensioni delle carte, e di descrizioni testuali, con illustrazione dell’indice e delle poesie contenute.
d) Appendice: in appendice la curatrice ha inserito due tabelle. La prima illustra gli indici presenti nei testimoni di Vespertina, attestando le variazioni autoriali avvenute «nel passaggio dalla stesura preparatoria alla prima edizione in volume» (p. 39). La seconda tabella rende conto, invece, delle varianti in M48 rispetto ai testimoni precedenti, secondo le seguenti casistiche: uso del segno della dieresi, uso delle maiuscole, varianti morfologiche e lessicali, varianti fonetiche, varianti interpuntive, varianti della struttura strofica.
e) Bibliografia: nella bibliografia la curatrice rende conto di varie opinioni, spesso discordanti tra loro, di critici che hanno commentato il lavoro di Ada Negri mentre la poetessa era ancora in vita: tra gli altri, si ricordano Croce, Borgese, Gargiulo, Bocelli, Titta Rosa, Capasso, Galletti, Sarfatti, Magni, Gorini Costa. La curatrice attesta anche varie traduzioni di Vespertina o quantomeno di alcuni suoi componimenti: francese, portoghese, rumeno, sloveno, greco. Segue la presa di consapevolezza del fatto che Ada Negri sia stata pressoché ignorata dal dopoguerra in poi, anche nelle antologie scolastiche e nei volumi letterari. Al contrario, la curatrice afferma che «negli ultimi anni l’attenzione da parte degli studiosi nei confronti dell’autrice lombarda è notevolmente cresciuta» (p. 210), così come testimoniano alcuni convegni e volumi a lei dedicati. Si segnala infine la bibliografia completa dell’autrice, divisa in poesia, prosa, scritti vari e traduzioni.