Autore dell’opera*: Giovanni Verga (Catania, 1840 – Catania, 1922)
Titolo dell’opera*: I Malavoglia
Altri titoli con cui l’opera è nota: I Vinti / I Vinti: I Malavoglia / I Malavoglia: i vinti
Ambito cronologico*: età contemporanea / secolo XX
Ambito linguistico*: Italiano
Tipologia di trasmissione dell’opera*: a stampa con edizioni d’autore e non d’autore
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione:
- manoscritto autografo
- edizioni a stampa
Titolo edizione*: I Malavoglia
Curatore edizione*: Ferruccio Cecco
Tipologia di edizione*: edizione critica
Sede di pubblicazione*: Catania, Fondazione Verga; Novara, Interlinea
Anno di pubblicazione*: 2014
Lingua di pubblicazione: Italiano
Dati bibliografici completi: Giovanni Verga, I Malavoglia, a cura di Ferruccio Cecco, Catania, Fondazione Verga; Novara, Interlinea, 2014, collana “Edizione nazionale delle opere di Giovanni Verga. Nuova serie. 1”, ISBN 978-88-8212-900-2
Autore recensione/scheda*: Anna Lanfranchi
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
Informazioni aggiuntive: questa scheda è parte del lavoro richiesto agli studenti per l’esame di Filologia editoriale (a.a. 2024/25), di cui è titolare la prof.ssa Virna Brigatti
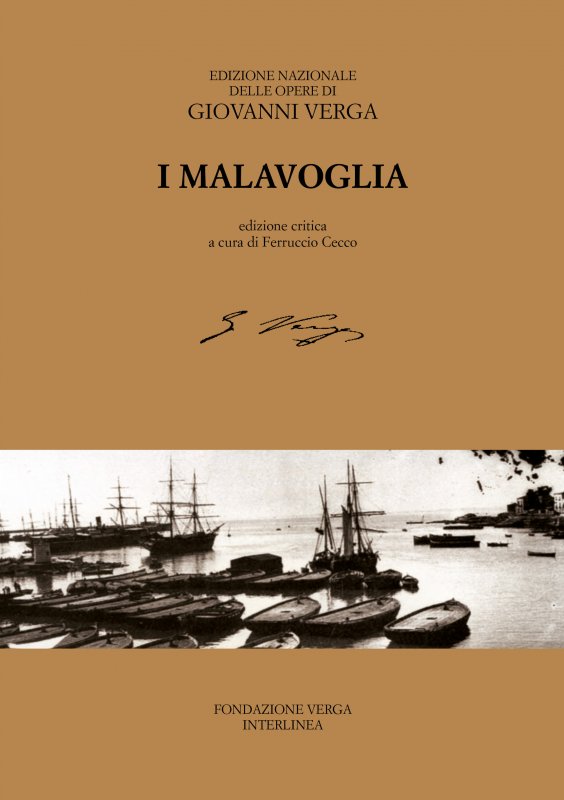
1.
• prima edizione dell’opera:*
Giovanni Verga, I Malavoglia / romanzo di G. Verga, Milano, Treves, 1881 (variante del titolo I vinti., Tit. in testa al front.)
• successive edizioni vivente l’autore:
- Giovanni Verga, I vinti: I Malavoglia / romanzo di G. Verga, Milano, Treves, 1881, 2. ed.
- Giovanni Verga, I Malavoglia: i vinti: romanzo di G. Verga, Milano, F.lli Treves, 1888, 3. ed.
- Giovanni Verga, I Malavoglia: romanzo / di Giovanni Verga, Milano, Treves, 1907 (In testa al front.: I vinti.)
- Giovanni Verga, I vinti; I Malavoglia: romanzo / di Giovanni Verga, Milano, F.lli Treves, 1907
Il testo del 1907 è stato ricomposto e numerose sono le differenze con la princeps. Colpisce la normalizzazione della particolare interpunzione, relativa soprattutto all’uso del trattino che, diversamente dalla prima edizione, viene introdotto a chiudere il discorso diretto. Questo impone una netta distinzione tra discorso diretto e didascalia, laddove nella princeps risulta esserci una “zona fluida” che permette un passaggio continuo dal discorso diretto, all’indiretto libero, alla didascalia. Non ci sono certezze sul fatto che gli interventi siano stati fatti solo dall’editore o se vi abbia preso parte anche l’autore, dunque non si può attribuire alle varianti che vi si riscontrano rispetto alla princeps il valore di varianti d’autore. Da questa edizione in avanti inizia un processo di progressivo distacco dal testo del 1881 a opera degli editori (Introduzione,pp. XV-XVIII).
- Giovanni Verga, I Malavoglia: romanzo / di Giovanni Verga, Milano, F.lli Treves, stampa 1919 (I vinti, Pretit.)
- Giovanni Verga, I Malavoglia: i vinti: romanzo / Giovanni Verga, Milano, Treves, stampa 1920 (il complemento del titolo precede il titolo)
- Giovanni Verga, I Malavoglia: I vinti: romanzo di Giovanni Verga, Firenze, R. Bemporad & f., 1921 (il complemento del titolo precede il titolo)
- Giovanni Verga, I vinti: I Malavoglia / romanzo di Giovanni Verga, Firenze, R. Bemporad, 1921 (Carpigiani e Zipoli), collana “Opere complete di G. Verga”
• edizioni postume:
Dato il cospicuo numero di edizioni postume si è deciso di segnalarne solo alcune, evidenziando i passaggi di collana più significativi e segnalando l’ingresso dell’opera all’interno di nuove sigle editoriali.
Prima del 1939, l’opera è stata pubblicata dalle case editrici Treves, Barion, Morreale, Bietti, Vallecchi e Bemporad (ultima edizione nel 1930).
Dal 1939 al 1992 I Malavoglia è pubblicato principalmente da Mondadori. Significativo è che sia tra i primi titoli a essere inserito nella collana “Oscar Mondadori” nel 1965. È importante segnalare l’enorme quantità di ristampe pubblicate da Mondadori durante questo arco di tempo.
Dal 1978 in avanti l’opera inizia a essere proposta anche da altre sigle, tra cui è significativo ricordare la pubblicazione nella “BUR” Rizzoli nel 1978 e l’uscita presso case editrici come Editori Riuniti (1978), Garzanti (1980), Newton Compton (1984).
Giovanni Verga, I Malavoglia, Milano, Mondadori, 1939, collana “Biblioteca moderna Mondadori” [successive ristampe]
Giovanni Verga, I Malavoglia, a cura di Lina e Vito Perroni, Milano, Mondadori, 1939, collana “Le opere di Giovanni Verga”
Giovanni Verga, I Malavoglia, col commento di Piero Nardi sul testo curato da Lina e Vito Perroni, Milano, Verona, Mondadori, 1940, [edizione per le scuole, successive ristampe]
Giovanni Verga, I Malavoglia, Milano, Mondadori, 1965, collana “Oscar” [successive ristampe]
Giovanni Verga, I Malavoglia, in I grandi romanzi: I Malavoglia; Mastro don Gesualdo, prefazione di Riccardo Bacchelli, testo e note a cura di Ferruccio Cecco e Carla Riccardi, Milano, Mondadori, 1972, collana “I Meridiani” [successive ristampe]
Giovanni Verga, I Malavoglia, cronologia, introduzione e note di Giulio Carnazzi, con un saggio di Leo Spitzer, Milano, 1978, collana “Biblioteca universale Rizzoli” [successive ristampe]
Giovanni Verga, I Malavoglia. Con una scelta di racconti da Vita dei campi e Novelle rusticane, a cura di Enrico Ghidetti, introduzione di Edoardo Sanguineti, con otto tavole originali di Renato Guttuso, Roma, L’Unità, Editori Riuniti, 1978
Giovanni Verga, I Malavoglia, introduzione e note di Nicola Merola, antologia della critica di Lucio Felici, Milano, Garzanti, 1980, collana “I Grandi libri per la scuola” [successive ristampe]
Giovanni Verga, I Malavoglia, a cura di Concetta Greco Lanza, Roma, Newton Compton, 1984, collana “Universale tascabile” [successive ristampe]
Giovanni Verga, I Malavoglia, introduzione di Edoardo Sanguineti, a cura di Enrico Ghidetti, Milano, Feltrinelli, 1993, collana “Universale economica” [successive ristampe]
Giovanni Verga, I Malavoglia, edizione critica a cura di Ferruccio Cecco, Milano, Il polifilo, 1995, collana “Testi e documenti”
Giovanni Verga, I Malavoglia, testo critico e commento di Ferruccio Cecco, Torino, Einaudi, 1995 (stampa 1996), collana “Einaudi tascabili” [successive ristampe]
Dagli anni ‘90 fino a oggi l’opera viene pubblicata, oltre che da case editrici minori, da tutti i maggiori editori (tra cui Mondadori, Rizzoli, Garzanti, Feltrinelli, Einaudi), soprattutto nelle edizioni con curatela sopra citate, di cui si riportano le più recenti (aggiornate al 17 giugno 2025 su OPAC SBN).
Giovanni Verga, I Malavoglia, testo critico e commento di Ferruccio Cecco, Torino, Einaudi, 2014, collana “ET”
Giovanni Verga, I Malavoglia, introduzione e note di Nicola Merola, Milano, Garzanti, 2015, collana “I grandi libri” (23. ed)
Giovanni Verga, I Malavoglia, a cura di Giulio Carnazzi, con un saggio di Gustavo Zagrebelsky, Milano, BUR Rizzoli, 2015, collana “BUR Rizzoli. Grandi Classici” (3. ed)
Giovanni Verga, I Malavoglia, introduzione di Carla Riccardi, con un saggio di Vincenzo Consolo, Milano, Mondadori, 2018, collana “Oscar Classici” (ristampa)
Giovanni Verga, I Malavoglia, introduzione di Edoardo Sanguineti, a cura di Enrico Ghidetti, Milano, Feltrinelli, 2019, collana “Universale economica” (23. ed)
• edizione corrente e testo su cui si basa:
Giovanni Verga, I Malavoglia, introduzione di Carla Riccardi, con un saggio di Vincenzo Consolo, Milano, Mondadori, 2016, collana “Oscar Classici” (ristampa 2024)
Il testo riprodotto è quello dell’edizione critica curata da Ferruccio Cecco (Einaudi, Torino, 1995). Lo si legge nella Nota al testo presente immediatamente dopo l’Introduzione.
• primi testimoni noti dell’opera*:
Nella sezione “L’edizione Treves 1881” (Introduzione, pp. XI-XII) si legge che prima della princeps (Treves 1881) sono state pubblicate solo alcune parti de I Malavoglia presso le seguenti riviste:
– Un’anteprima dei Malavoglia col titolo Poveri pescatori! è pubblicata il 1° gennaio 1881 nella “Nuova Antologia”, vol. XXV, serie II, pp. 61-68. Il testo comprendeva uno stralcio ampio del capitolo 10 con pochissimi interventi rispetto alla versione finale, due dei quali sicuramente attribuibili all’autore, che sopprimono riferimenti non comprensibili fuori dal contesto più ampio del romanzo.
– La prefazione ai Malavoglia col titolo Il nuovo romanzo di Verga è anticipata nel numero 6 febbraio 1881 dell’“Illustrazione italiana”, VIII, 6, pp. 90-91.
2.
• precedente edizione critica del testo*
Giovanni Verga, I Malavoglia, edizione critica a cura di Ferruccio Cecco, Milano, Il Polifilo, 1995, collana “Testi e documenti, 8”
• precedente edizione scientifica di riferimento*
Giovanni Verga, I Malavoglia, in I grandi romanzi, prefazione di Riccardo Bacchelli, testo e note a cura di Ferruccio Cecco e Carla Riccardi, Milano, Mondadori, 2006, collana “I meridiani”
3.
• testo dell’edizione critica in oggetto e ragioni della scelta ecdotica*
Nell’Introduzione,a p. LXXXIII, si legge che il testo adottato per I Malavoglia è quello dell’edizione Treves 1881 – testo che è stato «riprodotto fedelmente, mantenendone inalterato, se si fa eccezione per qualche essenziale restauro, anche il particolare sistema interpuntivo che […] viene sottoposto a partire dall’edizione del 1907, e non certo per volontà dell’autore, a vistosi quanto inopportuni interventi di normalizzazione».
Il testo della princeps è stato riprodotto fedelmente anche nelle particolarità grafiche e mantenendo le alternanze di forme tipiche della scrittura verghiana. La possibilità di riscontro sull’autografo ha consentito di verificare se un’alternativa presente nella princeps rispecchiava realmente l’usus scribendi di Verga o se doveva essere imputata al proto. Si è, invece, intervenuti uniformando le alternanze apparenti che non trovavano conferma nell’usus scribendi dell’autore. Ciò che ha giustificato queste scelte è il fatto che alla lezione della princeps vada accordata fiducia, in quanto implicitamente approvata da Verga, che seguì direttamente le fasi di composizione, anche se la sua sorveglianza non fu sempre rigorosa (come testimoniano i numerosi refusi presenti nella princeps,elencati nel dettaglio nell’Introduzione, p. LXXXVII).
Le ragioni della scelta ecdotica sono determinate dal fatto che, dal 1907, ha inizio un processo di progressivo distacco dal testo dell’edizione Treves 1881,a opera di editori che si sono sentiti autorizzati a intervenire per correggere refusi e sviste presenti sulla princeps – edizione, effettivamente, non molto sorvegliata dal punto di vista tipografico. A un progressivo livellamento sono state sottoposte soprattutto le frequenti oscillazioni di forme, le incertezze di uso che caratterizzano la scrittura verghiana e una certa coloritura dialettale. Queste operazioni hanno finito per correggere anche ciò che costituiva parte integrante del romanzo. In conclusione, il testo cui era necessario riferirsi nella costruzione dell’edizione critica doveva essere quello della princeps, «beninteso non feticisticamente riprodotto, ma emendato, con tutte le cautele del caso […], dei refusi e delle sviste dell’autore, sulla base anche di continui riscontri sul manoscritto autografo» (Introduzione, p. XIX).
4.
• criteri di edizione*
Nella sezione “Criteri di edizione” si legge che nel margine destro del testo de I Malavoglia è stata inserita la divisione in commi, mentre al suo interno, evidenziata da due barre verticali, si trova l’indicazione delle corrispondenti carte del manoscritto ultimo A inviato in tipografia, che riporta l’unica redazione completa del romanzo (Introduzione, p. LXXXIII).
Per quanto riguarda gli apparati, il testo è corredato dall’apparato genetico costituito dalle varianti del solo manoscritto A. L’edizione dà conto dei criteri per la lettura dell’apparato (Introduzione, pp. XC-XCI), che si riportano di seguito:
- Alla porzione di testo implicata in variante (indicata, con riferimento numerico in neretto, tramite la parola iniziale e quella finale, inframezzata da puntini, se il brano da richiamare è ampio), segue dopo la parentesi in quadra semplice l’apparato genetico.
- Un esponente numerico progressivo (1, 2, 3) individua, qualora siano più d’una, le varie fasi correttorie, sempre riferite all’intera frase che precede; all’interno di una frase principale l’esponente compare in corsivo.
- Quando la lezione ultima di A coincide con quella a stampa, si usa la sigla TR (Treves), che sarà seguita dal due punti e da una serie di rimandi numerici al testo (in tondo chiaro) tra parentesi, nel caso in cui si debba render conto di uno o più incidenti interni a una lezione che è prossima, ma non identica a quella definitiva; per l’analoga situa nell’apparato degli abbozzi si impiega la sigla T (Testo).
- Le lezioni che precedono quella definitiva sono da intendersi come cassate, salvo diversa indicazione (ma in questo caso da imputare alla dimenticanza dell’autore).
Ulteriori criteri specificati a p. XCI dell’Introduzione sono i seguenti:
- Le didascalie usate all’interno di una fase sono riferite alla parola che precede immediatamente; se la porzione di testo è ampia, l’attacco è segnato da una mezza parentesi quadra (⎡) e progressivamente, per porzioni sempre più ampie che includono già l’impiego della mezza parentesi, da un asterisco (*) e successivamente da una losanga (♦), che verranno in questo caso ripetute, per evitare ambiguità, all’interno della didascalia relativa.
- Il ricorso a corpi tipografici diversi ha la funzione di evidenziare l’unità della lezione ultima di una fase, rispetto agli incidenti interni.
- Il segno di cassatura (> <) viene usato per cancellature in linea o comunque per lezioni di estensione limitata. La parentesi ad angolo (< >) segna le integrazioni dell’editore; la doppia parentesi quadra [ ] indica una lacuna nel testo o una lezione avviata, ma non conclusa dall’autore; la barra verticale ( / ) indica gli “a capo” dell’autografo.
- Le parole risultate indecifrabili vengono indicate con terne di puntini tra parentesi quadra ([…]); qualora la porzione illeggibile sia di tre o più parole, si impiegano tre terne di punti [… … …].
- Si sono inoltre usate le seguenti didascalie, che, salvo diversa indicazione, si intendono sempre riferite alla parola o alla porzione di testo che precede: agg. interl. = aggiunta interlineare (se l’aggiunta presenta varianti interne, queste sono fornite dopo il due punti che segue la didascalia); cass. e riscr. = cassato e riscritto di seguito; spscr. a = soprascritto a; spscr. = soprascritto (in questo caso riferito alla parola che segue l’abbreviazione); prima = variante in linea; su = ricalcato su; segue = riferito al testo che segue (cioè alla parola implicata in variante, segue…); err. = erroneamente; non corr. = non corretto (per interventi non completati).
Per gli apparati dei testi riportati in Appendice valgono gli stessi criteri, fatta eccezione per l’abbozzo M5 che presenta 2 fasce di apparato: la prima riporta l’apparato genetico, la seconda quello evolutivo. Qualora una delle due fasce non fosse presente, si segnala la mancanza con un filetto tipografico.
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Nella nota a piè di pagina nella pagina precedente l’Introduzione si legge: «la presente edizione riprende, completamente rivista e aggiornata nei testi, negli apparati e nell’introduzione, quella pubblicata in occasione del “Premio Raffaele Mattioli”, dalla casa editrice Il Polifilo di Milano nel 1995, per conto della Banca Commerciale Italiana (oggi in Banca Intesa San Paolo)».
Nella sezione “L’edizione Treves 1881”, contenuta nell’Introduzione, sono specificati alcuni aspetti legati alla princeps, tra cui si leggono le principali differenze che presenta l’edizione Treves del 1907: normalizzazione del sistema interpuntivo; correzione di molti degli evidenti refusi tipografici presenti nella prima edizione e introduzione di nuovi refusi; modifiche relative ai troncamenti delle finali; tendenza in più casi a uniformare le frequenti oscillazioni o a preferire forme più comuni. Tali interventi sono di natura tale da non permettere l’esclusione di un intervento correttorio dell’autore, ma non se ne può nemmeno riconoscere con certezza la presenza, visto che possono essere giustificati semplicemente come nuovi refusi introdotti durante la ricomposizione tipografica. Del resto, l’unico accenno sul possibile coinvolgimento dell’autore si trova in una lettera di Emilio Treves del 9 gennaio 1907.
Nella sezione intitolata “Dal bozzetto Padron ‘Ntoni ai Malavoglia” sono riportate le fasi di gestazione del bozzetto Padron ‘Ntoni, a partire dal primo accenno a un progetto che può essere assimilato alla storia dei Malavoglia (riscontrabile in una lettera di Verga alla famiglia, risalente al febbraio 1874). Si dà qui una sintesi schematica di tale processo di gestazione.
- Le più antiche testimonianze del bozzetto intitolato Padron ‘Ntoni si riscontrano in due frammenti cui si è conferito la dignità di abbozzi (M1 e M2). È la datazione relativamente sicura dell’abbozzo M3 (febbraio 1976) a delimitare l’arco di tempo in cui collocare M1 e M2 (tra dicembre 1874 e gli ultimi mesi del 1875).
- Nell’abbozzo M3 le proporzioni assunte dal testo tendono a fuoriuscire dalla misura del bozzetto. Proprio per la sua lunghezza, il testo è rifiutato dalla rivista fiorentina “Rassegna settimanale di Scienze, Lettere e Arti”.
- Nel 1978 avviene una svolta decisiva per l’evoluzione del bozzetto: Verga avvia una nuova redazione del testo, pensando in un primo momento di rifare ex novo la parte iniziale di M3, usando per il resto le rimanenti carte di M3 (tale progetto non ha, in realtà, seguito). Questa fase è documentata dall’abbozzo M4 che, diversamente da M3, presenta una scansione tipica della forma romanzo. Nelle carte iniziali di M4 si distingue una fitta serie di interventi in inchiostro diverso, che costituiscono un ulteriore rifacimento dell’abbozzo (M4 bis).
- Va considerato che la stesura della novella Fantasticheria (in cui è offerto uno spaccato del mondo e dei personaggi di Trezza, pubblicata nel 1879 sul “Fanfulla della domenica”), avviene nel febbraio 1978, andando dunque ad affiancare l’elaborazione di Padron ‘Ntoni in un momento cruciale della sua evoluzione, cioè quando il progetto viene rifondato su nuove basi.
- Verga dovette rendersi conto che la sovrapposizione della fase M4 bis alle pagine già intricate di M4 non rendeva possibile dare seguito alla nuova stesura, motivo per cui allestì un nuovo testo (abbozzo M5) pensando di recuperare direttamente le carte di M3. Tuttavia, giunto alla carta 73, Verga riprese il testo dall’inizio, con una serie di interventi che configurano una vera e propria seconda redazione. Un appunto, datato 25 marzo 1880, che fissa il programma di lavoro dell’autore, consente di inscrivere M4, M4 bis e M5 nell’arco di tempo che va da maggio 1978 alla prima metà di marzo 1980.
- M6 rielabora alcune sequenze di M5 e anticipa alcune parti del manoscritto ultimo A.
- Gli abbozzi M7 e M8 recano, invece, due varianti alternative dell’avvio (finora presente solo in M5). L’apertura del romanzo con la soluzione M7 modificava quella che doveva essere presente in M5 (molto vicina alla scelta che sarà poi definitiva). Le carte di M7 (divise in M7a, M7b, M7c, M7d) precedono immediatamente la stesura (il cui avvio è stabilito alla metà di marzo 1880) del testo dell’autografo A. La configurazione dell’avvio sembrerebbe aver trovato un suo assestamento definitivo, ma Verga mette contemporaneamente in cantiere una nuova versione proprio usando il verso delle carte di M7.
- Con M8 l’apertura del romanzo viene ulteriormente e profondamente modificata. Tale tentativo è poi superato senza ripensamenti.
- Il frammento M9 è costituito da carte che in origine facevano parte del manoscritto A, poi espunte in conseguenza del nuovo assetto che il testo assume. L’abbozzo comprende tre gruppi di carte: M9a, M9b, M9c.
Il rapporto stretto che M9 intrattiene con l’autografo A può essere così schematizzato:
cc. 1-11 (poi 43-53) di A + M9a + M9b + cc. 27-30 (poi 56-58) di A + M9c.
Questa è la successione delle carte che precede l’intervento dell’autore. Il testo si apre con le cc. 1-11 (episodio della tempesta e del naufragio della Provvidenza), cui fa seguito il capitolo II (M9a e M9b e cc. 27-30), che recupera gli antefatti degli eventi narrati nel capitolo iniziale, col negozio dei lupini, la presentazione della famiglia e la partenza di ‘Ntoni per il servizio militare. A carta 31 (M9c) compare l’indicazione di capitolo III.
Verga interviene su questa costruzione ripristinando una configurazione testuale già sperimentata nell’abbozzo M5: sulla base del gruppo di carte di M9b, stende i due capitoli iniziali, di conseguenza le precedenti cc. 1-11 diventano le cc. 43-53; la carta di M9a riceve una nuova numerazione (12 → 54), in sostituzione poi delle carte di M9b, compare una c. 55, e le precedenti cc. 27-30 (a esclusione di c. 28) assumono la nuova numerazione 56-58; successivamente sulla base del testo delle cc. 31-35 (cioè M9c) Verga stende le cc. 59-62 dell’autografo ultimo.
Nella sezione “La redazione ultima” si osserva che il manoscritto autografo A reca l’unica redazione completa del romanzo. Viene fornita una descrizione dell’autografo e dei materiali annessi, conservati nel Fondo Verga. L’appunto contenente il programma di lavoro consente di circoscrivere i tempi della stesura del testo base nei mesi che vanno dalla metà di marzo al 23 giugno 1880. Dopo la consegna formale all’editore (avvenuta il 1° luglio 1880), il manoscritto rimase nelle mani di Verga e da quel momento iniziò una revisione che si sarebbe protratta fino al 9 agosto, quando venne inviata all’editore la prima parte del romanzo. Ma nelle carte rimaste in mano all’autore le correzioni non si arrestarono. Punto finale della vicenda evolutiva del romanzo è la correzione delle bozze di stampa (novembre 1880), di cui oggi non disponiamo ma che possiamo ricostruire per differenza.
Per quanto riguarda la prefazione, nelle carte che precedono il manoscritto definitivo ci sono due versioni: P1, datata 19 gennaio, e P2, datata 22 gennaio 1881. Verga inviò entrambe le redazioni all’editore, chiedendo un consiglio. La preferenza di Treves andò a P2, tuttavia l’autore non accettò passivamente il suggerimento e ripristinò P1, accogliendo la versione di P2 per quelle parti che i due testi avevano in comune.
6.
• fonti archivistiche consultate dal curatore*
Fondo Verga, presso la casa editrice Mondadori (Fondo Mondadori – FM)
Fondo Verga (FV), presso la Biblioteca Universitaria di Catania
• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*
Casa editrice Mondadori
Biblioteca Universitaria di Catania
7.
• tipo di apparato/i*:
Genetico, orizzontale, costituito dalle varianti del solo manoscritto ultimo A.
A p. XC dell’Introduzione si osserva che risulta impossibile estendere la collazione a tutti gli abbozzi che recano le precedenti stesure, anche a quelli che con la redazione ultima presentano le maggiori affinità. Questo si deve al fatto che sono presenti divergenze di impianto narrativo tali che la loro assunzione in apparato avrebbe come conseguenza l’accostamento di sequenze simili solo in apparenza, perché in realtà inserite in compagini narrative del tutto diverse.
Si legge, inoltre, che «l’apparato della prefazione definitiva al romanzo si fonda sulla prefazione datata 19 gennaio 1881 (P1), su quella datata 22 gennaio (P2) solo per le parti che questa ha in comune con la prima, infine su quella comparsa nell’“Illustrazione italiana” il 6 febbraio 1881 (R)».
A p. XCI è specificato che l’abbozzo M5 presenta 2 fasce di apparato: la prima riporta l’apparato genetico, la seconda quello evolutivo.
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina
8.
• presenza di note / commento al testo*: No
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
Introduzione
- “L’edizione Treves 1881”: sono descritti i primi testimoni noti dell’opera, la prima edizione Treves 1881 e le successive ristampe, l’edizione Treves 1907 (non una semplice ristampa ma una nuova edizione per la quale il testo è stato interamente ricomposto e rispetto al quale sono descritte le modifiche con la princeps). Si fa riferimento, infine, al processo, avviato dall’edizione del 1907, di progressivo distacco dal testo della princeps per mezzo di operazioni di restauro da parte di editori che hanno corretto ben più del dovuto.
- “Dal bozzetto Padron ‘Ntoni ai Malavoglia”: si descrivono le fasi di gestazione del bozzetto Padron ‘Ntoni, elencando e descrivendo tutti gli abbozzi da M1 fino a M9.
- “La redazione ultima”: si descrive il manoscritto autografo A e il suo invio in casa editrice; una seconda parte è dedicata alle prefazioni; una terza e ultima parte riguarda gli appunti di lavoro.
- “Criteri di edizione”: si descrivono i criteri di edizione, spiegando quale sia il testo adottato per l’edizione critica e quali criteri si sono seguiti nel riprodurlo fedelmente; in seguito, sono descritti gli apparati che corredano il testo e la prefazione, e i criteri in vigore per la lettura degli apparati.
Appendici
- Appendice I. Prefazione rifiutata. Appunti di lavoro
Include le seguenti appendici:
- “Appendice I a. Prefazione rifiutata”: si tratta di P2.
- “Appendice I b. I Malavoglia. Svolgimento dell’azione”: contiene appunti preparatori, la sua stesura sembra essere prossima alla versione ultima del romanzo, anche se non completamente coincidente.
- “Appendice I c. Fondamento dei caratteri locali pei Malavoglia”: il testo è costituito da due appunti dal titolo “Fondamento dei caratteri locali pei Malavoglia” e “Per l’Uomo di lusso”.
- “Appendice I d. I Malavoglia. Personaggi, carattere, fisico, e principali azioni”: di ogni personaggio del romanzo si dà un breve ritratto e si presentano in sintesi le principali vicende che lo vedono coinvolto.
- “Appendice I e. 1°. Padron ‘Ntoni. Note e richiami per coordinare il manoscritto”: sono prospettate una serie di soluzioni alternative per definire i ruoli dei personaggi di Mena e Lia.
- “Appendice I f. Proverbi”: si tratta di un lungo elenco di 293 proverbi.
- Appendice II. Abbozzi
- Comprende gli abbozzi M1, M2, M3, M4, M4 bis, M5, M6, M7 a, M7 b, M7 c, M7 d, M8, M9 a, M9 b, M9 c.
- “Frammento f”: si riproducono due carte la cui lezione è ripresa in parte nelle cc. 220-222 della redazione finale.
- Appendice III. Frammenti vari
- “Frammento a”: il testo continua c. 3 di M7b; nel verso si legge c. 18 dell’abbozzo M8.
- “Frammento b”: la carta si riconnette con c. 13 di M9b; nel verso si legge la c. 20 di M8.
- “Frammento c”: il testo si legge nel verso di cc. 1-2 di M8.
- “Frammento d”: si legge nella sezione “Carte da intercalare”, nel verso di c. 21 di M8.
- “Frammento e”: si legge nella sezione “Carte da intercalare”.
