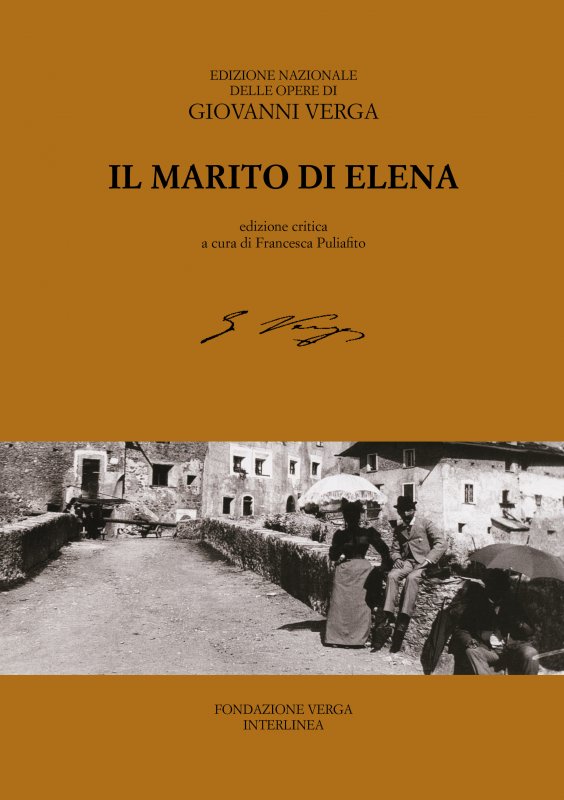Autore dell’opera*: Giovanni Verga (Catania, 1840 – Catania, 1922)
Titolo dell’opera*: Il marito di Elena
Ambito cronologico*: età contemporanea / XIX secolo
Ambito linguistico*: italiano
Tipologia di trasmissione dell’opera*:
- a stampa con edizioni di autore e non d’autore
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione:
- manoscritto autografo (ms)
- edizioni a stampa (Tr e stampe successive)
Titolo edizione*: Il marito di Elena
Curatore edizione*: Francesca Puliafito
Tipologia di edizione*: edizione critica
Sede di pubblicazione*: Novara, Interlinea
Anno di pubblicazione*: 2019
Lingua di pubblicazione: italiano
Dati bibliografici completi: Giovanni Verga, Il marito di Elena, edizione critica a cura di Francesca Puliafito, Novara, Interlinea, 2019, pp. I-LXX; 1- 254.
Autore recensione/scheda*: Giorgia Diviggiano
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
Informazioni aggiuntive: questa scheda è parte del lavoro richiesto agli studenti per l’esame di Filologia editoriale (a.a. 2024/25), di cui è titolare la prof.ssa Virna Brigatti.
1.
• prima edizione dell’opera*:
Giovanni Verga, Il marito di Elena : romanzo, Milano, Fratelli Treves, 1882 (Tr)
• successive edizioni vivente l’autore:
- Da Tr sono emesse altre otto ristampe da Treves, fino al 1923.
- Giovanni Verga, Il marito di Elena : romanzo, Firenze, R. Bemporad & figlio, 1921: l’edizione attesta una lezione sostanzialmente identica a Tr, con un’impaginazione meno ampia; alcuni refusi sono conservati, altri sono corretti e alcuni sono introdotti; emerge una capillare normalizzazione di elementi paragrafematici operata da parte del tipografo.
• edizioni postume:
- Giovanni Verga, Il marito di Elena : romanzo, Milano, A. Barion, 1924
- Giovanni Verga, Il marito di Elena : romanzo, Milano, Bietti, 1925
- Giovanni Verga, Il marito di Elena : romanzo, Milano, A. Mondadori, 1932
- Giovanni Verga, Eros ; Il marito di Elena : romanzi, A. Mondadori, 1946
- Giovanni Verga, Il marito di Elena, introduzione di Maurizio Vitta, cronologia e bibliografia di Carla Riccardi, Milano, Mondadori, 1980, Oscar Mondadori (e successive ristampe in Oscar classici)
- Giovanni Verga, Il marito di Elena ; Mastro-don Gesualdo (1888) ; Mastro-don Gesualdo (1889) ; Dal tuo al mio, a cura di Enrico Ghidetti, Firenze, Sansoni, 1983
- Giovanni Verga, Tutti i romanzi, le novelle e il teatro : I malavoglia ; Mastro-don Gesualdo ; Sulle lagune ; Una peccatrice ; Storia di una capinera ; Eva ; Tigre reale ; Eros ; Il marito di Elena ; Dal tuo al mio ; Tutte le novelle ; Tutto il teatro e gli inediti per il teatro e per il cinema, Roma, Newton Compton, 2011
- Giovanni Verga, Il marito di Elena, Enna, Euno Edizioni, 2015
- Giovanni Verga, Il marito di Elena, edizione critica a cura di Francesca Puliafito, Novara, Interlinea, 2019
- Giovanni Verga, Il marito di Elena, Pavia, Ibis, 2022
- Giovanni Verga, Il marito di Elena, Firenze, Edimedia, 2023
• edizione corrente e testo su cui si basa:
- Giovanni Verga, Il marito di Elena, introduzione di Maurizio Vitta, cronologia e bibliografia di Carla Riccardi, Milano, Mondadori, Oscar Mondadori, 1980 (e successive ristampe in Oscar classici)[1] . L’edizione si basa sul testo pubblicato nel 1882 (Tr).
• primi testimoni noti dell’opera*:
L’uscita della princeps tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo è preceduta dalla pubblicazione a puntate nelle appendici del quotidiano romano «Capitan Fracassa», dal 26 dicembre 1881 al 20 febbraio 1882 (Riv).
2.
• precedente edizione critica del testo* NO
• precedente edizione scientifica di riferimento* NO
3.
• testo dell’edizione critica in oggetto e ragioni della scelta ecdotica*
Nei Criteri di edizione è espressa la decisione di dare a testo «la princeps del romanzo, ossia l’edizione Treves stampata a Milano nel 1882» (Tr) (p. LXIII). Si tratta dell’unica lezione pubblicata dall’autore, tramandata sostanzialmente identica nelle successive edizioni.
4.
• criteri di edizione*
L’edizione critica di Francesca Puliafito propone il testo di Tr emendato dai refusi (nota 2, p. LXIII) e riprodotto «rispettandone le particolarità grafiche, senza uniformare l’accentazione alle norme tipografiche moderne e mantenendo quindi l’uso ottocentesco dell’accento grave anziché acuto». Il sistema interpuntivo è stato lasciato inalterato ed è stato seguito un criterio conservativo delle alternanze formali che si riscontrano nella lezione verghiana. Gli unici interventi sono segnalati nelle note 3, 4 e 5 da p. LXIII a LXVII.
I criteri di edizione, le abbreviazioni e i segni utilizzati sono descritti alle pp. LXIII – LXX; tali criteri sono applicati anche alla sezione di appendici che segue il testo.
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
L’introduzione è divisa in tre sezioni: Storia del testo (pp. XI-XXXV), Testimoni autografi e a stampa (pp. XXXVII-LXII) e Criteri di edizione (LXIII-LXX).
La prima di queste ricostruisce in modo puntuale ed esaustivo la composizione del romanzo, che «si identifica come un’opera di transizione, collocata, a livello tematico e stilistico, a metà tra la produzione giovanile degli anni ’70, da un lato, e I Malavoglia e il Mastro-don Gesualdo, dall’altro» (p. XXXV).
Il suo iter creativo, infatti, comincia durante il biennio 1878-1879, quando il «suo laboratorio è occupato da importanti progetti» come la stesura dei Malavoglia e delle novelle di Vita dei campi. Il romanzo è proposto per la prima volta all’editore Emilio Treves nel 9 gennaio 1879 ed appare come poco impegnativo, «di genere mondano piuttosto che sociale, dotato di quello stile leggero e ironico proprio della conversazione salottiera, dove la tragedia non si manifesta apertamente perché coperta da una vernice di buona compagnia». A questa altezza, il disegno diegetico delineato non coincide con quello definitivo (pp. XI-XII).
In realtà, nonostante le sue intenzioni originarie, il romanzo finisce per costituire uno scoglio per il suo autore: come emerge dalla ricostruzione della curatrice, dopo l’abbandono di un primo progetto e probabilmente occupato nel laboratorio di altri testi da lui considerati più fecondi e stimolanti, Il marito di Elena scompare dal carteggio con Treves fino all’aprile del 1881. A quest’ultima data risale una risposta preoccupata dell’editore che gli chiede di concentrarsi sul «Don Menelao e Don Gesualdo». Il progetto di terminare il romanzo viene rimandato più volte, tra l’impazienza dell’editore che attende il lavoro promesso e il ritardo di consegna dell’autore che nel frattempo incalza in nuovi progetti. Dal carteggio con Capuana emerge uno stato d’animo di repulsione nei confronti del romanzo, che lo disturba rispetto ad altri progetti a lui cari: «Detesto Il marito di Elena, ma troppo tardi» (p. XXXI).
Tale tormento terminerà con la pubblicazione in rivista tra il dicembre 1881 e il febbraio 1882 e infine con la stampa in volume nei primi mesi del 1882. Emerge quindi evidente come Il marito di Elena non nasca con una volontà di riscatto dall’insuccesso della pubblicazione dei Malavoglia e, anzi, sembri ostacolarne la composizione; «restava in definitiva un accordo preso con Treves al quale Verga non poteva venire meno», il cui risultato «è inesorabilmente incompiuto, un “aborto”, almeno dal punto di vista dell’autore» (pp. XXXIV-XXXV).
La descrizione dei testimoni autografi e a stampa permette di ripercorrere, di documento in documento, le diverse stesure e varianti dei capitoli del romanzo, mettendo a confronto il primo abbozzo diegetico con la sua stesura definitiva. Tra questi materiali troviamo:
- Manoscritto autografo (ms): il romanzo è tramandato integralmente da quest’unico documento autografo, esemplare inviato in tipografia per la stampa che presenta le indicazioni del proto e la stratificazione delle diverse stesure verghiane.
Si tratta quindi dell’antigrafo di Tr.
- Abbozzi e frammenti (appendici α e β): 21 carte autografe che testimoniano le fasi compositive precedenti la stesura definitiva.
- Appunti (appendice γ): carta non numerata che costituisce un promemoria per alcune modifiche da apportare al romanzo, per valorizzare il profilo caratteriale del protagonista e ristrutturare la suddivisione dei capitoli.
- Edizione in rivista (Riv): «Le varianti rispetto al testo non sono numerose, si distribuiscono omogeneamente nei capitoli del romanzo e nella quasi totalità dei casi toccano esclusivamente aspetti formali». Il romanzo esce in 40 puntate, con una frequenza di quasi una puntata al giorno: «è molto probabile che Verga non avesse ricevuto bozze di stampa e comunque non avesse avuto il tempo di revisionare con attenzione il testo che era pubblicato per la rivista. Difatti alcune lezioni di Riv che non coincidono con quelle di ms e di Tr sembrano nascere da un fraintendimento di lettura del manoscritto o da una banalizzazione della lezione da parte del tipografo». Nei Criteri di edizione si rende conto comunque delle varianti attestate in Riv, laddove opportuno.
- Tr e stampe successive.
6.
• fonti archivistiche consultate dal curatore*
- Fondo Giovanni Verga presso Biblioteca Regionale Universitaria di Catania, segnatura 008.U.Ms.Verga.8, antica segnatura Ms.U.239.83 (ms)
- Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (AME) di Milano (appendici α, β e γ)
• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*
- Biblioteca Civica Leonardo Lagorio di Imperia (Tr): volume della prima edizione con dedica autografa nella pagina dell’occhietto: Ad Edmondo De Amicis / dal suo amico / Verga.
7.
• tipo di apparato/i*:
L’apparato è di tipo genetico orizzontale e «riporta le varianti del manoscritto autografo definitivo (ms)» (p. LXVI).
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina
8.
• presenza di note / commento al testo*: NO
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
Introduzione (pp. IX-LXX):
L’introduzione è divisa in tre sezioni, per le quali si rimanda ai punti 4 e 5: Storia del testo (pp. XI-XXXV), Testimoni autografi e a stampa (pp. XXXVII-LXII) e Criteri di edizione (LXIII-LXX).
Appendici (pp. 191-254):
«Nelle appendici, ordinate secondo il capitolo del romanzo al quale si riferiscono, si legge la trascrizione, corredata dal relativo apparato genetico, delle parziali stesure autografe risalenti a un momento compositivo precedente rispetto alla redazione definitiva. Gli abbozzi che si legano alla prima stesura del romanzo sono contrassegnati dalla lettera α, mentre tutti gli altri dalla lettera β (appendici α e β)».
«Nell’appendice γ, collocata in ultima posizione, sono trascritti gli appunti autografi della carta riprodotta nel ft. 753 del Microfilm IX» (pp. LXIX-LXX).
10.
• ulteriori eventuali considerazioni
L’edizione critica ha permesso di gettare luce sulla genesi del romanzo, ritenuto fino a questo momento una scrittura successiva alla pubblicazione senza successo de I Malavoglia. Nell’edizione Oscar Mondadori del 1980 questo elemento compare più volte: nell’introduzione («Scritto subito dopo la pubblicazione dei Malavoglia (1881), […]»[2]; «Ma due mesi dopo lo scrittore confessava apertamente il “fiasco completo” del suo romanzo, e subito metteva mano al Marito di Elena, del resto incoraggiato dallo stesso Treves. Il lavoro non fu facile […], ma verso la fine del 1881 il romanzo era già pronto e nel 1882 veniva pubblicato»[3]) e persino nella quarta di copertina («Scritto nel 1882, subito dopo I Malavoglia, questo romanzo rappresenta il ritorno di Verga alla maniera pre-verista, a un tipo di narrativa più tradizionale, a sfondo psicologico»)[4]. Lo studio sui materiali d’archivio e sulla corrispondenza[5] ha invece permesso di delineare una parabola creativa che comincia nel biennio 1878-1879, quando il laboratorio verghiano è già occupato dalla stesura dei Malavoglia e delle novelle di Vita dei campi, e che non nasce quindi da una volontà di riscatto rispetto all’insuccesso del primo volume del Ciclo dei Vinti. «Verga aveva iniziato a lavorare al romanzo prima del biennio 1879-1880, e aveva proposto all’editore Treves un’opera che verosimilmente era già stata abbozzata per più della sua metà, benché al momento dell’annuncio non era ancora definita la direzione che avrebbe potuto prendere la sua scrittura». Il romanzo è quindi correttamente ricollocato tra la produzione giovanile degli anni ’70 da un lato e I Malavoglia e il Mastro-don Gesualdo dall’altro (pp. XXXIV-XXXV).
[1] Nonostante le edizioni successive pubblicate presso altre case editrici, si è ritenuto opportuno segnalare questo volume pubblicato nella collana Oscar Mondadori che, pur essendo tascabile, rimane l’edizione di lettura più autorevole.
[2] Giovanni Verga, Il marito di Elena, introduzione di Maurizio Vitta, cronologia e bibliografia di Carla Riccardi, Milano, Mondadori, 1998, Oscar Mondadori, p. 5.
[3] Ibid., p. 6.
[4] Ibid., quarta di copertina.
[5] Gino Raya, Verga e i Treves, Herder Editore, Roma, 1986; Carteggio Verga-Capuana, a cura di Gino Raya, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1984; Carteggio Verga-Rod, introduzione e note di Giorgio Longo, Fondazione Verga, Catania, 2004.