Autore dell’opera*: anonimo
Nomi alternativi con cui l’autore è noto: Amico dell’Ottimo
Titolo dell’opera*: Chiose sopra la ‘Comedia’
Altri titoli con cui l’opera è nota:
Ambito cronologico*: medioevo / XIV secolo
Ambito linguistico*: italiano (volgare fiorentino trecentesco)
Tipologia di trasmissione dell’opera*: manoscritta di estensione limitata
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione: manoscritti apografi
Titolo edizione*: Chiose sopra la ‘Comedia’
Curatore edizione*: Ciro Perna
Tipologia di edizione*: edizione critica su manoscritto preferenziale
Sede di pubblicazione*: Roma, Salerno Editrice (collana «Edizione Nazionale dei Commenti danteschi», 6)
Anno di pubblicazione*: 2018
Lingua di pubblicazione: italiano
Dati bibliografici completi: Amico dell’Ottimo, Chiose sopra la ‘Comedia’, a cura di Ciro Perna, Roma, Salerno Editrice, 2018, collana «Edizione Nazionale dei Commenti danteschi», 6 (t. IV), ISBN 978-88-6973-229-4, pp. CXIII-820.
Autore recensione/scheda*: Giuseppe Andrea Liberti
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
Informazioni aggiuntive: l’edizione costituisce il quarto tomo dell’edizione dell’Ottimo Commento alla Commedia, a cura di Giovanni Battista Boccardo, Massimiliano Corrado e Vittorio Celotto.
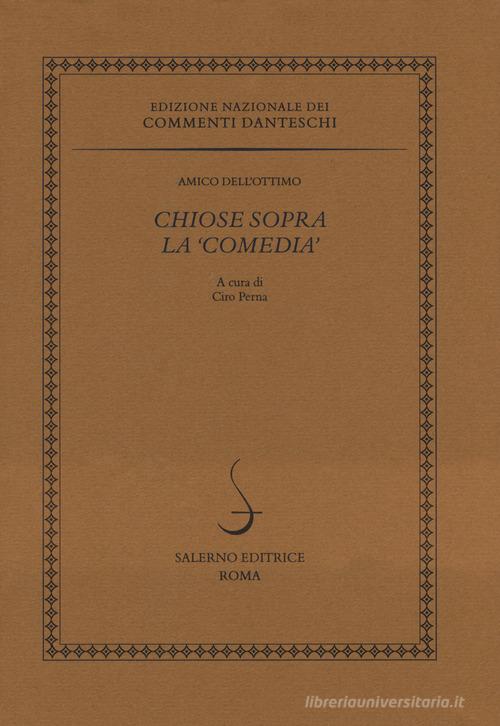
1.
• primi testimoni noti dell’opera*
Il testimone più antico dell’opera è il manoscritto M676 conservato presso la Morgan Library and Museum di New York (siglato NY), databile intorno al quarto o quinto decennio del XIV secolo.
2.
• precedente edizione critica del testo*
Nel 2008 Claudia Di Fonzo ha procurato un’edizione critica delle chiose all’Inferno, sebbene ritenendole ancora una “terza redazione” dell’Ottimo Commento: L’ultima forma dell’Ottimo commento. Chiose sopra la Comedia di Dante Alleghieri fiorentino tracte da diversi ghiosatori. Inferno (Ravenna, Longo, 2008). Sull’edizione, può essere utile rimandare ai rilievi mossi da Ciro Perna in una recensione comparsa nella «Rivista di studi danteschi», IX 2009, 1, pp. 171-176.
• precedente edizione scientifica di riferimento*
Vd. sopra. L’edizione Di Fonzo è stata inoltre digitalizzata, sotto la supervisione di Robert Hollander, nell’ambito del Dartmouth Dante Project.
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
Il riconoscimento dell’originalità dell’operazione esegetica ora attribuita a un misterioso ma non meno autorevole Amico dell’Ottimo rappresenta un deciso passo in avanti nelle ricerche tanto sui primi lettori di Dante quanto sulla tradizione del più noto Ottimo Commento alla Commedia, di cui le Chiose sopra la ‘Comedia’ sono state per lungo tempo ritenute una semplice “terza redazione”. Era stato Giuseppe Vandelli a proporre questa interpretazione degli apparati di note tràditi da alcuni manoscritti ricondotti all’Ottimo da Luigi Rocca, e ancora pochi anni fa Claudia Di Fonzo poteva licenziare un’edizione dell’Ultima forma dell’Ottimo commento (vd. il punto 2 della presente scheda).
Perna dimostra invece, soprattutto attraverso il confronto di luoghi testuali affini, che le Chiose rappresentano una produzione del tutto autonoma – benché indubbiamente assai influenzatane – dall’Ottimo Commento. Siamo probabilmente di fronte a un sodale dell’Ottimo, facente parte del suo stesso milieu culturale; un personaggio di cui troppo poco sappiamo, al punto da ricorrere a una formula à la Contini per identificarlo, eppure da valorizzare nella sua indipendenza di lettore e interprete dell’opera dantesca.
4.
• criteri di edizione*
La Nota al testo si apre con la descrizione dettagliata dei quattro testimoni su cui si basa la recensio, per poi procedere con collazioni serrate finalizzate a stabilire i rapporti tra i manoscritti. Perna giunge alla conclusione che due dei testimoni siano descripti di BA, e pertanto non utili alla ricostruzione del testo.
Il testo base dell’edizione è quello del ms. M676 della Morgan Library and Museum, siglato NY. La scelta si basa sul prestigio del copista, Andrea Lancia (egli stesso autore di un commento alla Commedia), e su «una incidenza di perturbazioni testuali certamente minore rispetto al suo collaterale» (p. CXI). Ciò detto, Perna ricorre al Barberiniano Latino 4103, siglato BA, nei casi di lezioni inesatte o lacune; lì dove entrambi i testimoni presentino identica omissione, l’editore tenta di emendare ricorrendo alle fonti oppure ope ingenii.
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Il primo paragrafo dell’Introduzione opera un confronto serrato tra alcuni luoghi testuali per dimostrare come l’autore dell’Ottimo Commento non coincida con quello delle Chiose; inoltre, il terzo paragrafo cerca di individuare a quale ramo della tradizione dei commenti alle diverse cantiche dell’Ottimo possa avere attinto l’Amico nella compilazione delle sue note esegetiche.
La Nota al testo offre invece un ampio numero di raffronti e collazioni tra i testimoni, al fine di chiarirne i rapporti e poter approdare a uno stemma codicum, poi presentato a p. CXI.
6.
• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*
L’editore ha adoperato manoscritti conservati presso le seguenti biblioteche: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana; New York, Morgan Library and Museum; Parigi, Bibliothèque Nationale de France.
7.
• tipo di apparato/i*: varianti alternative.
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina, in prima fascia d’apparato. L’edizione è inoltre corredata da due appendici (pp. 725-783): nella prima, si forniscono le chiose seriori del ms. Barberiniano Latino 4103 (BA); nella seconda, si dà conto di chiose singolari e postille del copista del ms. M676 della Morgan Library and Museum (NY), Andrea Lancia, e delle note relative al progetto illustrativo dello stesso manoscritto.
8.
• presenza di note / commento al testo*: Sì.
• tipo di note / commento*
Le note individuano le fonti dell’Amico dell’Ottimo e i rapporti intertestuali che le sue Chiose intrattiene con altri capitoli dell’esegesi dantesca; in questo caso, l’editore ha inteso confrontare il testo non solo con l’esegesi pregressa, ma anche con quella seriore, «per meglio contestualizzarne le scelte interpretative» (p. CXIII).
• posizione delle note / commento*: a piè di pagina, in seconda fascia d’apparato.
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
L’Introduzione (pp. IX-LXXVI) si apre con un necessario approfondimento sugli elementi che suggeriscono di distinguere l’autore delle Chiose sopra la ‘Comedia’ da quello dell’Ottimo Commento. I paragrafi successivi sono dedicati alla disamina delle fonti compulsate dall’Amico, a cominciare da Dante stesso, delle cui opere, finanche di quelle meno scontate come la Monarchia o il Convivio, il commentatore mostra una conoscenza non cursoria. Particolare attenzione è dedicata ai rapporti che il commento intrattiene con l’Ottimo e il Lana, che vengono sovente riscritti in un’ottica di snellimento del materiale su cui fondare l’esegesi (si veda anche il punto 5 della presente scheda). Si procede poi a un’indagine dei modi di recupero di alcuni capitoli fondamentali dell’antica esegesi, come Jacopo Alighieri o il volgarizzamento A di Graziolo Bambaglioli. Condivisibile è la cautela con cui Perna tratta possibili riprese da commenti come quello dell’Anonimo Latino o le Expositiones di Guido da Pisa; a proposito di quest’ultimo, per esempio, al di là di «consonanze che possono facilmente configurarsi come poligenesi interpretative […], si riscontrano solo minimi punti di convergenza, che non consentono di confermare, ma neppure di smentire, un rapporto diretto tra le Chiose sopra la ‘Comedia’ e il commento del carmelitano» (p. LXVIII). Non mancano osservazioni sulla conoscenza, da parte dell’Amico, delle fonti bibliche e classiche, tutt’altro che banale o grossolana. Come scrive Perna, «è evidente che ci troviamo di fronte ad un uomo di cultura, ad un lettore attento e, perché no, appassionato dell’opera dantesca, ad un sofisticato esegeta»; e tuttavia quella dello studioso napoletano si configura più come la premessa di un lavoro da compiere che il risultato intoccabile di una ricerca, visto che «tante domande restano ancora senza risposta, tanti dubbi irrisolti, a partire dall’identità sino ad arrivare alle modalità di accesso ai volumi sopra menzionati: saranno questi, verosimilmente, i nuovi percorsi di indagine che potranno essere intrapresi a partire da questa edizione critica» (p. LXXIII).
Il sesto e ultimo paragrafo ipotizza una conoscenza delle Chiose da parte di Benvenuto da Imola, vale a dire uno dei maggiori commentatori tardo-trecenteschi. Ben al di là del Lancia, dunque, questo apparato di note ha un successo non secondario nell’esegesi del XIV secolo, se Perna può reperire almeno quattro luoghi nei quali (pur ammettendo una sempre possibile poligenesi per qualche caso) Benvenuto sembra riprendere proprio l’Amico dell’Ottimo.
La Bibliografia occupa le pp. LXXVII-LXXXV. È infine presente un Indice degli antroponimi e dei toponimi (pp. 787-816) a cura di Arianna Starace.
