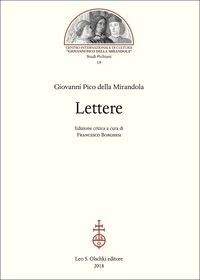Autore dell’opera*: Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)
Titolo dell’opera*: Lettere
Altri titoli con cui l’opera è nota: Epistole
Ambito cronologico*: età moderna / secolo XV
Ambito linguistico*: latino umanistico
Tipologia di trasmissione dell’opera*: manoscritta e stampa
Tipologia di testimoni su cui si basa l’edizione:
- stampa
- manoscritto / inedito / apografo
Titolo edizione*: Lettere
Curatore edizione*: Francesco Borghesi
Tipo edizione*: edizione critica
Sede di pubblicazione*: Firenze, Olschki
Anno di pubblicazione*: 2018
Lingua di pubblicazione: italiano
Dati bibliografici completi: Giovanni Pico della Mirandola, Lettere, edizione critica a cura di Francesco Borghesi, Firenze, Oschki, 2018.
Autore recensione/scheda*: Francesco Amendola
Tipologia di contributo*: schedaDati bibliografici della recensione/scheda*: inedita
1.
• prima edizione dell’opera*: vedi edizioni postume
• successive edizioni vivente l’autore: nessuna
• edizioni postume: Commentationes Joannis Pici Mirandulae in hoc volumine contentae: quibus anteponitur vita per Joannem Franciscum illustris principis Galeotti Pici filium conscripta, Heptaplus de opere sex dierum geneseos, Apologia tredecim quaestionum, Tractatus de ente et uno cum obiectionibus quibusdam et responsionibus, Oratio quaedam elegantissima, Epistolae plures, Deprecatoria ad Deum elegiaco carmine, Testimonia eius vitae et doctrinae, diligenter impressit Benedictus Hectoris Bononiensis, Boninae, anno salutis MCCCCLXXXXVI, die vero XX Martii.
La stampa postuma è stata curata dal nipote dell’autore, Giovan Francesco Pico della Mirandola. In questa edizione le lettere sono state ordinate secondo un preciso progetto editoriale che rispecchia la biografia dello zio tracciata da Giovan Francesco Pico nella Vita premessa agli Opera omnia.
• edizione corrente e testo su cui si basa: Giovanni Pico della Mirandola, Opere complete, a cura di Francesco Bausi, Roma-Torino, Lexis-Nino Aragno, 2000 (edizione informatica in CD-Rom)
Nella sua edizione Bausi raccoglie tutte le epistole conosciute e già edite di Giovanni Pico della Mirandola e quelle a lui destinate, suddividendole in due sezioni: una prima sezione contiene le lettere scritte da Giovanni Pico, organizzate secondo l’ordinamento della princeps postuma del 1496; la seconda sezione comprende le lettere inviate a Pico, ordinate alfabeticamente secondo i cognomi dei mittenti.
2.
• precedente edizione critica del testo*: NO, non esiste una precedente ed. critica
• precedente edizione scientifica di riferimento*: Giovanni Pico della Mirandola, Opere complete, a cura di Francesco Bausi, Roma-Torino, Lexis-Nino Aragno, 2000 (edizione informatica in CD-Rom)
La pubblicazione curata da Bausi non può considerarsi una vera e propria edizione critica, poiché non presenta alcun tipo di apparato. Bausi tuttavia sottolinea come la particolare natura dei testi abbia richiesto di procedere a una loro trascrizione, condotta secondo criteri scientifici.
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
Per quanto riguarda le lettere pubblicate nella Parte II (pp. 81-150), la redazione del testo si basa sull’editio princeps delle opere pichiane, pubblicata postuma a Bologna nel 1496 per le cure del nipote dell’autore, Giovan Francesco Pico della Mirandola. L’edizione bolognese tramanda infatti una silloge non originale, obbediente a un preciso progetto del curatore. Nell’intento di conservare l’organicità dell’epistolario tramandato dall’edizione postuma, Francesco Borghesi è partito dalla stampa del 1496, spesso portatrice di un testo scorretto e arbitrariamente modificato, mettendola a confronto con il manoscritto Capponi 235 della Biblioteca Apostolica Vaticana, da lui considerato come l’unico altro testimone di rilievo ai fini della constitutio textus: dopo aver effettuato una collazione del testo della princeps con quello del ms. Capponi 235, Borghesi ha messo a testo la princeps segnalando in apparato le lezioni divergenti di cui è portatore il ms. vaticano. Nel caso di aggiunte cospicue o significative del codice Capponi 235 rispetto alla princeps, per comodità del lettore, l’editore ha deciso integrare la lezione della princeps con quella del manoscritto.
Invece, le Lettere extravagantes di Giovanni Pico stampate nella Parte III dell’edizione critica (pp. 153-171), corrispondenti alle lettere dell’autore non tramandate nella princeps, sono state tutte pubblicate da manoscritti (pp. 61-67): il testo delle epistole già edite in altra sede è stato ricollazionato con quello dei relativi manoscritti e adeguato ai criteri di trascrizione adottati per le lettere della Parte II.
L’edizione critica delle Lettere di Giovanni Pico della Mirandola, curata da Borghesi, restituisce quindi il testo delle missive pichiane in una veste corretta e attentamente sorvegliata dal punto di vista filologico, rendendo accessibili in un unico volume dei documenti fondamentali non solo per comprendere la complessa personalità dell’autore e il suo percorso biografico, ma anche per approfondire la storia religiosa e filosofica dell’Umanesimo.
4.
• criteri di edizione*
Per la scelta del testo base vedi punto 3; per i criteri di trascrizione: «non si sono conservate le oscillazioni ortografiche presenti nei testimoni, ma ci si è attenuti all’uso classico e quindi sono stati ripristinati i dittonghi, mentre le maiuscole sono impiegate secondo l’uso moderno. Tale uso è stato, quindi, ristabilito nel complesso del testo critico, che di conseguenza risulta graficamente normalizzato» (p. 53).
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
– Nella Premessa (p. IX) è sviluppata una riflessione sui nuovi strumenti informatici che la filologia ha a disposizione, auspicando un connubio tra metodologie della filologia testuale, genetic criticism e risorse digitali.
– Parte I, cap. 1 (pp. 3-10) sono ricapitolate le principali questioni legate alla pubblicazione degli epistolari umanistici, e sono discussi tra gli altri i noti contributi di Alberto Perosa e Mario Marti.
– Parte I, cap. 6 (pp. 50-51) è sviluppata un’importante riflessione sui curatori editoriali di opere postume e sul problema della valutazione dell’ultima volontà dell’autore in relazione a quella del curatore della stampa.
6.
• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*
Più di venticinque manoscritti (pp. 61-67) conservati presso le seguenti sedi di biblioteche o archivi di Stato: Basilea, Universitätsbibliothek; Bologna, Biblioteca Universitaria; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana; Erlangen, Universitätsbibliothek; Firenze, Archivio di Stato, Biblioteca Medicea Laurenziana, Biblioteca Nazionale Centrale e Biblioteca Riccardiana; Mantova, Archivio di Stato; Modena, Biblioteca Estense; Parigi, BNF; Perugia, Archivio di Stato, Biblioteca Comunale Augusta; Torino, Biblioteca Nazionale; Vienna, Österreichische Nationalbibliothek.
7.
• tipo di apparato*: varianti alternative
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina
8.
• presenza di note*: Sì
• tipo di note*: le note, molto sintetiche, mirano principalmente a riconoscere i passi degli autori classici citati nelle missive (carattere intertestuale o ricerca delle fonti).
• posizione delle note*: a piè di pagina
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
Il volume curato da Borghesi è suddiviso in tre parti. A un’iniziale Premessa (pp. VII-XI), segue la Parte I (pp. 3-57), che consiste in uno studio critico-filologico articolato in sei capitoli: il primo (pp. 3-10) affronta in via preliminare le questioni legate alla pubblicazione degli epistolari umanistici; il secondo (pp. 11-19) passa in rassegna la bibliografia sulle epistole pichiane, suddividendola in contributi che riguardano propriamente la tradizione testuale delle lettere e in studi di carattere generale sulla figura dell’autore; il terzo capitolo (pp. 21-30) è incentrato sull’editio princeps dell’epistolario, ritenuta un testimone fondamentale per la constitutio textus; il quarto (pp. 33-44), scritto da Maria Agata Pincelli, è uno studio descrittivo del ms. Capponiano 235 della Biblioteca Apostolica Vaticana, che rappresenta il secondo testimone chiave su cui si basa l’edizione critica; infine, chiudono questa prima parte un capitolo che riesamina lo status quaestionis (pp. 45-48) e la Nota al testo (pp. 49-57) corredata da una tabella con le principali differenze testuali tra il ms. Capponiano 235 e la princeps.
A questa prima parte seguono due Appendici, intitolate rispettivamente: Localizzazione dei manoscritti contenenti lettere di Giovanni Pico (pp. 61-67) e Diffusione della editio princeps e della successiva contraffazione lionese (pp. 69-78). Nella Parte II (pp. 81-150) si pubblica il testo critico delle lettere di Giovanni Pico comprese nell’editio princeps. Nella Parte III (pp. 153-172), invece, sono stampate le Lettere extravagantes di Giovanni Pico. Completano il volume la Bibliografia (pp. 173-180), l’Indice dei nomi (pp. 181-184) e l’Indice dei corrispondenti (p. 185).