Autore dell’opera*: Niccolò Povero
Titolo dell’opera*: Le mattane
Ambito cronologico*: XIV secolo
Ambito linguistico*: italiano (fiorentino tre-quattrocentesco)
Tipo trasmissione dell’opera*: manoscritta e a stampa
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione*: manoscritti miscellanei
Titolo edizione*: Le mattane
Curatore edizione*: Vittorio Celotto
Tipo edizione*: edizione critica con commento
Sede di pubblicazione*: Roma, Salerno Editrice (collana «Testi e documenti di letteratura e di
lingua», XL)
Anno di pubblicazione*: 2018
Lingua di pubblicazione: italiano
Dati bibliografici completi*: Niccolò Povero, Le mattane, a cura di Vittorio Celotto, Roma, Salerno, 2018, collana «Testi e documenti di letteratura e di lingua», XL, ISBN 978-88-6973-245-4, pp. LXI-98.
Autore recensione/scheda*: Giuseppe Andrea Liberti
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
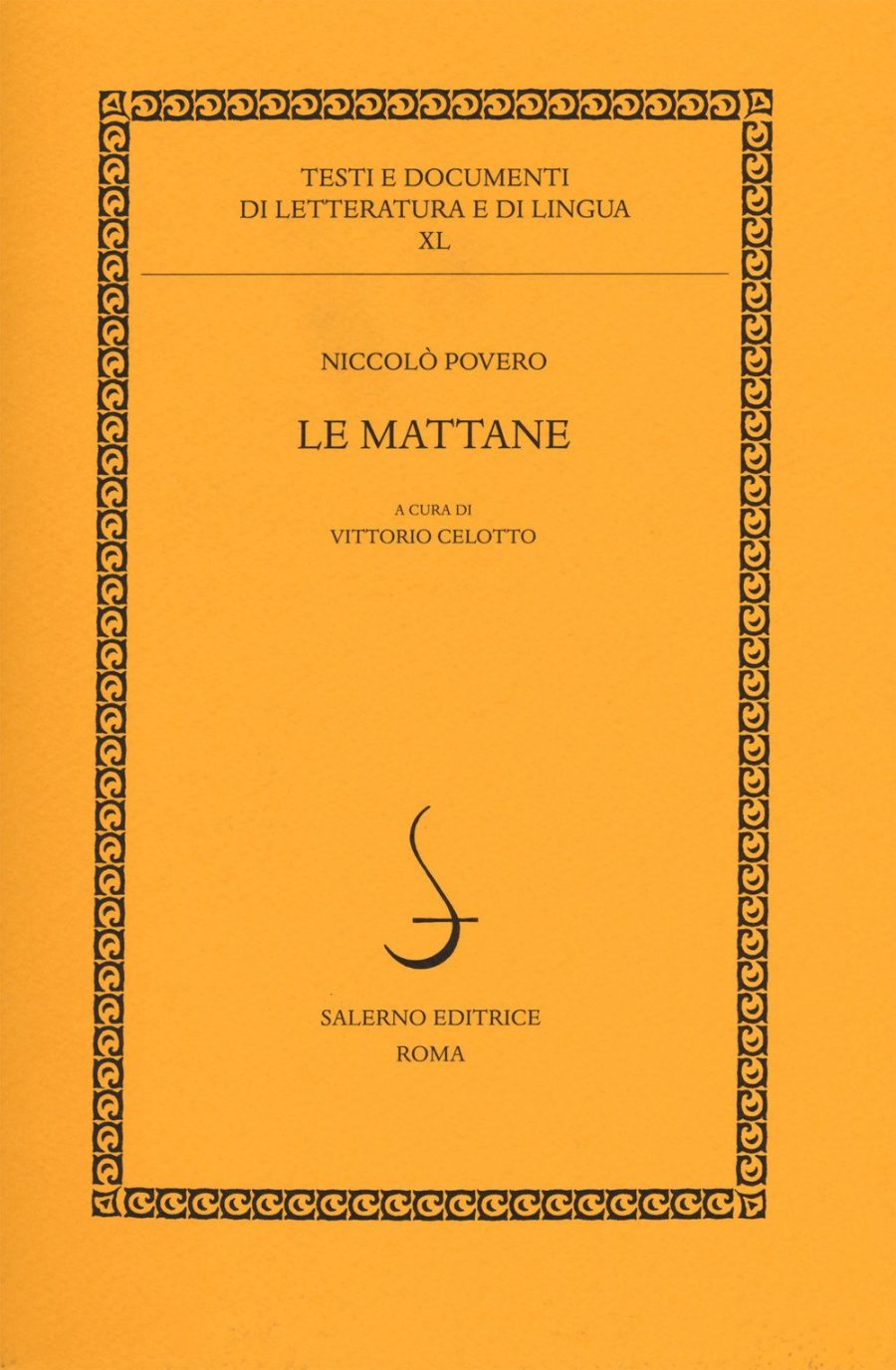
1.
• primi testimoni noti dell’opera*
I testimoni manoscritti più antichi delle mattane sono il Riccardiano 2873 (siglato R), datato 1432, e il Marucelliano C 155 (siglato M), databile tra il 1417 e il 1439.
2.
• precedente edizione critica del testo*
Un’edizione critica delle mattane, che ha costituito per molto tempo anche l’edizione scientifica di riferimento, è stata proposta da Ezio Levi nel suo articolo Le paneruzzole di Niccolò Povero. Contributo alla storia della poesia giullaresca del Medio Evo italiano, in «Studi medievali», III (1908), alle pp. 81-108.
• precedente edizione scientifica di riferimento*
Vd. sopra.
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
L’edizione di Vittorio Celotto si discosta da quella di Levi (della quale è pur riconosciuta l’importanza) anche in virtù dell’acquisizione di quattro nuovi testimoni che modificano inevitabilmente il quadro della tradizione e la constitutio del testo. In primo luogo, l’editore nota il grande tasso di rielaborazione a cui sono soggetti i due ternari, dovuto al basso ‘gradiente di autorialità’ di cui potevano godere componimenti votati al nonsense e al comico. La scoperta e verifica di errori significativi viene ancor più complicata dal fatto che, in una poesia di questo tipo, non è scontato indicare quale lezione possa essere indicata come erronea o anche solo come innovazione: «caratteri come l’obscuritas della lettera, la scarsa formalizzazione sintattica e densità semantica, e soprattutto lo stesso principio organizzativo su cui si articola il discorso poetico, votato all’accumulazione e al proliferare di modelli associativi non-sensici, rendono componimenti del genere naturalmente disponibili a
interventi, per così dire, dall’esterno» (pp. 63-64).
Anche per questi motivi, oltre che per l’assenza di errori significativi comuni all’intero testimoniale, non è possibile ipotizzare l’esistenza di un archetipo. Pertanto, Celotto sceglie di razionalizzare i rapporti tra testimoni, formando gruppi in base a «comportamenti affini che concernono una certa sistematicità nel ricorso delle varianti» (p. 66); per quanto solo ipotetici, tali ‘insiemi’ di testimoni consentono indubbiamente di mettere ordine in una tradizione quanto mai caotica e difficile da sistematizzare. Ognuna delle mattane viene quindi editata a partire dal raffronto tra manoscritti e stampe, scegliendo poi un testimone particolarmente affidabile per approntare il testo base.
Per la prima mattana, I’ ò una paneruzzola bella e nuova, il testimone selezionato è R, il cui copista «è sempre molto attento, anche quando riporta lezioni singolari, a restituire l’omogeneità del testo e ad attenersi agli schemi imposti dal metro» (p. 68); la scelta è motivata anche dal confronto di R e dei manoscritti a esso maggiormente legati con M, molto antico ma portatore di una versione decisamente corrotta del testo.
Per Sì duramente un sonno mi percosse, invece, si prende come testo base quello del ms. F (BNCF, II IV 344). Celotto fonda la recensio sui mss. F, M e Vb3 (BAV, Barberiniano Latino 3936), dopo aver individuato la sicura discendenza da quest’ultimo del ms. Vb4 e delle stampe Al e V; dei tre, F si rivela essere il «più autorevole dal punto di vista della posizione nell’ordinamento, bisognoso di correzioni poco onerose e in numero non elevato» (p. 88); nei casi di adiaforia, tuttavia, si decide di optare, «dal momento che i raggruppamenti […] non consentono in ogni caso l’applicazione di criteri meccanici di scelta delle lezioni» (ibidem).
4.
• criteri di edizione*
La Nota ai testi presenta un paragrafo sulla lingua dei manoscritti R e F, riconducibile al fiorentino argenteo del Quattrocento, essenziale per legittimare le scelte editoriali. I numerosi scempiamenti e raddoppiamenti delle consonanti, sia quelli comuni a tutte le varietà toscane come lo scempiamento di protoniche dopo il prefisso a- sia quelli, più insoliti, di postoniche, la cui connotazione è «esclusivamente grafica» (p. 92), vengono normalizzati secondo l’uso moderno, al fine di «favorire l’approccio e l’ordinaria leggibilità» di un testo già piuttosto arduo data la «fisionomia spiccatamente gergale del lessico» (p. 93). L’editore è inoltre intervenuto su alcuni tratti non connotati da un punto di vista linguistico, di cui dà conto alle pp. 93-95.
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Nella Nota ai testi, l’editore offre dettagliate schede di raffronto tra gruppi di testimoni come fra singoli manoscritti, al fine di rilevare lectiones singulares, errori peculiari ed errori significativi utili alla ricostruzione dei rapporti tra i testimoni.
6.
• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*
L’editore ha adoperato manoscritti e stampe conservate presso le seguenti biblioteche: Firenze, Biblioteca Riccardiana (R); Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale (F, Fc); Firenze, Biblioteca Marucelliana (M); Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (Vb3, Vb4); Roma, Biblioteca Universitaria Alessandrina (V).
7.
• tipo di apparato/i*:
L’apparato critico, parzialmente discorsivo, raccoglie le lezioni sostanziali giudicate erronee;
alle varianti seguono le sigle dei testimoni che le riportano.
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina
8.
• presenza di note / commento al testo*: Sì.
• tipo di note / commento*
Il commento è di tipo ermeneutico e linguistico. Pur nell’intricato guazzabuglio di paradossi, contraddizioni e ossimori che edifica le mattane, Celotto restituisce il senso dei singoli passaggi delle terzine attraverso la parafrasi e la spiegazione dei gruppi di versi più ostici. Molto utile è il riconoscimento di alcuni motivi tipici della poesia del nonsense, come quello degli «animali intenti ad azioni militari» (I 22, p. 7) o la «dislocazione di strutture architettoniche» (I 116-117, p. 18), che contribuiscono a collocare i testi del Povero in un filone poetico non privo di sue consuetudini e di vere e proprie regole per l’esercizio dell’assurdo.
Il curatore fornisce rimandi a opere coeve, al fine di spiegare con ulteriori esempi i termini piùvconnotati, offrendone anche una definizione (sovente vagliata da verifiche sul GDLI e sul TLIO); numerosi sono soprattutto i rinvii ad autori d’area fiorentina – tra i quali Dante, Boccaccio, Antonio Pucci e Burchiello –, ad altri assimilabili all’area della poesia comica e ‘alla burchia’ e, nel caso della seconda mattana, a testi medievali d’ambito medico, come i Fiori di medicina di Gregorio d’Arezzo o la Santà del corpo di Zucchero Bencivenni.
Non mancano in ogni caso note di tipo filologico volte a giustificare la scelta di una lezione, come per esempio a I 105, dove «si sostituisce la lezione al singolare di R perché non rispetta la rima» (p. 17).
• posizione delle note / commento*: a piè di pagina.
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
L’Introduzione occupa le pp. XI-L del volume e colloca la figura semi-sconosciuta di Niccolò Povero, «rimatore a cui non si può assegnare né una storia né un profilo biografico» (p. XI), nel quadro della poesia del nonsense di area fiorentina: le mattane fanno parte di una «tradizione poetica piuttosto ricca – seppure sostanzialmente municipale – di registro mediocre, che fa del ricorso oltranzistico al linguaggio gergale, del ritmo disarticolato e dell’accumulazione seriale gli strumenti propri di una retorica che procede sul doppio versante della rappresentazione creaturale della realtà e dell’equivoco verbale» (p. XIX). Celotto illustra poi le diverse tipologie d’infrazione del senso, ottenuto per mezzo di artifici retorici e sintattici, come nel caso prevalente dell’«inversione del rapporto soggetto-oggetto» (p. XXVI). Particolarmente importante è la messa in discussione del rapporto tra il Povero e la poesia giullaresca, proposto con convinzione da Levi nei suoi pionieristici studi sulle paneruzzole ma irricevibile a una verifica testuale. Per quanto le mattane siano tramandate assieme a cantari in ottava rima, riconducibili al repertorio della giulleria, lo stile e la forma di questi testi non suggerisce in alcun modo una loro prossimità al mondo dei giullari; prova sia, per esempio, il destinatario di Sì duramente un sonno mi percosse, che non è «il pubblico popolare delle piazze fiorentine, ma un ipotetico “lettore” che l’autore esplicitamente chiama in causa» (p. XVIII). Proprio questa seconda mattana è al centro di una più particolareggiata disamina, in quanto evidente parodia del linguaggio medico; la ‘ricetta’ del Povero, che rispetta lo schema farmacopeico medievale, gioca sulla «tensione continua che si instaura tra ricorsività metrico-sintattica», scandita da formule e lemmi caratteristici come gli imperativi e i futuri di togliere, pestare e ungere, «e distorsione logica dei contenuti, la quale anzi risulta tanto più radicale quanto più coincide con un’intelaiatura irreprensibile» (p. XXXII).
La Bibliografia del volume occupa invece le pp. LI-LXI; oltre alle sigle di repertori, vocabolari e altri strumenti lessicografici si dà conto delle opere letterarie citate e degli studi critici consultati dal curatore, tra i quali spiccano quelli di Giuseppe Crimi e Michelangelo Zaccarello, del resto meritevoli studiosi della poesia burchiellesca .
