Autore dell’opera*: Thomasus de Faventia
Nomi alternativi con cui l’autore è noto: Thomaxius de Faventia, Tomaso da Faenza, Thomazo iudice
Titolo dell’opera*: Rime
Altri titoli con cui l’opera è nota:
Ambito cronologico*: medioevo / secolo XIII
Ambito linguistico*: italiano (volgare)
Tipologia di trasmissione dell’opera*: manoscritta di estensione limitata (senza autografi)
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione: manoscritti, in parte editi e in parte inediti, tutti apografi
Titolo edizione*: Rime
Curatore edizione*: Fabio Sangiovanni
Tipo edizione*: edizione critica ricostruttiva
Sede di pubblicazione*: Ravenna, Longo
Anno di pubblicazione*: 2016
Lingua di pubblicazione: italiano
Dati bibliografici completi: Tomaso da Faenza, Rime. Edizione critica con commento, a cura di Fabio Sangiovanni, Presentazione di Furio Brugnolo, Ravenna, Longo, 2016, 230 pp., ISBN 978-88-8063-825-4
Autore scheda*: Francesco Amendola
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
Informazioni aggiuntive: Alla tradizione del testo appartiene anche una stampa settecentesca (Giovanni Maria Barbieri, Dell’origine della poesia rimata, pubblicata ora per la prima volta e con annotazioni illustrata dal cav. ab. Girolamo Tiraboschi, 1790), che «riporta i primi sei versi di I [Spesso di gioia nasce ed inconinza] (in attribuzione guinizzelliana) citandone la fonte nel Libro siciliano» (p. 16).
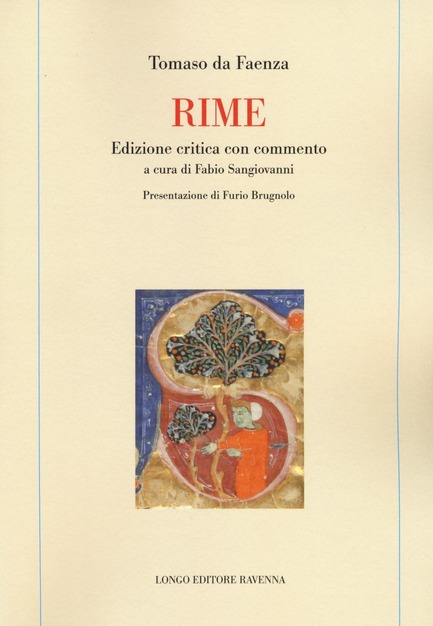
1.
• primi testimoni noti dell’opera*: i tre manoscritti più antichi, latori di componimenti di Tomaso, sono i seguenti:
- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Redi 9 (siglato L, ultimo decennio del Duecento);
- Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rai 217 (siglato P, fine sec. XIII);
- Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3793 (siglato V, fine sec. XIII-inizi sec. XIV).
2.
• precedente edizione critica del testo*
Guido Zaccagnini, Due rimatori faentini del secolo XIII, «Archivium Romanicum», XIX (1935), pp. 79-106 e Id., Rime di Tommaso da Faenza, di Onesto da Bologna, di Cino da Pistoia e di altri ricostruite sopra un nuovo canzoniere del secolo XIV, «L’Archiginnasio», XXXV (1940), pp. 226-43.
• precedente edizione scientifica di riferimento* Concordanze della lingua poetica italiana delle origini, I, a cura di D’Arco Silvio Avalle e con il concorso dell’Accademia della Crusca, Milano-Napoli, Ricciardi, 1992
Alcuni componimenti di Tomaso da Faenza sono stati pubblicati in:
- Gianfranco Contini, Poeti del Duecento, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960, 2 voll.;
- Onesto da Bologna, Rime, a cura di Sandro Orlando, Firenze, Sansoni, 1974;
- Monte Andrea da Fiorenza, Le rime, edizione critica a cura di Francesco Filippo Minetti, Firenze, Accademia della Crusca, 1979.
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
Si tratta di una nuova edizione critica che si sostituisce al precedente lavoro ecdotico realizzato da Guido Zaccagnini tra il 1935 e il 1940, considerato ormai datato e «di rara scorrettezza e arbitrarietà» (Contini). L’edizione di Sangiovanni rende per la prima volta fruibile in una veste filologicamente sorvegliata le rime di Tomaso da Faenza, poeta del Duecento citato e apprezzato da Dante nel De vulgari eloquentia (I, xiv, 3). Ai tredici componimenti attribuiti a Tomaso si aggiungono quelli a lui inviati dai suoi corrispondenti: Monte Andrea, Giovanni dall’Orto, Cino da Pistoia e Onesto da Bologna.
Ogni componimento presenta una peculiare tradizione testuale, motivo per cui Sangiovanni, una volta esposti nell’Introduzione (pp. 35-37) i criteri ecdotici generali su cui si fonda la sua edizione, riserva nel cappello delle singole poesie uno specifico spazio (Discussione testuale) in cui espone le scelte filologiche da lui adottate per la pubblicazione di ogni testo. In linea generale, dieci rime sono tramandate in tradizione unitestimoniale e tre invece in tradizione plurima: in quest’ultimo caso Sangiovanni predilige il Vat. lat. 3793 come testo base, in quanto testimone più autorevole (tale criterio risulta implicito, ma piuttosto evidente).
4.
• criteri di edizione*
I criteri di edizione dell’apparato sono i seguenti: «si costituisce un’unica fascia di apparato critico negativo, non distinguendo visivamente tra sostanzialità e formalità di lezione (le varianti sostanziali e i problemi di contitutio si discutono nelle sezioni introduttive); la segnalazione delle innovazioni dei descripti non è contemplata, non trattenendo tra gli obiettivi di questa edizione lo studio della mouvance […]. Entro la stringa delle varianti la maiuscola può indicare inizio di verso nei casi di ambiguità; per banalità dei casi, le abbreviature sono sciolte senza ulteriori indicazioni» (p. 35).
I criteri di trascrizione sono precisati in modo dettagliato nell’Introduzione (par. 7, Criteri ecdotici, pp. 35-37). Sono stati ricondotti all’uso grafico moderno quei fenomeni privi di rilevanza fonetica (come il nesso palatale -gli- che risponde alle grafie -lgli-, -lgl- etc., o altri simili come -ce- -ge- che corrispondono a -cie- e -gie-). Riguardo l’oscillazione grafica tra scempie e geminate «si è scelta invece la modalità seguente: per i componimenti relati da testimoni toscani la doppia, protonica o postonica, è assunta se almeno uno dei testimoni antichi presenti la forma geminata; in caso di manoscritto unico, o in accordo generale di scempiamento, si integrano solo le postoniche» (pp. 36-37). Per le preposizioni articolate si è preferita la tradizionale opzione analitica. È stata regolarizzata l’alternanza tra c’ e ch’, e composti. In apparato il grafema j è ricondotto a i, a testo è operata la distinzione tra u e v, la normalizzazione della congiunzione et, in scrizione estesa così come in eventuale nota tironiana. Per quanto riguarda i casi di rafforzamento fonosintattico: «non si è inserito il punto in alto (basti il raddoppiamento consonantico) che invece si utilizza per la caduta di consonante in assimilazione e successivo scempiamento o per semplice caduta di nasale; non si è inoltre adottato il trattino dopo nn finale» (p. 37).
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Il testo di ogni rima è preceduto da un cappello introduttivo in cui, oltre ad una sintesi relativa al significato del componimento, alle principali tematiche e allo studio intertestuale di fonti e topoi impiegati dal poeta, sono presenti: a) un elenco dei codici che tramandano il componimento (Mss.); b) una nota bibliografica sulle precedenti edizioni (Edizioni); c) l’analisi metrica del testo (Metrica); d) la Discussione testuale; e) la Discussione attributiva. Dopo il testo del componimento è presente un ampio commento.
Ai criteri costitutivi del corpus tomasiano è dedicato il par. 3 dell’Introduzione (pp. 20-22), in cui si chiarisce che l’attribuzione dei componimenti all’autore è stata stabilita in sede di recensio sulla base di quei testimoni «che presentino almeno un’attribuzione di paternità relativa a Tomaso, ed è operazione che nel faentino si rivela senza ostacoli, sia per ragioni d’unitestimonialità, sia per accordo delle rubriche» (p. 20). L’unico caso dubbio è rappresentato dalla canzone I (Spesso di gioia nasce ed inconinza) fino a ora classificata come dubbia a causa di una discordanza tra i mss. Vat. lat. 3793 (V) e Chig. L VIII 305 (Ch), che attribuiscono la rima a Tomaso, contro il ms. Banco Rai 217 della Biblioteca Nazionale di Firenze (P), che invece indica come autore il nome di Siribuono Giudice. Nella Discussione attributiva dedicata al componimento I (p. 42), Sangiovanni riconduce con sicurezza la canzone a Tomaso sulla base della testimonianza concorde dei due mss. V e Ch, «latori di miglior lezione rispetto al testo tradito da P – tendenzialmente più scorretto, nonché mutilo» (p. 42).
6.
• fonti archivistiche consultate dal curatore*: 12 manoscritti (pp. 14-20)
- Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. L VIII 305;
- Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3214;
- Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3793;
- Firenze, Accademia della Crusca, 53 (Raccolta Bartoliniana);
- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Redi 9;
- Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rai 217;
- Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II iii 492
- Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II iv 250 (già Magliabechiano VII 1009, già Strozzi);
- Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano VII 993 (già Strozzi 620);
- Firenze, Società Dantesca, ms. 4 (già Ginori Conti di rime antiche, già Strozzi);
- Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 1058;
- Verona, Biblioteca Capitolare, CCCCXLV
7.
• tipo di apparato/i*: apparato critico negativo; sono precisate le varianti alternative
• posizione dell’apparato*: ai piedi di ogni strofa (dunque non necessariamente a piè di pagina: nel caso di un componimento pluristrofico ogni strofa è seguita da una fascia di apparato)
8.
• presenza di commento al testo*: Sì
• tipo di commento*: all’iniziale parafrasi del testo si aggiungono informazioni di carattere linguistico, stilistico, culturale e filologico.
• posizione del commento*: a fine capitolo (ossia dopo la pubblicazione integrale del testo di ogni componimento)
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
- Presentazione (pp. 5-8) di Furio Brugnolo;
- Introduzione (pp. 9-38) articolata in 9 paragrafi:
- par. 0. Cenni di causalità (pp. 9-10): riflette sulla necessità di un’edizione critica delle rime di Tomaso da Faenza riepilogando lo stato degli studi.
- par. 1. L’autore: traccia biografica (pp. 10-14): cerca di fare luce sull’identità e sulla biografia dell’autore attraverso un riesame critico delle fonti e delle ipotesi formulate dai precedenti studiosi.
- par. 2. Operazioni di recensio (pp. 14-19): censimento e descrizione dei testimoni che tramandano le rime di Tomaso da Faenza.
- par. 3. Costituzione del corpus tomasiano (pp. 20-22): discute l’attribuzione a Tomaso delle rime che compongono il corpus pubblicato nell’edizione.
- par. 4. Metrica (pp. 23-25): scheda dei metri usati dall’autore.
- par. 5. Linee di cultura poetica (pp. 25-32): Sangalli descrive la prassi poetica di Tomaso essenzialmente come imitativa. I modelli di riferimento dell’autore si rintracciano in primo luogo nel repertorio tematico-formulare della scuola siciliana, e in particolare di Giacomo da Lentini, di cui condivide «i principi della rimeria cortese amorosa»; in secondo luogo Tomaso è «parziale assimilatore di certa parte di certo guittonismo, sempre di frequentazione bolognese». Non mancano, tuttavia, altri modelli coevi come Guinizzelli, affine culturalmente a Tomaso per area geografica e per professione giuridica, e Cino da Pistoia, con il quale Tomaso intrattiene una tenzone poetica.
- par. 6. Aspetti linguistici (pp. 34-35) studio linguistico dei principali fenomeni grafici e fonetici e dei fenomeni morfologici riscontrati nel testo delle rime di Tomaso da Faenza.
- par. 7. Criteri ecdotici (pp. 35-37) espone le linee guida adottate per la pubblicazione del testo critico.
- par. 8. Criteri esegetici (pp. 37-38) illustra i principi che hanno guidato il commento ai testi.
- Appendice (pp. 193-195): contiene tre testi rispettivamente di Guido Orlandi, Mula de’ Muli da Pistoia e Cino da Pistoia;
- Bibliografia (pp. 197-218)
- Elenco delle Edizioni di riferimento (pp. 219-221)
- Indice rimico, Indice metrico e Indice dei componimenti (pp. 222-227)
