Autore dell’opera*: Jacopo Cecchi
Titolo dell’opera*: Rime
Ambito cronologico*: medioevo / XIV secolo
Ambito linguistico*: italiano (volgare fiorentino)
Tipo trasmissione dell’opera*: manoscritta (tradizione pluritestimoniale non autografa)
Opera edita o inedita*: parzialmente edita (edite le rime I-II e App. 1; inedite le rime III e App. 2)
Titolo edizione*: Rime
Curatore edizione*: Benedetta Aldinucci
Tipo edizione*: edizione critica e commentata
Sede di pubblicazione*: Roma, Salerno Editrice
Anno di pubblicazione*: 2019
Lingua di pubblicazione: italiano
Dati bibliografici completi*: Jacopo Cecchi, Rime, a cura di Benedetta Aldinucci, Roma, Salerno Editrice, 2019 («Testi e documenti di letteratura e di lingua», XLIII), pp. XLII, 162.
Autore recensione/scheda*: Tommaso Salvatore
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
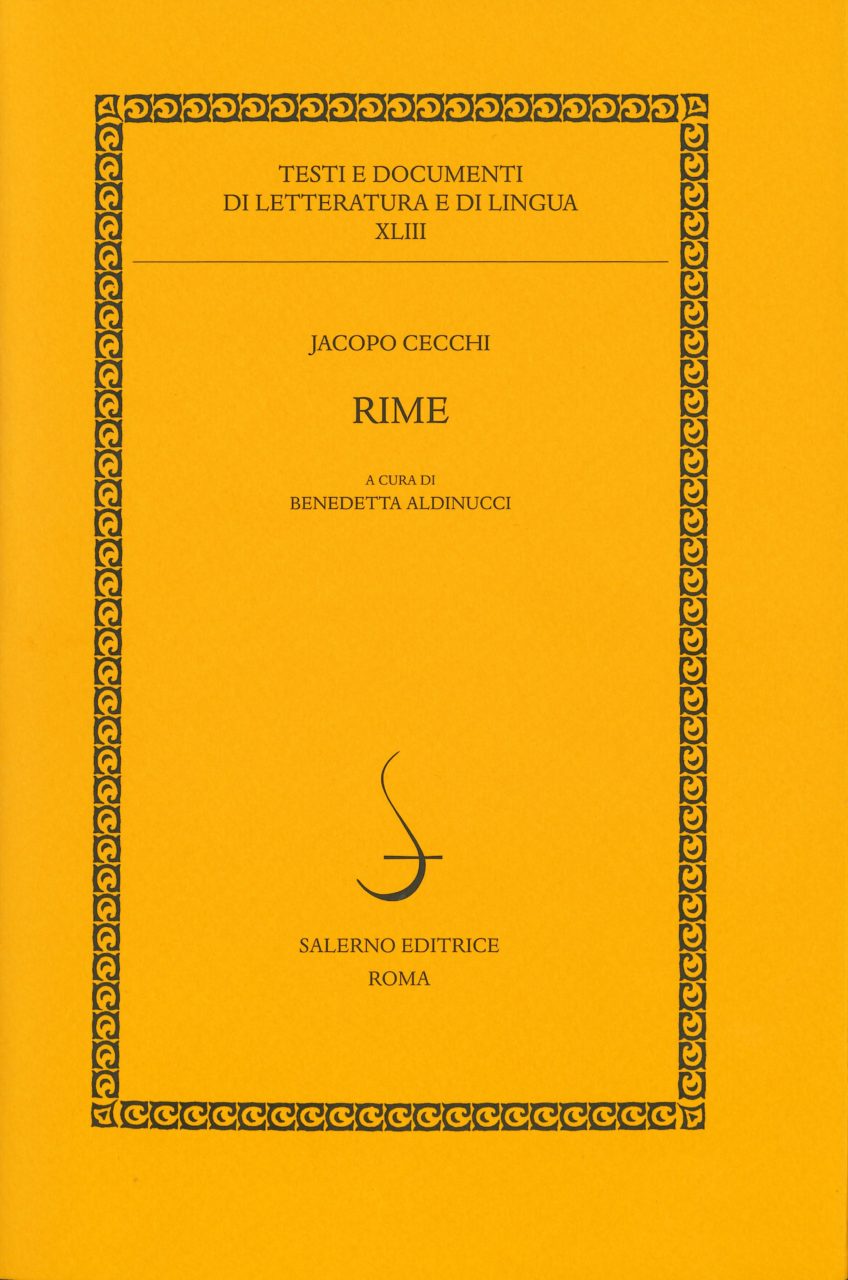
1.
• prima edizione dell’opera*
- Rima I: per secoli pubblicata fra le rime di Dante, la prima volta in Sonetti e canzoni di diversi antichi autori toscani in dieci libri raccolte, Impresso in Firenze, per li heredi di Philippo di Giunta, 1527.
- Rima II: Giovanni Lami, Catalogus codicum manuscriptorum qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur, Liburni, Antonii Sanctinii, 1756 (sulla base di Ricc. 1100).
- Rima III: inedita prima d’ora.
2.
• precedente edizione critica del testo*
Solo la rima I, edita da Elena Niccolai in C. Marin, E. Niccolai, Su un antico testimone della «Commedia» (Berlino, Staastbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Rehdiger 227), sul suo copista e sulla canzone di Jacopo Cecchi «Morte, perch’io non trovo a cui mi doglia», «Filologia italiana», XIV, 2017, pp. 29-66, a pp. 58-63.
• edizioni scientifiche di riferimento*
Solo le rime I-II, in Rimatori del Trecento, a cura di Giuseppe Corsi, Torino, UTET, 1969, a pp. 433-438 e pp. 438-440.
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
Prima edizione critica lachmanniana, sulla base dell’intero testimoniale noto, delle tre rime di Jacopo Cecchi pubblicate insieme; a esse si aggiungono la rima App. 1, di cui si propone la paternità del rimatore (sulla base dell’attribuzione a un imprecisato dominus Jacobus del ms. Par5), e la rima App. 2, anonimo rifacimento quattro-cinquecentesco della canzone I.
Solo le rime I-II e App. 1 erano finora edite; solo la rima I lo era in edizione critica.
4.
• criteri di edizione*
Edizione critica lachmanniana dell’intero corpus dell’autore, fondata su tutto il testimoniale noto. I criteri di edizione sono enunciati a pp. 150-153: oltre agli elementi di veste formale, descritti a p. 150, e alla tipologia di apparato, per cui vd. punto 7, si segnala che per le rime I-II si impiega come testimone base per la resa formale il ms. L46, fiorentino del sec. XIV ex. (non è il testimone fiorentino più antico, che per la rima I sarebbe Be, ma il testimone fiorentino più antico che tramandi le due rime insieme); per la rima III il testimone più antico Mr, fiorentino del sec. XV. L’ordinamento dei testi è così stabilito: per le rime I-II si mantiene la successione pluri-attestata dalla tradizione, la rima III viene in posta a seguire secondo la successione di Mr (qui però non a contatto). In appendice è posta App. 1, essendo solamente ipotetica l’identificazione di dominus Jacobus con il Nostro. In appendice pure, il rifacimento anonimo della canzone I, indicato come App. 2, a tradizione monotestimoniale.
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Descrizioni metriche dei testi e albero genealogico tracciato per ogni testo (nel cappello introduttivo); descrizione codicologica dei manoscritti e dettagliata recensio delle testimonianze relative a ogni testo con discussione degli errori guida e delle lectiones singulares che determinano i rapporti genealogici (nella nota al testo in calce al volume).
(vd. anche punti 9. e 10.)
6.
• fonti archivistiche consultate dal curatore*
1) fonti archivistiche a pp. XXI-XXI (dai fondi ASFi, Notarile Antecosimiano, Libri fabarum, Priorista di Palazzo, Diplomatico, Riformagioni e altri);
2) censimento dei manoscritti a pp. 50-96.
3) censimento delle stampe a pp. 96-110.
7.
• tipo di apparato/i*:
apparato critico negativo, registra in trascrizione diplomatica tutte le varianti alternative rifiutate, comprese le singulares, ma escludendo quelle puramente formali.
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina, in prima fascia d’apparato.
8.
• presenza di note / commento al testo*: Sì.
• tipo di note / commento*: commento esegetico, linguistico, intertestuale.
• posizione delle note / commento*: a piè di pagina, in seconda fascia d’apparato.
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
1) Introduzione con 1a) biografia dell’autore ricostruita tramite le fonti d’archivio; 2b) suo ruolo nella poesia del Trecento: la rima I attribuita per secoli a Dante e i casi di intertestualità con Petrarca.
2) Bibliografia divisa in 2a) Edizioni; 2b) Studi
3) Cappello introduttivo a ogni testo con: 3a) enunciazione del tema del testo; 3b) descrizione metrica; 3c) elenco dei testimoni manoscritti con loro rubrica attributiva; 3d) elenco delle edizioni a stampa; 3e) stemma codicum (per gli apparati vd. punti 7 e 9).
4) Nota al testo divisa in 4a) Conspectus siglorum; 4b) censimento dei manoscritti; 4c) censimento delle stampe; 4d) recensio dei testi singolarmente esaminati; 4e) criteri di edizione
5) Glossario delle voci linguistiche
10.
• recensione*
Prima edizione critica lachmanniana, fondata su tutto il testimoniale noto, dell’intero corpus di Jacopo Cecchi, ossia le tre rime a lui attribuite dalla tradizione, a cui si aggiungono la rima App. 1, di cui si propone la paternità del rimatore (sulla base dell’attribuzione a un imprecisato dominus Jacobus del ms. Par5), e la rima App. 2, anonimo rifacimento quattro-cinquecentesco della canzone I.
Solo le rime I-II e App. 1 erano finora edite; solo la rima I lo era in edizione critica. Precisamente, la rima I è stata per secoli pubblicata fra le rime di Dante, la prima volta nella ‘Giuntina di rime antiche’ (Sonetti e canzoni di diversi antichi autori toscani in dieci libri raccolte, Impresso in Firenze, per li heredi di Philippo di Giunta, 1527); la rima II la prima volta sulla base di Ricc. 1100 nel catalogo dei codici riccardiani di Giovanni Lami (Catalogus codicum manuscriptorum qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur, Liburni, Antonii Sanctinii, 1756); la rima III inedita prima d’ora. L’edizione di riferimento era fino a tempi recenti, per le sole rime I-II, RdT di Giuseppe Corsi (Rimatori del Trecento, Torino, UTET, 1969, a pp. 433-438 e pp. 438-440), fino a quando la sola rima I non si è giovata di un’edizione critica da parte di Elena Niccolai (in C. Marin, E. Niccolai, Su un antico testimone della «Commedia» (Berlino, Staastbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Rehdiger 227), sul suo copista e sulla canzone di Jacopo Cecchi «Morte, perch’io non trovo a cui mi doglia», «Filologia italiana», XIV, 2017, pp. 29-66, a pp. 58-63).
La presente edizione è così articolata:
- Introduzione con 1a) biografia dell’autore ricostruita tramite le fonti archivistiche citate a pp. XXI-XXI (dai fondi ASFi, Notarile Antecosimiano, Libri fabarum, Priorista di Palazzo, Diplomatico, Riformagioni e altri); 1b) ruolo del rimatore nella poesia del Trecento, che discute il caso della rima I attribuita per secoli a Dante e elementi salienti di intertestualità petrarchesca.
- Bibliografia divisa in 2a) Edizioni; 2b) Studi.
- Testi, ognuno dei quali corredato di capello introduttivo e apparato in due fasce: 3a) Cappello introduttivo con: 3a1) enunciazione del tema del testo; 3a2) descrizione metrica; 3a3) elenco dei testimoni manoscritti con loro rubrica attributiva; 3a4) elenco delle edizioni a stampa; 3a5) stemma codicum. 3b) Apparato a piè di pagina in due fasce così articolato: 3b1) apparato critico negativo, che registra in trascrizione diplomatica tutte le varianti alternative rifiutate, comprese le singulares, ma escludendo quelle puramente formali; 3b2) commento esegetico, linguistico, intertestuale.
- Nota al testo divisa in 4a) Conspectus siglorum; 4b) censimento dei manoscritti con descrizione codicologica; 4c) censimento delle edizioni a stampa; 4d) dettagliata recensio delle testimonianze relative a ogni testo, singolarmente esaminato, con discussione degli errori guida che determinano i rapporti genealogici e delle lectiones singulares; 4e) criteri di edizione: oltre agli elementi di veste formale e alla tipologia di apparato, si segnala che per le rime I-II si impiega come testimone base per la resa formale il ms. L46, fiorentino del sec. XIV ex. (non è il testimone fiorentino più antico, che per la rima I sarebbe Be, ma il testimone fiorentino più antico che tramandi le due rime insieme); per la rima III il testimone più antico Mr, fiorentino del sec. XV in. L’ordinamento dei testi è così stabilito: per le rime I-II si mantiene la successione pluri-attestata dalla tradizione, la rima III viene in posta a seguire secondo la successione di Mr (lì però non a contatto); in appendice è posta App. 1, essendo solamente ipotetica l’identificazione di dominus Jacobus con il Nostro; in appendice pure, come App. 2, è il rifacimento anonimo, a tradizione monotestimoniale, della canzone I.
- Glossario delle voci linguistiche.
