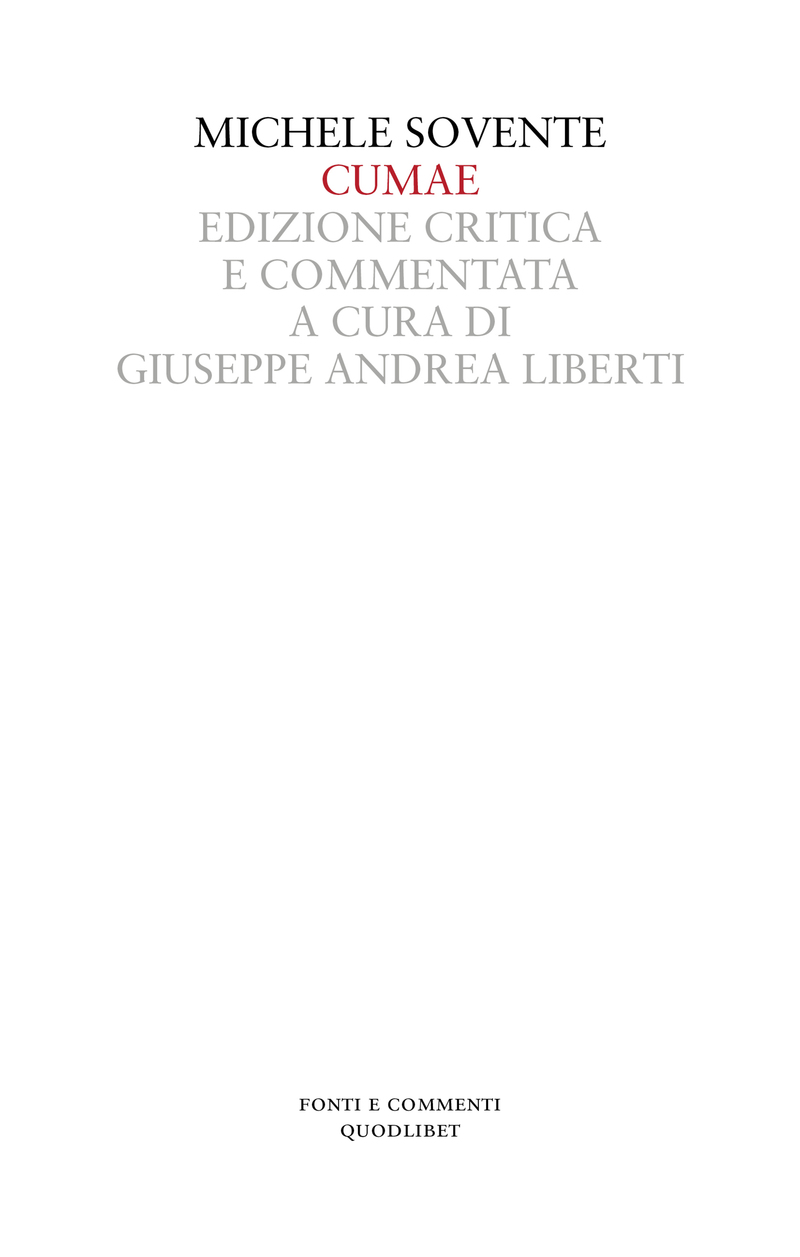Autore dell’opera*: Michele Sovente (1948-2011)
Titolo dell’opera*: Cumae
Ambito cronologico*: Età contemporanea/XXI sec.
Ambito linguistico*: Italiano
Tipo trasmissione dell’opera*: a stampa
Tipologia di testimoni su cui si basa l’edizione*:
- testimoni manoscritti e dattiloscritti autografi,
- edizioni a stampa
Titolo edizione*: Cumae
Curatore edizione*: Giuseppe Andrea Liberti
Tipo edizione*: Edizione critica con commento
Sede di pubblicazione*: Macerata, Quodlibet
Anno di pubblicazione*: 2019
Lingua di pubblicazione: Italiano
Dati bibliografici completi: Michele Sovente, Cumae, edizione critica e commentata a cura di Giuseppe Andrea Liberti, Macerata, Quodlibet, 2019 (Fonti e commenti, nuova serie, 2), pp. 487, ISBN 978-88-229-0411-9
Autore della scheda*: Viola Bianchi
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
1.
• prima edizione dell’opera*:
Alcuni testi poetici, poi confluiti nella raccolta del 1998, furono pubblicati dall’autore su diversi periodici tra il 1988 e il 1996 (cfr. le indicazioni fornite nella Nota al testo, in particolare nel paragrafo II, La formazione di Cumae, pp. 92-111).
Prima edizione della raccolta di poesie: Michele Sovente, Cumae, Venezia, Marsilio, 1998 (Poesia, collana diretta da Giovanni Raboni).
• successive edizioni vivente l’autore:
Alcuni componimenti della raccolta furono ripubblicati in: Michele Sovente e Giuseppe Leone, L’eco dell’ombra, Napoli, Pitturaepoesia, 2009 e «L’Ulisse. Rivista di poesia, arti e scritture», n. 11 (2008), La poesia lirica nel XXI secolo: tensioni, metamorfosi, ridefinizioni (cfr. p. 92, Riviste, antologie e riedizioni successive alla pubblicazione di Cumae in Nota al testo, par. 1, Descrizione dei testimoni).
2.
• precedente edizione critica del testo*: NO
• precedente edizione scientifica di riferimento*: NO
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
Giuseppe Andrea Liberti utilizza come testo-base quello dell’editio princeps (Venezia, Marsilio, 1998), in quanto unica edizione di Cumae fino ad oggi pubblicata. Il curatore sottolinea nella Nota al testo (cfr. pp. 87-119) l’importanza di condurre uno studio filologico e critico sulla raccolta, anche «A dispetto dell’assenza di qualunque riedizione dei libri del poeta Sovente» (p. 117): dedicando due corposi paragrafi alla storia testuale di Cumae e al metodo di lavoro del poeta, Liberti mette infatti in evidenza la problematicità di «un volume dalla lunga gestazione, non ripercorribile in ogni sua tappa ma in ogni caso scandita da pubblicazioni in rivista e altri, variegati avantesti» (p. 111) e ricostruisce con chiarezza l’evoluzione «di una ricerca lenta, che affonda in realtà le sue radici in progetti, bozze e prove poetiche risalenti almeno agli anni Ottanta, che per Sovente hanno rappresentato certamente la fase in cui prende corpo il linguaggio che ne caratterizza l’opera matura» (p. 93). La ragione dell’edizione critica di Liberti sta dunque nel voler «sfruttare tutti i mezzi a disposizione per accertare il percorso compositivo di un’opera che, se è rimasta immutata nella forma, non di meno vanta un processo elaborativo di lunga durata, redazioni stratificate, è insomma un “testo storico in movimento”» (p. 117).
4.
• criteri di edizione*
Giuseppe Andrea Liberti dedica ai Criteri di edizione un intero paragrafo della nota al testo (cfr. pp. 117-119). Il testo-base che viene scelto è necessariamente quello dell’editio princeps, «in quanto unica edizione pubblicata di Cumae» (p. 118) e sorvegliata dall’autore (il quale ricevette l’ultima bozza di stampa il 26 gennaio 1998). In apparato, è quindi riportata la varia lectio «delle liriche di cui si dispongono versioni anteriori» (ivi). Il curatore segnala infine di non aver potuto rispettare «la mise en page originale dei testi bilingue, che nel volume del ’98 si presentavano con testo a fronte» (ivi), a causa della «mole degli apparati esegetici che compongono questa edizione» (p. 119), specificando tuttavia che «Il mancato rispetto di questa testualità […] è compensato dai numerosi ragguagli forniti nel commento sui legami e le differenze tra testi latini e italiani» (pp. 118-119).
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Nella corposa Nota al testo, Liberti fornisce, oltre alla descrizione dei testimoni mano- dattiloscritti e a stampa (cfr. par. 1, Descrizione dei testimoni, pp. 89-92), la fondamentale ricostruzione della storia della raccolta (cfr. par. 2, La formazione di Cumae, pp. 92-111), l’approfondimento sul metodo di lavoro dell’autore (cfr. par. 3, Approssimazione al lavoro di Sovente, pp. 111-117) e i criteri ecdotici applicati (cfr. par. 4, Criteri di edizione, pp. 117- 119).
6.
• fonti archivistiche consultate dal curatore*
Biblioteca “Michele Sovente”, Cappella di Monte Procida (NA). Per i dettagli delle collocazioni archivistiche e la descrizione dei testimoni autografi si rimanda alla Nota al testo, sottoparagrafo 1.2, Testimoni mano-dattiloscritti, pp. 90-91.
7.
• tipo di apparato*:
L’apparato, orizzontale e genetico, viene descritto dal curatore nella Nota al testo, a p. 118:
«nel caso delle liriche di cui si dispongono versioni anteriori […] il testo è seguito da due fasce d’apparato: nella prima, si riportano, preceduti dalla sigla “att.” (‘attestato in’), i testimoni che tramandano il testo; nella seconda, si dà conto del processo variantistico a cui è stato soggetto il testo. La lezione soggetta a mutamento è riferita col numero del verso del testo base in cui ricorre e delimitata da una parentesi quadra chiusa, alla quale seguono le varianti individuate dalla sigla o dalle sigle dei testimoni che la riferiscono». Nello stesso luogo viene presentato anche l’elenco dei simboli e delle abbreviazioni utilizzate in apparato.
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina
8.
• presenza di note / commento al testo*: sì
• tipo di note / commento*:
Ciascun componimento è preceduto da un cappello introduttivo che offre sintetiche informazioni di natura filologica ed interpretativa, ed è seguito da una nota metrica e da un commento puntuale, in rapporto a singoli luoghi del testo, sottoforma di brevi note.
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
L’edizione presenta una ricca Introduzione (cfr. pp. 11-68) firmata dallo stesso curatore, che fornisce informazioni sulla poetica di Sovente e sugli elementi formali caratterizzanti la raccolta, con uno sguardo che da Cumae si estende anche ad altre esperienze poetiche dell’autore. Si segnala in particolare il paragrafo Le lingue e lo stile (cfr. pp. 34-57), in cui il curatore delinea «il triplice profilo linguistico» (p. 35) dell’opera (latino, italiano e vernacolo cappellese). Sebbene il dato linguistico abbia monopolizzato per anni l’attenzione della critica intorno alla poesia soventiana, con conseguente «svalutazione dell’originalità dei contenuti» (p. 34) (non trascurata da Liberti nella presente edizione), questo approfondimento resta un tassello fondamentale, vista anche l’importanza rivestita da Cumae nello «scavo linguistico di Sovente» (p. 35): la raccolta non costituisce, infatti, un «punto d’arrivo», ma «una prima, determinante stabilizzazione, con l’ufficializzazione dell’uso del latino come lingua della poesia e l’introduzione di un libro compiuto del dialetto» (ivi).
Il curatore ha introdotto inoltre una Nota bio-bibliografica di Michele Sovente (cfr. pp. 69- 76) e una Bibliografia poetica (cfr. pp. 77-86) suddivisa in Raccolte poetiche, Poesie in miscellanee e antologie, Poesie pubblicate su riviste, giornali e in rete, Bibliografia critica su Michele Sovente.
In fondo al volume vengono sciolte le Abbreviazioni bibliografiche (cfr. pp. 477-487) ed è presente l’Indice dei nomi (cfr. pp. 489-493).
10.
• ulteriori eventuali considerazioni
L’edizione critica rielabora una tesi di dottorato discussa nel febbraio 2019 presso L’Università di Napoli “Federico II” ed è stata pubblicata con il contributo dello stesso Ateneo.