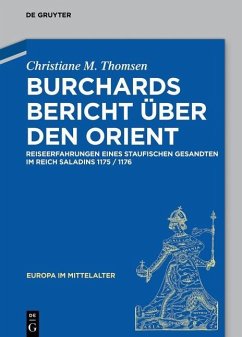Autore dell’opera: Burchardus Argentinensis
Titolo dell’opera di cui si recensisce l’edizione: Relatio de itinere in Terram Sanctam
Ambito cronologico dell’opera di cui si recensisce l’edizione: medioevo/XII secolo
Ambito linguistico: latino
Tipologia di trasmissione: Due testimoni diretti; tradizione indiretta
Curatore dell’edizione: Christiane M. Thomsen
Tipologia dell’edizione: edizione critica con commento
Dati bibliografici del volume recensito: Burchards Bericht über den Orient. Reiseerfahrungen eines staufischen Gesandten im Reich Saladins 1175/1176, hrsg. Christiane M. Thomsen, Berlin-Boston, De Gruyter, 2018, pp. vii-654, tavv. (Europa in Mittelalter 29)
Sede di pubblicazione del volume recensito: De Gruyter, Europa in Mittelalter
Anno di pubblicazione: 2018
Lingua di pubblicazione del volume recensito: tedesco
Autore della recensione: Paolo Chiesa
Tipologia del contributo: recensione
Parole chiave: letteratura di viaggio
L’opera è una descrizione dell’Egitto e della Siria, che comprende anche l’itinerario marittimo a partire da Genova; venne composta in seguito a una missione diplomatica presso il Saladino, compiuta dall’autore per incarico dell’imperatore Federico Barbarossa. Il testo è conservato in due manoscritti principali (Vaticano lat. 1058; Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 362), ed era riportato in un frammento scoperto da P. Lehmann nella Universitätsbibliothek di Monaco e da lui pubblicato nel 1940, ma in seguito andato distrutto.
Esso è incorporato inoltre nel settimo libro della Chronica di Arnoldo di Lubecca, e degli estratti per collazione compaiono in alcuni codici della Peregrinatio di Tietmaro, che inoltre ne riporta vari passaggi nel corpo dell’opera. Il volume presenta un’edizione critica del testo, sulla base di tutta la documentazione disponibile. Nell’ampia introduzione vengono discussi gli aspetti letterari (genere, struttura, caratteristiche linguistiche, funzione comunicativa), vengono approfondite le circostanze storiche della missione, e si procede all’identificazione dei luoghi e dei fatti narrati da Burcardo, inquadrandoli nell’immagine della Terrasanta, e soprattutto dell’Egitto, che gli Europei avevano all’epoca. L’opera, per quanto non molto diffusa, ebbe comunque una certa circolazione (oltre che da Arnoldo e da Tietmaro, essa fu utilizzata da Jacques de Vitry), e se ne indagano i meccanismi di ricezione: nel codice Vaticano e nel frammento di Monaco essa è unita alla Descriptio de locis sanctis di Rorgone Fretello, a formare una piccola raccolta tematica, forse a uso di pellegrini.
Il problema posto dall’edizione di questo testo è la valutazione della tradizione indiretta (in particolare Arnoldo, ma in misura minore anche Tietmaro) ai fini della ricostruzione testuale. La Chronica di Arnoldo è in effetti la testimonianza più antica dell’opera, risalendo al 1210 e precedendo di una settantina d’anni il primo dei testimoni diretti, che è il codice Vaticano; il giudizio di Thomsen è che la riproduzione di Arnoldo sia “recht zuverlässig”, nonostante gli inevitabili aggiustamenti effettuati per inserire il testo nel nuovo contenitore (pp. 487-90). La Chronica non ha a sua volta una tradizione ‘facile’, perché se ne conoscono due redazioni d’autore e due redazioni successive, queste ultime più diffuse e meglio attestate, ma divergenti dalle forme originali; alla ricostruzione di questa situazione, con descrizione dei manoscritti più importanti, Thomsen riserva ampio spazio nel volume. In realtà il testo riportato da Arnoldo è in certi casi piuttosto diverso, anche in particolari importanti (il nome dell’autore della relazione di viaggio, ad esempio, figura nella forma Gerardus, non Bernhardus).
Le premesse all’edizione non sono molto soddisfacenti. Viene presentato uno stemma a tre rami, ognuno dei quali è individuato da “Übereinstimmungen”, ma non da errori comuni; nessuna di queste concordanze, semplicemente indicate in nota con il rinvio alla riga del testo, viene per altro discussa sul piano stemmatico; un esame sommario fa pensare che si tratti di varianti adiafore, prive di valore distintivo. Il punto è delicato perché, ad esempio, la stessa connotazione geografica dell’autore (Argentinensis vicecomes in Arnoldo, Gentinensis nelle appendici a Tietmaro) è conservata nella tradizione indiretta, ma non in quella diretta. Lo stemma ricostruito è tripartito ([A+collazioni in Tietmaro] vs. Tietmaro vs. [V, M, W, cioè la tradizione diretta]) ma non sembra sufficientemente motivato. Si conclude, un po’ superficialmente, che “recht gute
Lesarten bieten die Arnoldhandschrift und der Vatikanische Codex”. L’introduzione alla “Textkonstitution” (p. 511) lascia perplessi. Dopo una breve premessa in cui si identificano le strategie possibili per un’edizione – scelta di un Leithandschrift ̧ scelta di un Leithandschriftgruppe e la costruzione di un Hybridtext sulla base di più manoscritti –, Thomsen dichiara che nel caso presente la concordanza fra manoscritti diversi assicura la qualità del testo, e il problema – par di capire – si risolve da solo. Come base viene preso il testo di Arnoldo, che però non viene elevato al rango di Leithandschrift. Tietmaro viene utilizzato come testo di controllo, in quanto terzo ramo della tradizione. Sulla spinosa e delicata questione della frase iniziale si segue il testo di Arnoldo, “da die Handschriften V, M und W [cioè la tradizione diretta] offenbar eine gekürzte Version bieten”.