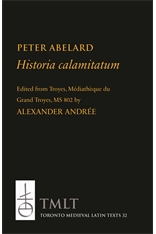Autore dell’opera: Abaelardus Petrus
Titolo dell’opera di cui si recensisce l’edizione: Historia calamitatum mearum
Ambito cronologico dell’opera di cui si recensisce l’edizione: medioevo/XII secolo
Ambito linguistico: latino
Tipologia di trasmissione: Tradizione multipla
Curatore dell’edizione: Alexander Andrée
Tipologia dell’edizione: edizione semiscientifica, su unico manoscritto, con commento
Dati bibliografici del volume recensito: Peter Abelard, Historia calamitatum, edited from Troyes, Médiathèque du Grand Troyes, MS 802 by Alexander Andrée, Toronto, Centre for Medieval Studies by the Pontifical Istitute of Mediaeval Studies, 2015 (Toronto Medieval Latin Texts 32)
Sede di pubblicazione del volume recensito: Toronto Medieval Latin Texts
Anno di pubblicazione: 2015
Lingua di pubblicazione del volume recensito: inglese
Autore della recensione: Paolo Chiesa
Tipologia del contributo: recensione
Informazioni aggiuntive: edizione a scopo divulgativo e didattico, che rispecchia l’impostazione (anche scientifica) della collana in cui è pubblicata, cioè la valorizzazione del manoscritto unico come prodotto culturale.
Parole chiave: autobiografia
Il volume è uno dei più recenti fra i Toronto Medieval Latin Texts. Si tratta di una serie attiva dal 1972 e basata su particolari criteri editoriali; in omaggio alla sua ormai lunga tradizione, si riserva un’altra scheda a un esame complessivo della consistenza complessiva della collana. L’edizione dell’Historia calamitatum si basa sul manoscritto Troyes 802 (T), considerato il codex potior della tradizione («whatever its exact position in the textual transmission, there can be no doubt that, of all surviving manuscripts, T is the superior and in itself presents a complete and largely correct text of the HC», p. 11). Il problema di posizione stemmatica cui l’editore accenna è se il codice sia derivato direttamente dall’archetipo, o si trovi a un livello più basso, in quanto copia di uno dei due subarchetipi, un punto su cui gli studiosi che si sono occupati del problema hanno espresso opinioni diverse. La scelta del manoscritto potior da parte di Andrée è comunque legata alla sua presupposta eccellenza nella restituzione del testo dell’autore: «with the exception of T (and perhaps A) all manuscripts are quite far removed from the hypothetical archetype of the tradition and contribute only minor, if any, improvements to the text of T (which are often picked up by Tcorr.)» (p. 10). Nella formulazione è resa esplicita la strategia della collana, che prevede l’adozione di un manoscritto unico, ‘migliorato’ dove necessario con il supporto di altri testimoni.
Le ragioni dell’edizione rispondono a quelli generali della serie di cui fa parte; nel caso di questa specifica si sottolineano soprattutto, con un certo understatement, le necessità didattiche e divulgative: dell’Historia calamitatum non c’è alcuna «standard student edition of the text geared to English-speaking readers»; «there are no edition, regardless of language, the provide students of Medieval Latin with an easily accessible text that is contestualized with comments and notes»; «the purposes of the present volume are to offer the Latin text of Abelard’s letter staying as close as possible to the most reliable manuscript and to furnish this text with notes, elucidating points of grammar and contents»; «in no way is this edition intended to supersede existing critical editions of the text or to take the place of one; its sole purpose is to serve scholarum in usum» (pp. 1-2).
Nell’introduzione vi è in realtà una trattazione abbastanza dettagliata della tradizione manoscritta, un’accurata descrizione di T e, soprattutto, una discussione delle precedenti edizioni dell’opera, di ognuna delle quali sono elencate le caratteristiche e i limiti, anche per rilevare le specificità dell’edizione presente. Si insiste molto sulla conservazione della facies formale del testo: quasi tutte le edizioni precedenti, fino a quella di Luscombe (The Letter Collection of Peter Abelard and Heloise, edited with a revised translation by David Luscombe after the translation by Betty Radice, Oxford, Clarendon Press 2013), uniformano la grafia alla norma classica, secondo quelle che vengono considerate «unhappy ortographical choises». Nell’edizione presente, invece, «the ortography of T has been followed closely»; tutte le «idiosyncrasies» ortografiche del manoscritto (cioè le irregolarità, le variazioni ecc., che sono parecchie, come viene apertamente dichiarato) sono mantenute come tali. Il peso un po’ ossessivo della conservazione grafica ha qualcosa di arbitrario, se misurato sulla prassi di Abelardo, perché il codice non è autografo e non c’è la minima ragione di pensare che l’autore avesse proprio quelle «idiosyncrasies» (anzi, data la sua formazione e la sua capacità letteraria, si penserebbe proprio il contrario, cioè che perseguisse la massima adesione possibile alla norma classica). La fedeltà al manoscritto non giunge a rispettarne la punteggiatura, che è stata modificata in modo da renderla «more synctatic»; analogamente i nomi propri e gli aggettivi geografici sono scritti con la maiuscola. Del codice sono state altresì mantenute le rubriche in margine, che secondo Andrée potrebbero essere originali.
Il testo è accompagnato da due apparati: il primo è composto da note di carattere linguistico e contenutistico; il secondo è invece filologico, e segnala in massima parte le lezioni di T che non vengono accettate, o gli interventi di un correttore nel ms. T, che in genere vengono accolti a testo perché, secondo Andrée, ne costituiscono un miglioramento. Queste correzioni a giudizio dell’editore non sono congetturali, ma ricavate da collazione e dunque tradizionali, anche se non è possibile dire quale sia il codice di controllo utilizzato («whether taken from the archetype or from another branch of the tradition»). Alla fine del volume è fornito un elenco dei passi in cui il testo di questa edizione si discosta da quello delle precedenti.
Nel complesso, l’edizione è un curioso, e forse suggestivo, mix di divulgazione e edizione critica. Lo scopo, nonostante la ragione dichiarata, non è soltanto quello di dare un testo accessibile agli studenti anglofoni, perché l’entità della ricerca sottesa non è irrilevante; c’è un forte contrasto, in particolare, fra il livello delle annotazioni linguistiche, in genere elementare, e quello delle annotazioni filologiche, che presuppongono un più impegnativo percorso di studio.