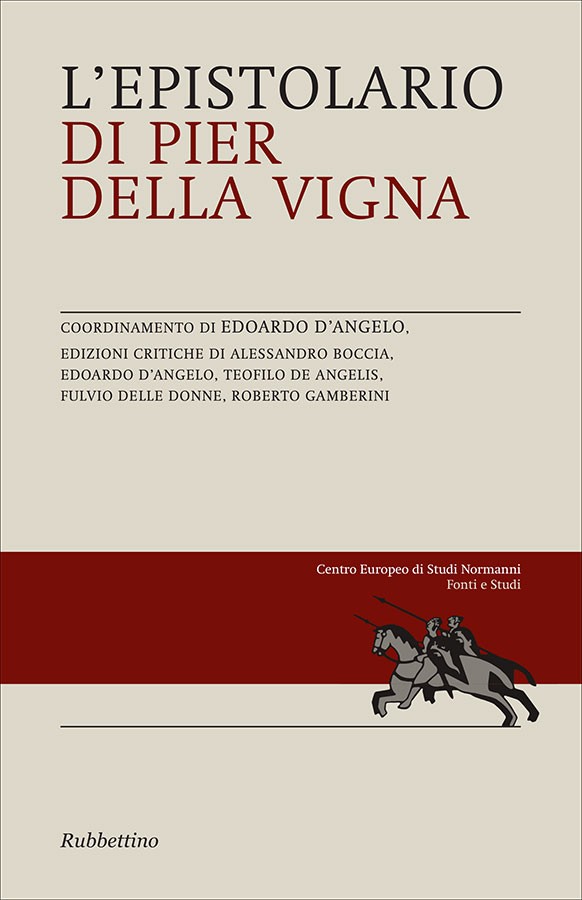Autore dell’opera: Petrus de Vinea
Titolo dell’opera di cui si recensisce l’edizione: Epistolae
Ambito cronologico dell’opera di cui si recensisce l’edizione: medioevo/XIII secolo
Ambito linguistico: latino
Tipologia di trasmissione: Tradizione molto abbondante e ad assetto variabile
Curatore dell’edizione: Coordinatore: Edoardo D’Angelo. Editori dei testi: Alessandro Boccia, Edoardo D’Angelo, Teofilo De Angelis, Fulvio Delle Donne, Roberto Gamberini
Dati bibliografici del volume recensito: L’epistolario di Pier della Vigna. Coordinamento di Edoardo D’Angelo. Edizioni critiche di Alessandro Boccia, Edoardo D’Angelo, Teofilo De Angelis, Fulvio Delle Donne, Roberto Gamberini, Centro Europeo di Studi Normanni – Rubbettino, Ariano Irpino – Soveria Mannelli 2014
Sede di pubblicazione del volume recensito: Centro Europeo di Studi Normanni
Anno di pubblicazione: 2014
Lingua di pubblicazione del volume recensito: italiano
Autore della recensione: Paolo Chiesa
Tipologia del contributo: recensione
Informazioni aggiuntive: edizione su testimone preferenziale di un’opera a vastissima diffusione. La traduzione, essendo la prima effettiva in una lingua moderna, comporta non indifferenti problemi interpretativi.
Parole chiave: epistolari – tradizioni numerose
L’imponente volume (1160 pagine) comprende l’edizione del cosiddetto Epistolario di Pier della Vigna, in realtà una raccolta di scritti diversi – lettere, editti, formulari ecc. -, alcuni dei quali collegati all’attività di Piero, ma altri certamente a lui estranei, anche soltanto per ragioni cronologiche; questi materiali furono poi assemblati a distanza di tempo in raccolte, che ebbero vastissima circolazione e divennero modelli di dictamen. Fra le quattro forme principali in cui l’Epistolario circola, si è scelto di pubblicare quella chiamata P6, ossia la Redazione Parva in 6 libri, per ragioni di carattere ‘scientifico’ – questa forma “sembra essere molto vicina a quella ‘originale’ P5, ma contiene quasi il triplo delle lettere”; inoltre è la più diffusa ed è quella pubblicata anche da Iselin [si sta parlando dell’edizione di Basilea del 1740], il che consente di mantenerne la numerazione, che è entrata in maniera assoluta nell’uso” – e di buon vicinato accademico (sulla redazione M6, la Magna in 6 libri, è attivo un progetto presso i Monumenta Germaniae Historica).
Il metodo editoriale seguito è quello del codex potior, ricontrollato e emendato sulla base di altri testimoni quando dubbio o mendoso. Il manoscritto prescelto è il Parigino lat. 8563, che è “il codice più alto di tutta la tradizione dell’Epistolario”, potendosi datare a prima del 1318. La scelta è certamente ragionevole, anche se si può osservare che la divaricazione cronologica fra questo codice e il documento databile più recente all’interno della raccolta, risalente al 1264, è comunque ampia, e rende meno cogente ricorrere a criteri cronologici nella scelta del testimone potior, come invece sarebbe stato se il manoscritto fosse stato più vicino a tale data, o almeno considerevolmente più prossimo all’originale rispetto ad altri. Gran parte della tradizione trecentesca viene del resto recuperata fra “gli altri testimoni usati a supporto delle défaillances di P”. Questi – tredici in tutto – sono stati selezionati “in base a tre criteri: in primis quello cronologico (XIV secolo); quello redazionale (appartenenza alla redazione P6), geografico; infine uno squisitamente filologico: il sondaggio di loci critici”. La formulazione è un po’ sbrigativa, e non permette al lettore di comprendere bene i motivi della scelta: anzitutto i criteri sembrano quattro e non tre (quello ‘geografico’ è introdotto in modo non molto perspicuo); e quanto ai loci critici si dice solo (in nota) quali sono stati i capitoli interessati all’operazione. L’analisi per loci critici consiste in genere nell’esaminare il comportamento di un ampio numero di testimoni, che non si vuole o non si può collazionare per intero, su specifici passi dell’opera, per i quali la collazione di alcuni testimoni fondamentali abbia già permesso di individuare degli errori-guida; in questo caso il termine sembrerebbe invece usato a designare una serie di capitoli-campione sui quali sono stati collazionati un certo numero di codici (non solo quei tredici, si penserebbe), all’interno dei quali sono stati poi individuati i ‘migliori’. Qualche parola in più per illuminare la procedura seguita sarebbe stata utile.
Oltre ai tredici citati, vengono utilizzati anche tre manoscritti della “tradizione stravagante” (nella quale cioè figurano singoli documenti, non organizzati nelle raccolte canoniche) “che già in altre occasioni hanno dimostrato di essere particolarmente significativi”: questo perché “essi, talvolta, recano i testi in una versione che non ha subito i pesanti filtri e gli adattamenti… che invece si riscontrano nei testimoni che trasmettono le organizzazioni più sistematiche”, e quindi “possono fornire lezioni più vicine a quelle originali”. Il ricorso ai codici ‘secondari’ è motivata così: “da un lato, nessun manoscritto – soprattutto per una redazione molto diffusa – può considerarsi esente da interventi o rimaneggiamenti di chi lo esemplò o lo organizzò; dall’altro… nessun manoscritto può dare l’immagine del testo in un ben determinato momento o in una ben determinata zona, se contemporaneamente ci sono altri testimoni che, nello stesso momento o nella stessa zona, offrono un’immagine diversa”. La prima spiegazione è anch’essa ragionevole, per quanto valga anche per opere meno diffuse; mentre piuttosto oscuro è il collegamento con la realtà geografica, che andrebbe chiamata in causa ove l’obiettivo dell’edizione fosse legato a un preciso contesto d’uso (come però non parrebbe), e non alla sua composizione.
L’edizione sulla base di un codex potior emendato con l’apporto di altri è, per sua natura, un’edizione eclettica e provvisoria, perché più approfonditi studi sulla tradizione possono portare in seguito a miglioramenti considerevoli. Di questo gli editori mostrano piena consapevolezza, espressa nella Introduzione generale di Edoardo D’Angelo. Tale introduzione reca il significativo sottotitolo I perché e i come di un’edizione impossibile, che denuncia insieme la fierezza per l’impresa realizzata e la consapevolezza dei suoi limiti; e tutta l’introduzione si sviluppa poi fra questi due binari.
Il discorso è forse un po’ troppo apologetico, e scivola talvolta in un’inutile polemica preventiva – ci ha ricordato certe prefazioni di opere medievali, nelle quali gli autori si scagliavano contro detrattori-fantasma per magnificare i pregi del loro lavoro – nella quale si ridicolizzano i “maestrini della filologia”, ossia quelli che “davanti a un quadro bellissimo si preoccupano soltanto di notare, ed eventualmente eliminare, la macchiolina infinitesimale nell’angolo in basso a sinistra”, e nella quale si evocano modelli di edizioni eroiche e ‘benemerite’, ancorché ampiamente perfettibili, come la Patrologia del Migne.
I principi metodologici e gli obiettivi del lavoro sono espressi con encomiabile chiarezza. “Sebbene si basi fondamentalmente su un manoscritto, la presente edizione non intende però adottare il metodo bédierano (sic) del bon manuscript… Questa edizione, invece è guidata da un principio di condotta assolutamente e semplicemente pragmatico: quello di fornire, innanzitutto, un testo leggibile e corretto nella forma e nella sostanza, stabilito sì sulla base di un unico manoscritto, ma scelto con criterio e costantemente vigilato. Innanzitutto perché quel manoscritto è antico, e – sebbene si resti consapevoli che i codici antiquiores non siano necessariamente potiores – offre, quindi, lezioni che sono state meno esposte ai costanti filtri e adattamenti che solitamente hanno subìto quel tipo di raccolte. Inoltre, perché, quando ci si è resi conto che il testo era corrotto e andava necessariamente sanato, ci si è premurati di consultare altri codici, talvolta anche all’esterno della redazione P6” (il grassetto è nostro). L’alternativa – possibile, anche se con un enorme aggravio di lavoro – di un’edizione “in qualche misura lachmanniana”, cioè preparata attraverso la ricostruzione di uno stemma codicum, poteva essere praticata solo lettera per lettera, e non per l’insieme della raccolta, “col risultato che non si pubblicherebbe più l’Epistolario, (in una delle sue forme strutturate), così concepito dal compilatore”. Altrettanto chiaro è il limite dell’edizione, che “non ha intenzione di rappresentare in nessun modo una forma di testo definitivo, data l’impossibilità di una formulazione di un qualunque stemma codicum, ma semplicemente di costituire un punto d’appoggio, scientificamente aggiornato e rigorosamente codificato, per una lettura della silloge vineana. Il suo còmpito è piuttosto quello di costituire un deposito di materiali di partenza per chi affronterà in maniera sistematica la complessità della tradizione dell’Epistolario, per fornire un’edizione critica, se sarà possibile, di impostazione in qualche modo lachmanniana (o neolachmanniana)” (p. 27).
L’obiettivo è dunque la pubblicazione della “raccolta”, che ha una sua consistenza e una definizione data dal redattore che ha assemblato in un insieme progettualmente coerente dei documenti sparsi. Interessanti sono del resto le considerazioni metodologiche sul rapporto esistente fra raccolta e singolo documento, e sulle strategie necessarie per l’edizione di una raccolta, diverse da quelle che si seguono per singole parti. Se però l’obiettivo è l’edizione della raccolta P6, meno comprensibile è allora il già citato ricorso alla ‘tradizione stravagante’, dove i singoli documenti circolano scorporati: questa fase di trasmissione è precedente a P6, e perciò non dovrebbe interferire con la ricostruzione di questa redazione; semmai può essere utilizzata come strumento di controllo in fase di selectio fra varianti concorrenti di diversi testimoni P6.
Quella dell’Epistolario è un’edizione ‘a più mani’, che si gioca cioè nella dialettica fra un coordinamento centrale e l’opera dei vari collaboratori, ognuno incaricato di una parte. La scelta è stata quella di dare spazio al singolo curatore, sia nella prassi editoriale (“data una base ampia e affidabile comune di ulteriore documentazione [il riferimento è ai codici di controllo] il singolo editore ha potuto muoversi in maniera abbastanza libera, soprattutto perché le lettere coinvolgono problematiche assai differenti e complesse” (p. 26). E si ribadisce che “nel quadro di una complessiva omogeneità metodologica si è comunque lasciato margine di libertà ai singoli editori, consci del fatto che il lavoro dell’editore critico necessita sempre un margine di autonomia – e per questo di responsabilità – incomprimibile” (p. 33). La stessa libertà è stata concessa al curatore in sede di traduzione: “si è scelta la strada di lasciare sostanzialmente liberi i diversi autori delle traduzioni, in modo da offrire al lettore e al fruitore del lavoro una più ampia gamma di possibilità di resa in lingua moderna del testo vineano”. La spiegazione non convince molto – sarebbe sensata se si trattasse di traduzioni alternative dello stesso testo, ma qui si tratta di traduzioni di testi differenti – ma si attaglia con il livello di coordinamento dichiarato: ampia responsabilità ai singoli collaboratori, in un progetto con precise, ma schematiche, linee-guida comuni.
All’interno del volume, la traduzione ha uno spazio particolare, e anche di questo il curatore è ben consapevole: “Ogni epistola è stata tradotta in italiano. Questa è forse l’iniziativa più innovativa, perché è la prima volta che si è compiuta un’impresa simile; rischiosa, certamente, per la involuta complessità dello stile retorico, l’enfatico stilus supremus, congiunto alle poliedriche implicazioni contenutistiche, espresse mediante il ricorso a un linguaggio tecnico assai vario…, ma necessaria a una più completa comprensione e fruizione del testo” (p. 36). L’intento è encomiabile, e l’impegno che comporta la traduzione per un testo del genere è evidente. Tuttavia crediamo che questo sia il punto più debole dell’intero volume, e che apra spiragli inquietanti anche sull’aspetto più strettamente filologico. Per i testi mediolatini, che hanno in genere una storia di studi ancora breve, l’azione del tradurre presenta connotati schiettamente filologici, perché è attraverso di essa che ci si assicura una piena comprensione del testo, sfuggendo alla scorciatoia di accettare per buono quello che si capisce poco: la traduzione è un’importante e necessaria verifica, per una via potente come quella permessa dall’intertestualità linguistica, della correttezza dell’edizione, e non un semplice accessorio a destinazione divulgativa. Nel caso dell’Epistolario, la traduzione – ma si dovrebbe parlare di “le traduzioni”, visto che i vari curatori hanno interpretato in modo davvero autonomo il loro compito: basta guardare come diversamente è tradotto un documento che è di fatto il medesimo, ma riportato due volte nella raccolta, a III 84, ad opera di Roberto Gamberini, e a V 102, ad opera di Edoardo D’Angelo – talvolta non è chiara, e non facilita al lettore, neppure italiano, la comprensione del testo. Si potevano fare due scelte: una era quella semplificare al massimo lo stile, con l’obiettivo di permettere la piena intelligibilità dei contenuti; l’altra quella di tentare di riprodurre la prosa d’arte cancelleresca, ma in questo caso ci si doveva attestare su un medium stilistico, cioè su un linguaggio italiano retorico e preciso, non burocratico e farraginoso. L’impressione è che alcuni dei traduttori abbiano preso un po’ sottogamba il loro compito: tradurre in italiano, senza troppi problemi, cercando di spiegare il contenuto del latino attenendosi per lo più a una versione pedestre.
Purtroppo un tale sistema è un po’ superficiale, e non rende buoni servigi al lettore. Prenderemo due casi a campione, ma molti altri potrebbero essere chiamati in causa. La lettera I 18 inizia così (in corsivo i passaggi che discuteremo più avanti):
Satis nos pungit interius res noua, quam scribimus, immo nostra medullitus interiora perturbat, dum ibi nouiter inquietamur amarius, ubi quietis dulcedinem studiosius procuramus; inde crudeliter ledimur et impetimur imprudenter, unde pacis deberet hodie prodire charitatiua religio et beatitudinis zelus a fidei nostrae cultoribus expectatur. Iste siquidem summus pontifex pastor ecclesiae – qui quantum nos iniuriis prouocarit, affectionis uestrae notitiam scire confidimus, nec mundus ignorat – sagittas acutas emittit de pharetra, dum satis sibi fore non aestimans in Ytaliae partibus continuis iaculis impetisse nos hactenus, nisi nunc in peculiaris Regni nostri pomerio, quod materna nobis decrevit hereditas, spinas interserat, et nostrorum corda fidelium, quae fidelitas natiua consolidat, a nostra deuotione subuertat, pro Lombardorum negotio, cuius occasione pacis tractatui semper impedimenta paraverat et in quo tocies uoluntatem eius inuenimus duriorem, quocies uoluntatis ad pacem signa monstrauimus prompciora.
La traduzione è la seguente:
Ci punge sensibilmente nell’intimo la cosa straordinaria di cui scriviamo, anzi turba profondamente il nostro cuore, poiché allora sorprendentemente siamo inquietati più amaramente, quando ricerchiamo con più attenzione la dolcezza della quiete; e lì siamo colpiti crudelmente e siamo assaliti imprudentemente, dove oggi la caritatevole religione della pace dovrebbe progredire e lo zelo della beatitudine è atteso dai cultori della nostra fede. Se certamente questo sommo pontefice pastore della Chiesa – quanto grandemente ci abbia ultimamente provocato con le sue ingiurie, confidiamo che lo sappia la consapevolezza del vostro affetto, né il mondo lo ignora – estrae le acute frecce dalla faretra, stimando che non sia abbastanza per lui averci attaccato finora, nei territori dell’Italia, con i suoi continui dardi, ora anche entro i confini del nostro specifico Regno, che l’eredità materna ci ha assegnato, dissemina spine, e perverte dalla devozione nei nostri confronti i cuori dei nostri fedeli, che la nativa fedeltà rende saldi, adducendo a ragione la questione della Lombardia, in occasione della quale aveva sempre posto ostacoli al trattato di pace, mentre, da parte nostra, tutte le volte che trovammo più ostile la sua volontà, altrettante mostrammo segnali di volontà più pronta alla pace.
Si potrebbe discutere di alcune scelte stilistiche – la quantità di avverbi di modo; la lunghezza della seconda proposizione, che forse sarebbe stato meglio interrompere; espressioni come ‘la consapevolezza del vostro affetto’, che per quanto letterali sono un po’ ridicole –, ma esse rientrano pur sempre nella facoltà ‘creativa’ del traduttore. In alcuni punti però il lettore si sente in imbarazzo, perché gli sembra di non capire bene il testo; in realtà non è tutta colpa sua, ma in parte si deve alla traduzione imprecisa o fuorviante. Abbiamo evidenziato in corsivo questi passaggi.
1) noua… nouiter: la duplicazione del termine mostra l’importanza della cosa per chi sta scrivendo, e avrebbe dovuto essere sottolineata. Il nouum di cui sta parlando Federico non è semplicemente una cosa ‘sorprendente’ o ‘straordinaria’ (aggettivo, per altro, che in italiano ha in genere una connotazione positiva), ma una cosa ‘eversiva’.
2) quando ricerchiamo con più attenzione la dolcezza della quiete: dalla traduzione Federico sembrerebbe un vecchio sovrano stanco di combattere, che il perfido papa non smette di tormentare. In realtà la frase dice tutt’altro: anzitutto si parla di luoghi e non di tempi (ibi… ubi), e la funzione di Federico, espressa dal verbo procuramus, è politicamente quanto mai attiva: “nel luogo per il quale noi facciamo di tutto per instaurare una dolce pace, proprio in quel luogo ci si lancia contro un’amara guerra”
3) inde… unde: ancora un contrasto locale: “siamo colpiti e assaliti proprio da quella parte… da dove dovrebbe uscire…” (questo il significato di prodire; ‘progredire’ è evidentemente sbagliato).
4) imprudentemente: perché mai ‘imprudentemente’? Sembra un avvertimento al papa – l’attacco all’imperatore è ‘imprudente’ perché potrebbe avere cattive conseguenze per lui – ma null’altro nel contesto va in questa direzione: Federico si sta lamentando della gravissima scorrettezza del pontefice, non lo sta minacciando. Forse il testo originario aveva impudenter, che sarebbe molto più adatto; se si vuole accogliere imprudenter, in omaggio al codex potior, la traduzione deve essere più interpretativa: imprudenter significherà ‘contro la prudentia’, nel senso della virtù medievale che si addice a un sovrano, e perciò ‘contro i principî del retto governare’.
5) siquidem: la traduzione “se certamente” (che sembra derivare da una separazione si quidem) non corrisponde al valore della congiunzione nel latino dell’epoca, che è invece causale-esplicativo (‘perché’, ‘infatti’). Nella frase si dice in che cosa consiste la res noua, senza alcuna valenza ipotetica. La miglior traduzione era forse omettere del tutto la congiunzione e creare un forte asindeto con un punto fermo.
6) ultimamente non è nel testo latino; l’aggiunta dell’avverbio, che limita l’estensione temporale dell’offesa, riduce la forza dell’espressione.
7) che la nativa fedeltà rende saldi: l’espressione indica il vincolo feudale, ma il lettore capisce invece che gli abitanti del regno meridionale siano fedeli per loro innata disposizione: “i cuori dei nostri fedeli, che sono tenuti a fedeltà per dovere di nascita”.
8) mentre, da parte nostra, tutte le volte che trovammo più ostile la sua volontà, altrettante mostrammo segnali di volontà più pronta alla pace. La successione logica prospettata dal testo latino è esattamente quella opposta: non è Federico che mostra maggior disponibilità alla pace tanto più il papa si indurisce (un atteggiamento, per altro, che sarebbe un po’ stupido sul piano politico), ma è il papa che si indurisce sempre di più ogni volta che Federico si mostra disponibile alla pace: la colpa ricade dunque sul papa.
Al di là degli errori, o delle cose che potrebbero essere dette più chiaramente, il problema è che una traduzione così non permette al lettore un miglior avvicinamento al testo.
Un secondo caso prendiamo da I 7. Il testo latino è:
Quia, cum idem blasphemator noster ausus alibi non fuisset in nostri nominis blasphemiam prorupisse, de tanta praesumptione gloriari non possit, quod ualentibus et uolentibus Romanis, contra nos talia perpetrasset, cum post id posset uestrae magnitudini imputari: si quod autem fuit, impedire laudabiliter potuistis, et post factum nostram et uestram iniuriam postponatis inultam.
La lettera è indirizzata ai nobili di Roma, che Federico accusa di connivenza, o quanto meno di acquiescenza, alla scomunica inflittagli dal papa. Nella frase precedente il sovrano ha ingiunto loro di insorgere a vendicare quello che egli considera un oltraggio portato non solo a lui, ma anche ai Romani stessi; il quia iniziale introduce appunto i motivi per cui i Romani devono intervenire. La traduzione è la seguente:
Perché, poiché lo stesso nostro calunniatore non avrebbe osato altrove prorompere nel vilipendio del nostro nome, non possa gloriarsi di tanta audacia che, con l’assenso e la partecipazione dei Romani, abbia perpetrato contro di noi tante nefandezze, considerando che ciò si potrebbe ben mettere in conto alla grandezza vostra: se ciò che è stato prima compiuto, avreste potuto impedirlo, e dopo il fatto lasciate invendicata l’ingiuria da noi e da voi subita.
La traduzione è ben poco comprensibile. Il lettore fatica a rintracciare la costruzione logica del periodo, si fa l’idea che il linguaggio della lettera sia volutamente oscuro, magari per rendere il tono più allusivo e minaccioso, e si chiede quale potesse essere l’esito politico di un messaggio tanto astruso. Ma non è così. Federico insiste sul fatto – già in precedenza richiamato nella lettera – che il papa poteva compiere un atto simile soltanto a Roma, perché in nessun altro luogo gli sarebbe stato permesso. Osserviamo che:
- Nel testo, la virgola dopo Romanis è fuorviante: la proposizione è quod ualentibus et uolentibus… perpetrasset;
- I due punti dopo imputari sono altrettanto sbagliati: si tratta delle possibili accuse che possono essere rivolte ai Romani, e dipendono strettamente da quel verbo.
- La subordinata quod… perpetrasset esprime il contenuto della praesumptio: la traduzione dovrebbe essere “non si possa vantare di aver fatto ciò che ha fatto con il pieno consenso dei Romani”.
- L’espressione post id posset uestrae magnitudini imputari è molto problematica, e la difficoltà si riflette sulla traduzione; ma meno lo diventa se si va a vedere il manoscritto P (e il resto della tradizione). Al posto di uestrae nel codice è scritto nostrae, e con nostrae la frase diventa chiara, anche se cambia senso: “dopo questo fatto possono essere portate a imputazione davanti alla nostra maestà due cose: il fatto che avreste a buon diritto potuto impedire quanto è avvenuto, e, una volta avvenuto, il fatto che eludiate di vendicare l’ingiuria arrecata a noi e a voi”. In effetti, magnitudo non sembra un termine adatto ai Romani, mentre è adattissimo se riferito a Federico.
- La traduzione di si quod autem fuit con “ciò che è stato prima compiuto” è pure problematica, perché vi compare la parola ‘prima’ che in latino non c’è (anche se certo fuit indica un’anteriorità). Il codice P in questo punto non è chiaramente leggibile, almeno nella riproduzione on-line in Gallica; la parola autem (sintatticamente problematica dopo il si ipotattico) potrebbe essere ante, che darebbe senso, e ante è segnata come varia lectio nell’apparato dell’edizione Iselin. Ci chiediamo se l’editore-traduttore non abbia operato un’interferenza fra due lezioni alternative su cui era in dubbio, e se questa incertezza non si rifletta nella sua traduzione; l’apparato critico però non dice nulla di tutto questo.
Nei prolegomeni dell’edizione (p. 27), il metodo del codex potior rettificato con l’ausilio di altri manoscritti è giustificato anche con l’appello all’autorità di Giovanni Orlandi, del quale viene riferita una frase tratta dal suo saggio forse più famoso: “dovendo rassegnarsi a intraprendere edizioni provvisorie di testi patristici o mediolatini dalla trasmissione sconfinata… una condotta pragmatica come quella del Lachmann, fondata su una scelta anche violenta e talora aprioristica di testimoni e sul tenersi le mani libere nella constitutio textus (fatta salva l’individuazione dei gruppi principali dei mss. utilizzati, ma senza insistere nel delineare uno stemma troppo rigido) può ancora rendere buoni servigi”. La citazione è corretta, ma per non far torto al suo autore bisognerebbe ricordare due cose. Orlandi considerava questo metodo provvisorio, ma valido, perché permette di “tenersi le mani libere nella costitutio textus”: non come rassegnazione alla lezione del manoscritto migliore, dunque, ma al contrario come stimolo a superarla. In secondo luogo, e più importante,Orlandi, nello stesso saggio, insiste molto sul fatto che una buona edizione di un testo fa leva anzitutto su una profonda comprensione della lingua in cui il testo studiato è stato scritto, e questo indipendentemente dalle possibilità di ricostruzione stemmatica: “un’esplorazione sistematica delle fonti e della lingua è, per i testi medievali, altrettanto urgente quanto quella della tradizione ms…. Altrimenti si possono collazionare codici a centinaia e poi approdare a un disastro editoriale”. Il codex potior è perciò una scelta accettabile, quando non è possibile sondare per intero la tradizione, come in questo caso; ma il prezzo del risparmio nelle collazioni dovrebbe essere una migliore cura nell’interpretazione linguistica, senza sottovalutare l’importanza scientifica della traduzione.