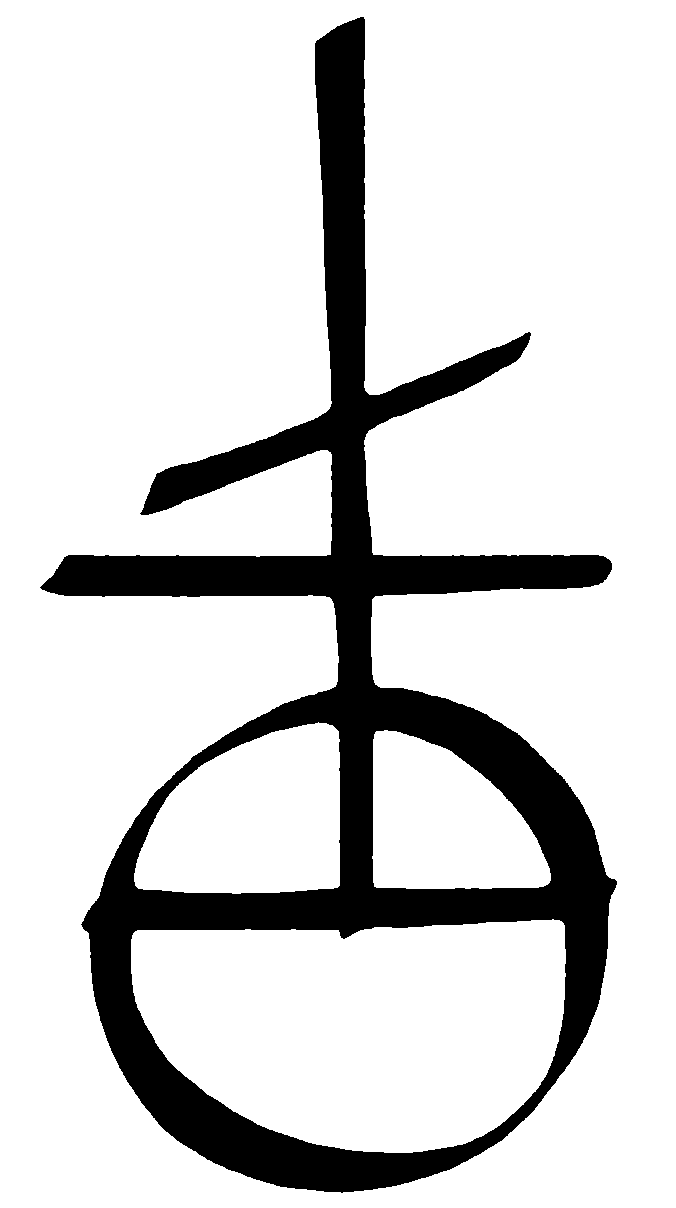Titolo: Toronto Medieval Latin Texts
Ambito cronologico: medioevo
Ambito linguistico: latino
Curatori: A. G. Rigg, David Townsend
Tipologia di edizione: collana che pubblica edizioni su testimone unico, con finalità didattiche, ma anche scientifiche
Sede di pubblicazione: Centre for Medieval Studies by the Pontifical Istitute of Mediaeval Studies, Toronto
Anno di pubblicazione: 1972-2018
Lingua di pubblicazione: inglese
Autore della recensione: Paolo Chiesa
Tipologia del contributo: recensione
Informazioni aggiuntive: Esame complessiva della prassi editoriale della collana (35 volumi pubblicati in 40 anni)
Parole chiave: collana
I Toronto Medieval Latin Texts, pubblicati dal 1972 sotto la direzione dapprima di A. G. Rigg, poi (dal 2008) di David Townsend, sono nati secondo un’impostazione editoriale molto precisa, che hanno poi coerentemente mantenuto. Nel corso del tempo sono divenuti uno strumento di largo uso, noto a tutti i medievisti, anche per la loro accessibilità. A quarant’anni dalla sua fondazione, la serie merita un breve esame complessivo; lo scopo non sarà tanto valutarne i risultati, che appaiono in ogni caso positivi, quanto misurare l’attualità di un presupposto scientifico che all’epoca destò un certo dibattito.
La dichiarazione programmatica, ripetuta all’inizio di ogni volume, è la seguente: «The series is intended primarily to provide editions suitable for university courses and curricula, at a price within the range of most students’ resources… Editions in this series are usually based on one manuscript only, with a minimum of textual apparatus; emendations are normally made only where the text fails to make sense, not in order to restore the author’s original version. Editors are required to elect their manuscript with great care, choosing one that reflects a textual tradition as little removed from the original as possible, or one that is important for some other reason (such as a local variant of a text, or a widely influential version). Manuscript orthography and syntax are carefully preserved».
Questa dichiarazione si concretizza poi, in ogni singolo volume, in una nota editoriale specifica per quel determinato testo. In tali note si dà conto, oltre che del manoscritto adottato e delle ragioni per cui è stato scelto, delle deroghe che sono state fatte rispetto al codex potior, nonché di altri eventuali accorgimenti; si precisano inoltre le norme grafiche, sempre improntate alla maggior conservatività possibile rispetto al testimone unico.
La posizione è molto chiara, ma non priva di problematicità. Espliciti, anzitutto, sono gli obiettivi cui si mira e il pubblico cui ci si rivolge: i volumi si propongono essenzialmente come strumenti didattici, di costo economico tale da poter essere proposti agli studenti, e costituiscono un’alternativa alle «expensive scholarly editions equipped with full textual apparatus but with little or no annotation for students». Accanto a questo obiettivo didattico, però, è evidente che vi sono anche altri presupposti, più strettamente scientifici. Se si volesse semplicemente proporre un’edizione ‘accessibile’, ‘semplificata’, ‘economica’, si potrebbe altrettanto semplicemente produrre una riduzione commentata di edizioni critiche maiores, senza proporre la trascrizione di un singolo manoscritto di cui vengono conservate tutte le caratteristiche testuali; nel caso dell’Historia calamitatum, si potrebbe ad esempio produrre una riduzione della recente edizione Luscombe. Per altro, se si esaminano i volumi pubblicati nel corso degli anni (33 in tutto), si vede che molti si riferiscono a testi fino a quel momento inediti, o privi di un’edizione critica qualchessia; in questi casi non si tratta evidentemente di un’operazione divulgativa, ma di un più alto impegno scientifico.
Questa duplice valenza – didattica per la destinazione, scientifica per i criteri editoriali – appare chiara se si riguarda la discussione che accompagnò la nascita della collana, negli anni Settanta. La sua impostazione metodologica fu duramente contestata da G. B. Hall, che recensendo una delle prime edizioni della serie – quella di un’antologia poetica contenuta in un codice di Glasgow (A Thirteenth Century Anthology of Rhetorical Poems, ed. B. Harbert, Toronto 1975) – bollò il metodo della scribal version cui era improntata come contrario al «respect of the truth», assicurato invece dalle edizioni scientifiche. Il direttore Rigg rispose che la collana non intendeva porsi in concorrenza con le edizioni critiche tradizionali, ma fungere da strumento didattico per la lettura di testi della latinità medievale. Aggiungeva però che l’adesione a un singolo codice aveva «for the medievalists at least, its own interest», in quanto permetteva di attingere la forma reale della lingua dell’epoca, come testimoniata dai copisti stessi. Su questo secondo versante, la serie ha certamente delle ambizioni scientifiche: nella sua risposta, Rigg dichiara che la posizione ‘regolarizzante’ di Hall in materia ortografica finisce per violare le consuetudini medievali, ed essere antistorica (Gli interventi principali nella discussione sono i seguenti: J. B. Hall, The Editing and Emendation of Medieval LatinTexts, «Studi medievali», III ser. 19 (1978), pp. 456-66; A. G. Rigg, The Editing of Medieval Latin Texts: A Response «Studi medievali», III ser. 24 (1983), pp. 385-8; J. B. Hall, A Reply to Dr. Rigg’s ‘Response’, ivi, pp. 385-7; F. Bertini, Recenti edizioni di testi latini del XII secolo: esperienze e polemiche, in Grafia e interpunzione del latino nel medioevo, a cura di A. Maierù, Roma, 1987, pp. 103-12A. G. Rigg, The Editing of Medieval Latin Texts: A Response, «Studi medievali», III ser. 24 (1983), p. 387*; G. Orlandi, Perché non possiamo non dirci lachmanniani, «Filologia mediolatina» 2 (1995), pp. 1-42, alle pp. 29-38 [ora in G.O., Scritti di filologia mediolatina, Firenze 2008, pp. 94-130, alle pp. 118-30]. G. Rigg, Medieval Latin, in Editing Medieval Texts: English, French and Latin Written in England, a cura di A. G. Rigg, New York, 1977, pp. 107-25). Un dibattito in seguito passato in sordina, o piuttosto non più riproposto esplicitamente, ma che ci sembra ancora piuttosto attuale; se non altro perché i problemi allora discussi sono quelli che si pongono quotidianamente agli editori critici.
Alcuni dei testi pubblicati nella collana sono conservati in testimone unico, e non si pone il problema della scelta del codex potior; inoltre, in questi casi appare psicologicamente più facile per l’editore seguire senza sensi di colpa il dettato del manoscritto. Nel caso delle Collationes de beata virgine di Nicola da Milano, il codice unico è il Fiorentino Nazionale Conv. soppr. G.7.1464, e la conservatività del testo pubblicato, nelle parole dell’editrice M. Michèle Mulchahey, sembra derivare da tale unicità («B e c a u s e this edition of the Collationes de beata virgine is based on a single manuscript, every effort has been made to render the text as it survives there as faithfully as possible», Fra Nicola da Milano, Collationes de beata virgine, ed. M. M. Mulchahey, Toronto 1997, p. 32, giungendo anche alla replica delle note duplicate), ancor più che dalle regole della collana. Ugualmente in un solo manoscritto (Cotton Vespasianus D xix) si leggono i Miracula Mariae di Nigello di Canterbury, pubblicati da Jan Ziolkowski (Nigel of Canterbury, Miracles of the Virgin Mary, in verse, ed. J. Ziolkowski, Toronto 1986); un’opera chiamata Oculus pastoralis, pubblicata da Terence Turnberg (si tratta del manoscritto che ha la bizzarra segnatura Cleveland, Public Library, MS Wq 7890921M-C73) (Speeches from the Oculus pastoralis, edited from Cleveland, Public Library, Ms. Wq 7890921M-C37 by Terence O. Tunberg, Toronto 1990); e il trattato Ex diversis auditis in scola magistri Willelmi de Monte di un presbitero di nome Samuele presbiter (ms. Oxford BL Bodl. 860) (Samuel presbiter, Notes from the school of William de Montibus, edited from Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 860 by A. N. J. Dunning, Toronto 2016).
Quando invece si tratta di un’opera a tradizione plurima, si pone il problema della scelta del codex potior, e insieme si creano le condizioni per l’impiego di altri codici di controllo. La casistica delle soluzioni presentate è qui piuttosto interessante, e può servire anche come screening delle possibili strade con cui si affrontano tradizioni anche molto numerose.
Un criterio adottato per alcune edizioni della collana è quello dell’antichità del codice; un criterio che può considerarsi author oriented, dato che il privilegio dei codici più antichi è quello di rappresentare potenzialmente meglio il testo originario. Sulla base di questo criterio H. C. Kim individua come codex potior per la sua edizione del diffusissimo Evangelium Nicodemi il manoscritto Einsiedeln, Stiftsbibliothek 326: «the reason for the choice of this MS as the basis for my edition is that Thilo, Tischendorf and others agree about its antiquity; in the absence of any other MS that is known to be older or more authoritative, I have accepted their judgement (The Gospel of Nicodemus. Gesta Salvatoris, ed. by H. C. Kim, Toronto 1973)». Al codice di Einsiedeln se ne affianca un altro – scelto stavolta, sembrerebbe, per pura comodità di reperimento – che viene utilizzato per emendare il primo quando esso è insostenibile: il Bodleiano Laud. misc. 79. L’antichità è anche alla base della scelta del testimone potior della Stella clericorum, un trattato di divulgazione teologica diffusissimo nel basso medioevo (se ne contano oltre 450 manoscritti): l’editore, Eric Reiter, adotta il codice conservato nel monastero di Stavelot (Saint-Rémacle a Wavreumont), perché è «one of the two earliest», mentre il testimone di controllo utilizzato è il Vorau 354, che è l’altro più antico («roughly contemporary copy»). A ben vedere si tratta di un’antichità abbastanza relativa, perché entrambi risalgono al tardo XIII secolo mentre il testo, a giudizio dell’editore, risalirebbe a un secolo prima (Stella clericorum, ed. E. H. Reiter, Toronto 1997).
L’esigenza di scegliere un testimone che rappresenti al meglio l’‘originale’ appare in modo ancor più spiccato in alcuni casi dove la scelta ricade su un codice che è vicino – o si suppone lo sia – all’autore dell’opera. Per gli scritti mariani di Filippo di Mézières l’editore, William Coleman, prende come testo-base il Parigino lat. 17330; la ragione non è spiegata chiaramente, ma si ricava dalla descrizione del manoscritto, secondo la quale esso fu di proprietà dell’autore stesso (Philippe de Mézières’ Campaign for the Feast of Mary’s Presentation, ed. W. E. Coleman, Toronto 1981, p. 20). Per la diffusissima commedia elegiaca Geta, Keith Bate preferisce «a manuscript which is nearest in both time and space to the original», cioè il Bernese 702, del quale «age and provenance make it the most important manuscript». Il codex potior viene emendato – senza per altro mai «radical changes in meaning» – sulla base di altri tre, scelti stavolta con criteri casuali; ma nelle speranze dell’editore «the result… is a text very close to that which Vitalis intended for a Loire Valley audience». Al criterio della vicinanza all’‘originale’ si affianca qui un criterio che è invece orientato alla fruizione: una possibilità prevista nelle premesse metodologiche della serie, dove si parla fra l’altro dell’opportunità di pubblicare qualche «local variant of the text» (Three Latin Comedies, ed. K. Bate, Toronto 1976, p. 6). Ma l’editore sembra considerare il Geta una vera e propria commedia rappresentata, perché presenta una premessa metodologica in cui si dice che il testo del Geta cambia considerevolmente nel tempo e nello spazio; non si devono, ad esempio, includere giochi di parole adatti a un pubblico tedesco, e che è il vero cavallo di battaglia della cosiddetta New Philology, ai cui dettami la collana di Toronto si ispira. Il codice di Berna rappresenta da solo una famiglia stemmatica; l’editore, dove serve emendarlo, deve perciò chiamare in causa testimoni di altri gruppi, e sembra rammaricarsene, probabilmente perché questo rischia di allontanare l’edizione dalla rappresentazione ‘pura’ di quanto si leggeva al tempo nella valle della Loira. Ancora un doppio criterio viene seguito nel caso del poema sulla Genesi di Avito di Vienne. Daniel Nodes sceglie il codice carolingio Laon 273, che contiene una collezione di testi poetici in uso nella scuola, adducendo sia ragioni testuali, sia ragioni di fruizione: il manoscritto appartiene alla famiglia tradizionale «nearest the time and place of the original composition», e insieme rappresenta «the ideal class book for the medieval school», fin dal formato, che è quello di un liber manualis (Avitus, The Fall of man: de spiritalis historiae gestis libri I-III, edited from Laon, Bibliothèque municipale, MS.273, by Daniel J. Nodes, Toronto 1985, pp. 10-11). Il testo del codice di Laon viene corretto – come sempre, solo quando necessario – sulla base di un altro manoscritto che appartiene al medesimo secolo e alla medesima famiglia (Leida, Voss. lat. Q. 86).
In qualche caso il criterio seguito è quello della maggiore completezza del testimone; che è un altro criterio author oriented. Molto dettagliate sono le motivazioni della scelta del codex potior per il Templum Dei di Roberto Grossatesta, anche questa un’opera molto diffusa (se ne contano un centinaio di manoscritti). In questo caso la scelta non è stata aprioristica: gli editori, Joseph Goering e F. A. C. Mantello, dichiarano di avere preso in considerazioni 65 codici, e di aver progressivamente proceduto a eliminazione sulla base di vari criteri: sono stati esclusi i manoscritti frammentari, quelli lacunosi, quelli che non si potevano fotografare perché troppo strettamente rilegati, quelli in cui le rappresentazioni di schemi – di cui l’opera è piena – vengono ricondotte a semplice testo in prosa. La scelta è ricaduta infine sul codice Cambridge, Emmanuel College 27, perché «complete and relatively free of unusual and idiosyncratic variants or significant lacunae and other glaring scribal blunders, it typifies well the mainstream of the textual tradition» (Templum Dei, edited from Ms. 27 of Emmanuel College, Cambridge, by Joseph Goering, and F. A. C. Mantello, Toronto 1984, p. 16). Un codice perciò che ha il pregio di essere piuttosto antico, e che sembra rappresentare meglio la forma
originaria dell’opera; ma che insieme riporterebbe una sorta di ‘testo standard’ (un criterio, invece, che sembrerebbe public oriented). Su quale base però si sia stabilito che questo testo è più comune o ‘normale’ degli altri non è spiegato, se non per il generico riferimento alla scarsa varianza individuale. La completezza è chiamata in causa come fattore discriminante anche nel ben più semplice caso della Vita Thome attribuita a Gualtiero di Châtillon: i codici sono solo due, e fra essi Carsten Wollin preferisce il Vaticano Reg. lat. 344 perché l’opera presenta qui un numero maggiore di versi rispetto all’altro testimone, il Bodleiano lat. 603 (Saintsʼ lives by Walter of Châtillon: Brendan, Alexis, Thomas Becket, ed. by C. Wollin, Toronto 2002).
Anche per la Disputatio puerorum attribuita a Alcuino (su basi insufficienti, a parere degli editori) la scelta del manoscritto è fatta per ragioni di completezza; ma stavolta gli editori, Andrew Rabin e Liam Felsen, chiamano in causa anche un criterio stemmatico. Viene pubblicato il testo del codice Viennese 458, che insieme al Monacense Clm 5257 è quello che riporta l’opera nella sua forma più ampia; fra i due, però, il Viennese «is the one that appears to approximate most closely the Urtext», perché rappresenta da solo un ramo della prima bipartizione dello stemma, mentre l’altro prevede uno snodo intermedio (The Disputatio puerorum. A Ninth-Century Monastic Instructional Text, edited from Vienna, Österreichisce Nationalbibliothek, 458 by A. Rabin and L. Felsen, Toronto, 2017, p. 6). Una scelta molto bédieriana; ma come sia stato costituito lo stemma non viene spiegato. Interessante è quanto emerge nella successiva discussione sull’autorialità del testo, cioè che il codice prescelto è l’unico a presentare una frase che non sembrerebbe compatibile con l’attribuzione tradizionale a Alcuino (Ibidem, p. 12); la frase in più è certamente un’aggiunta redazionale – d’autore o no –, e almeno in questo punto il manoscritto usato si direbbe più distante dall’Urtext rispetto a quello che poteva essere scelto in alternativa. La vicenda è anche sintomatica del circolo vizioso che può instaurarsi se il testo del codice prescelto viene considerato testo tout court: un fatto presente in quel solo manoscritto dà il destro per un’interpretazione generale dell’opera in quanto tale. Se fosse stato scelto come codex potior il Monacense, non si sarebbe potuto invocare quel passo ai fini attribuzionistici.
Altre volte criteri fruizionali prevalgono nettamente, con uno spettro di accezioni piuttosto vasto. Ciò che porta Jeremy Reedy a scegliere come testimone privilegiato delle Genealogiae deorum del Boccaccio il manoscritto University of Chicago, Joseph Regenstein Library, 100, è il fatto che il codice venne copiato su incarico di Coluccio Salutati («the fact that C was written for Coluccio makes it of special interest to students of medieval literature») (Boccaccio in Defence of Poetry: Genealogiae deorum gentilium Liber XIV, edited from University of Chicago MS. 100 by Jeremiah Reedy, Toronto 1978); il testimone di controllo è in questo caso un’edizione critica, quella pubblicata da Vincenzo Romano nel 1951ì (Giovanni Boccaccio, Genealogie deorum gentilium libri, Bari 1951). Per il diffusissimo De proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico, di cui si pubblicano due libri, la scelta di R. James Long ricade su un manoscritto posseduto da un maestro illustre, Goffredo di Fontaines (si tratta del Parigino lat. 16098). A questa scelta concorrono la datazione alta del codice e la sua (presumibile) importanza nella scuola, applicando in parte un altro dei criteri programmatici della collana, cioè quello di privilegiare una «widely influential version». A queste ragioni se ne aggiunge una di carattere più strettamente testuale: il codice parigino appare superiore alle «uncorrected versions of all the other manuscripts» che l’editore ha potuto esaminare, e perciò presenterebbe un testo «more ‘sincere’» degli altri testimoni antichi (Bartolomaeus Anglicus, On the Properties of Soul and Body. De proprietatibus rerum libri III et IV. Edited from Bibliothèque Nationale ms. Latin 16098 by R. James Long, Toronto 1979, p. 10). Nel caso di Bartolomeo i testimoni di controllo sono tre – il Parigino lat. 16099, il Londinese Add. 24074, l’edizione di Francoforte del 1601 – collocati, a quanto si capisce, in una precisa gerarchia: quando la lezione del codice-base è priva di senso, e quella di uno di questi (esaminati nella successione indicata) è invece accettabile, si colloca a testo quest’ultima. Nell’esporre questa strategia di lavoro l’editore sembra però in difficoltà: l’obiettivo è riprodurre A, e lo si sceglie anche quando sarebbe meglio non farlo («wherever the readings of A were tolerable, I chose them over B / B2, even where the latter were technically or grammatically preferable [corsivo mio]. In such cases I recorded the alternate readings in the textual notes. Only where A’s readings were obvious scribal slips or simply did not make sense did I emend. In short, I attempted to reproduce A with all of its warts intact» (Ibidem, p. 13).
Per la Regula Benedicti, John Chamberlin sceglie di pubblicare il codice Cambridge, Corpus Christi College 57 in quanto «local variant of the text»: si tratta della specifica forma in uso nell’abbazia di Abingdon, cioè in una delle fondazioni monastiche inglesi che ebbero maggiore importanza nel X secolo (The Rule of St. Benedict: the Abingdon Copy, edited from Cambridge, Corpus Christi College Ms. 57 by John Chamberlin, Toronto 1982). Nel caso della raccolta di favole attribuita a Gualtiero Anglico, Aaron Wright sceglie il codice Wolfenbüttel, Helm. 185 anche per la completezza con cui la collezione figura in questo specifico codice, ma soprattutto per il fatto che in esso le favole sono accompagnate da glosse interlineari e da un commento esplicativo, le une e l’altro fedelmente riprodotti nell’edizione; si privilegia perciò l’assetto testuale di quel singolo codice come testimonianza dell’uso scolastico dell’Aesopus. Anche in questo caso si cerca di motivare la scelta anche con elementi di carattere più strettamente filologico: «despite its late date – the Wolfenbüttel manuscript was written some three centuries after the probable composition of the fables – the text preserved in the manuscript is to all appearances reliable and authoritative, with relatively few metrically defective lines, and only a single distich omitted» (The Fables of ‘Walter of England’, ed. A. E. Wright, Toronto 1997). Ma, mancando un esame comparativo con il resto della tradizione, non è chiaro su cosa si fondi questa opinione. Per l’edizione di un commento all’Alexandreis, la scelta di David Townsend di pubblicare il testo del codice Londinese, Add. 18217 è giustificata con l’intento di mostrare la performance scolastica che si realizza in quella specifica copia (An Epitome of Biblical History. Glosses on Walter of Châtillon’s «Alexandreis» 4.176-274, Edited from London British Library, MS. Additional 18217, ed. D. Townsend, Toronto 2008). Per un libretto devozionale proveniente da Durham (Londra, Society of Antiquaries 7), l’editore, Thomas Bestul, segnala, in particolare, che la punteggiatura adottata nel codice rispecchia la lettura orale che ne veniva fatta (A Durham Book of Devotions, edited from London, Society of Antiquaries, MS. 7 by Thomas H. Bestul, Toronto 1987).
Alcuni volumi della collana pubblicano un insieme di scritti conservati in un particolare codice, rispettando l’oggetto-libro come veicolo culturale. Si tratta di una strategia – beninteso, del tutto legittima – che si segue di frequente quando all’interno del libro si riesce a cogliere una progettualità, da parte di un redattore che potrebbe essere anche chiamato, con buone ragioni, ‘autore’ della raccolta. In questo senso vanno l’edizione di una collezione di ‘rhetorical poems’ contenuti nel ms. Glasgow, Hunterian Library, V.8.14, pubblicata da Bruce Harbert, dove figura anche una breve introduzione metodologica sull’importanza di mantenere l’assetto delle raccolte poetiche medievali al fine di non travisare il significato comunicativo e contestuale del singolo testo (A Thirteenth Century Anthology of Rhetorical Poems, cit.); o quella del gruppo di 24 lettere di Alcuino contenute nel codice Cotton Vespasianus A xiv, pubblicate da Colin Chase e da lui considerate l’unione di due differenti collezioni preesistenti (Two Alcuin Letter-Books, ed. C. Chase, Toronto 1975).
Alla stregua di una collezione, e perciò rientrante in questa categoria, può essere considerato anche l’Innario di Canterbury, pubblicato da Gernot Wieland sulla base del codice Londinese Add. 37517 (The Canterbury Hymnal, ed. G. R. Wieland, Toronto 1982). Opposto è il caso dell’edizione delle Epistolae di Pietro il Venerabile. Si tratta di un gruppo di 17 lettere, drastica selezione delle 193 contenute nell’editio maior pubblicata da Gilles Constable (The Letters of Peter the Venerable, edited, with an introduction and notes, by Giles Constable, Cambridge, Mass., 1967). L’edizione di Toronto è curata da Janet Martin, ma si vale della collaborazione dello stesso Constable (Peter the Venerable, Selected Letters, edited by Janet Martin in collaboration with Giles Constable, Toronto 1974). Ciascuna delle 17 lettere prescelte è pubblicata sulla base del testimone potior che la riporta: nove sono trascritte dal manoscritto Douai 381, di poco successivo a Pietro; sei da un codice di Le Puy, scritto intorno al 1420; due dall’editio princeps del 1522. Dal punto di vista testimoniale l’edizione delle singole lettere ha perciò valore diverso, e questa volta viene violata la linea di privilegiare la fruizione (la raccolta, il libro come entità) rispetto all’autorialità; in compenso, i prolegomeni filologici, per quanto sintetici, sono precisi e corretti, rifacendosi a una ricerca completa come quella di Constable.
Per l’edizione di un commento alle Metamorfosi di Ovidio (chiamato dall’editore, Frank Coulson, ‘Vulgate’ Commentary), di cui si conoscono 17 manoscritti, è scelto come testo-base il codice Sélestat 92 (The ‘Vulgate’ Commentary on Ovid’s Metamorphoses. The Creation Myth and the Story of Orpheus, ed. F. T. Coulson, Toronto 1991). Le motivazioni invocate riguardano stavolta la (presunta) qualità testuale: il codice appartiene alla famiglia α, i rappresentanti della quale «have been more carefully copied and are less subject to corruption». Fra i cinque codici del gruppo α, quello di Sélestat, privo di guasti materiali, «preserves a reliable and complete text of the ‘Vulgate’ commentary, and the commentary itself has remained unaffected by the vagaries of later correcting hands». L’edizione si sforza poi di riprodurre la struttura articolata del commento: si pubblicano i versi di Ovidio riga per riga con le glosse interlineari in apparato, e sulla pagina di fronte il commento medievale esteso. L’editore deve però rilevare che il testo ovidiano, come appare nel codice, «is unfortunately often corrupt»; di conseguenza lo emenda (secondo le edizioni critiche correnti, si penserebbe). Per quanto riguarda il commento, invece «the reading of the manuscript is retained whenever possible»; ma «where the text seems deficient due to scribal corruption, readings from two other manuscripts are incorporated (si tratta del Wolfenbüttel Gud. 123, affine a quello di Sélestat, e del Vaticano lat. 1598, «which contains corrections by a later hand that frequently serve to clarify textual problems»; una motivazione sorprendente, perché a questo punto si dovrebbe pensare a una superiorità di quest’ultimo codice, anche se corretto successivamente). Il risultato, da un punto di vista documentale, è ibrido: il testo delle Metamorfosi è ricostruito, e non corrisponde più a quello del manoscritto; il testo del commento è quello del manoscritto, occasionalmente rettificato sulla base degli altri due, e non ha più un aggancio diretto con quello ovidiano ‘ricostruito’ che nell’edizione si legge di fronte.
Il volume forse più ‘sperimentale’ della collana è quello curato dal suo direttore di allora, A. G. Rigg, ed è riservato a una serie di testi che raccontano la storia dell’Inghilterra dalle origini leggendarie fino alla caduta del re Riccardo II (1399) (A Book of British Kings 1200 BC – 1399 AD, edited from British Library MSS Harley 3860, Cotton Claudius D.vii, and Harley 1808 by A. G. Rigg, Toronto 2000). I tre testi principali sono: la cosiddetta Harley Epitome, così chiamata perché contenuta nel codice Londinese Harley 3860, ma utilizzata anche (sulla base di un testimone diverso e talvolta superiore) dal cronista Walter of Coventry; una versione metrica della Harley Epitome, conservata in cinque manoscritti; il commento alla versione metrica, scritto nel margine a uno di tali codici, il Cotton Claudius D vii. Rigg pubblica in una stessa pagina la versione metrica, che è al centro del suo interesse, l’Epitome da cui essa deriva, e il commento marginale. L’editore riconosce che, poiché la versione metrica è tratta dall’Epitome, quest’ultima potrebbe servire per discriminare le varianti fra i tre manoscritti e produrre un’edizione ricostruttiva della prima; ma «the principles of the series require fidelity to a single manuscript», e l’editore sceglie perciò di attenersi al manoscritto Cotton. Nel caso dell’Epitome, Rigg deroga invece dichiaratamente alle regole della collana: il suo scopo stavolta è quello di fornire un testo il più possibile vicino al modello della versione metrica, e a tal fine egli modifica talvolta il testo del manoscritto Harley sulla scorta della versione parallela di Walter. Il risultato è paradossale: per l’Epitome non si fa una ricostruzione dell’originale, che viene quasi dogmaticamente esclusa, ma si fa invece la ricostruzione di un piano intermedio, solo perché questo sarebbe il modello di un testo derivato; e sulla pagina convivono un testo conservativo (la versione metrica con il relativo commento, che trovano posto in effetti nel medesimo manoscritto Cotton), e un testo ricostruito (l’Harley Epitome, che non vi trova posto).
Abbiamo registrato, in modo fors’anche troppo meticoloso, la strategia editoriale dei vari volumi, perché ci sembrava che essi illustrassero bene le precise istanze scientifiche della collana, e insieme i limiti con cui essa ha dovuto scontrarsi nelle realizzazioni pratiche. Molto di rado – o forse mai – la regola di attenersi al singolo manoscritto ha potuto essere rispettata alla lettera; sempre si è fatto ricorso a codici di controllo, quando disponibili (Così anche nel caso, che non abbiamo avuto occasione di citare, della Vita Gundulfi pubblicata da Rodney Thomson: The Life of Gundulf Bishop of Rochester, ed. by R. Thomson, Toronto 1977), oppure a un’emendatio, per quanto moderata e praticata sottovoce. Il necessario equilibrio fra riproduzione fedele del manoscritto e leggibilità («weighing the ideal of reproducing A faithfully against the necessity of producing a text which would be comprehensible», come si dice nell’introduzione dei R. James Long al De proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico, cit., p. 12) è l’obiettivo costante, ma non facile da realizzare; nel caso dell’Ex diversis auditis del presbitero Samuele, è stato giocoforza modificare l’assetto testuale presentato dal manoscritto per poter rendere comprensibile al lettore il continuo rinvio fra le parti in prosa e in versi (Samuel presbiter, Notes from the school of William de Montibus, cit.). Gli editori sono costretti talvolta a decisioni dolorose: a proposito del sermone su Thomas Beckett di Stephen Langton, l’editrice, Phyllis B. Roberts, dice di avere seguito «the section divisions in the manuscript [Vaticano lat. 1220] as a basis for references, even though these subdivisions on occasion break the sequence of the argument» (Selected Sermons of Stephen Langton, ed. by P. B. Roberts, Toronto 1980, p. 11). La tentazione – o se si preferisce il miraggio – del testo ‘ricostruito’ sembra sempre dietro l’angolo, e dà ragione dell’understatement di Alexander Andrée, editore dell’Historia calamitatum di Abelardo, che sembra giustificarsi per avere prodotto un’edizione non pienamente scientifica (Peter Abelard, Historia calamitatum, edited from Troyes, Médiathèque du Grand Troyes, MS 802 by A. Andrée, Toronto, 2015. A questo volume dedichiamo una scheda specifica all’interno dell’Osservatorio).
L’arbitrarietà nella scelta del codex potior, nonostante le motivazioni che di solito vengono addotte, resta piuttosto ampia; e del resto si tratta di un’arbitrarietà intrinseca, dato che il fondamento teorico della serie è che ogni documento (in questo caso, ogni codice) ha la sua piena dignità come oggetto storico e testuale, e ciascuno meriterebbe di essere pubblicato al pari di tutti gli altri. La migliore interprete di questa linea è forse l’editrice del volume più recente della serie, Martha Bayless (Fifteen medieval Latin parodies, edited by M. Bayless, Toronto 2018), che pubblica un’antologia di 15 testi parodici, tutti sulla base di un unico manoscritto; si tratta sempre di versioni inedite, anche se nella maggior parte dei casi di opere di cui erano già state pubblicate forme diverse. Nell’introduzione si sottolinea che, nonostante ogni singolo testo sia conservato in più manoscritti, «virtually none of these manuscripts versions is a direct copy of another version», perché ogni scriba apporta proprie modifiche («additions and changes») nella copia che va producendo. Le parodie sarebbero perciò un eccellente esempio della variabilità del testo medievale, secondo la chiave interpretativa fornita dalla New Philology; come auctoritas viene citata una delle più famose – o quanto meno delle più appariscenti – frasi del «preeminent New Philologist Bernard Cerquiglini: “l’écriture médiévale ne produit pas de variantes, elle est variance”» (Ibidem, p. 4. La frase di Cerquiglini viene da Éloge de la variante, Paris 1989, p. 111).
Forse con qualche rimpianto, un filologo di scuola classica come Michael Winterbottom scrive (a proposito della Vita Ethelwoldi di Wulfstan): «a critical edition of Wulfstan would give variants of all five manuscripts and of Aelfric [cioè del volgarizzamento anglosassone del testo]. But for the purpose of this series it has been necessary to rely on one manuscript», e la scelta ricade sul Cotton Tiberius D iv vol. 2, «the best witness», che tuttavia «contains readings that certainly do not go back to Wulfstan» (Three Lives of English Saints, ed. by M. Winterbottom, Toronto 1972, p. 7). Il concetto di «best witness» è inteso qui in senso strettamente testuale: dal punto di vista di completezza materiale il codice è anzi problematico, in quanto danneggiato dall’incendio della Cotton Library del 1731, e dove il testo non è più leggibile l’editore lo integra grazie alla collazione di altri testimoni. Nonostante questo, «the other manuscripts would have been even less reliable in this respect». Nel caso della Vita sancti Edmundi, dubitativamente attribuita ad Abbone, Winterbottom sceglie un altro codice Cotton (Tiberius B ii), in virtù della sua maggiore correttezza rispetto ad altri due di pari antichità, ma anche in base a ragioni stemmatiche. Ricostruiti i rapporti fra i testimoni, Winterbottom non si trattiene dall’emendare occasionalmente il codice preferenziale, anche se la formula usata tende a ridurre l’importanza di tali interventi: «I have kept to a minimum tampering with T on the basis of the other branch of the tradition».
Un ultimo appunto di carattere terminologico, che potrebbe però spiegare l’intransigente conservatività che la collana dimostra sul versante ortografico e, forse anche morfologico. Non sempre chiara nelle introduzioni alle singole opere appare la definizione di errore e di correzione. Tutti gli editori sottolineano che, in omaggio alle regole della serie, ‘non correggono il testo del manoscritto’, a meno che non sia palesemente inaccettabile. Talvolta però si ha l’impressione che il senso di questo ‘correggere’ non sia filologico (non corrisponda cioè a quella che si chiama tecnicamente emendatio), ma linguistico. Bestul ad esempio, nella sua edizione del libretto devozionale di Durham, dichiara di non correggere gli indicativi che nel manoscritto sono indebitamente usati in luogo di un congiuntivo classico (A Durham Book of Devotions cit., p. 17). Ma nessun editore che sia un medievista si sognerebbe di correggere un indicativo poco conforme alle regole classiche, o al contrario un congiuntivo ipercorrettivo, se non quando ci siano elementi per pensare che l’autore avesse una buona formazione scolastica e alle regole scolastiche si attenesse. L’opposizione, per il filologo, non è fra ‘adesione alla regola’ / ‘violazione della regola’, ma fra ‘lezione originaria’ / ‘lezione derivata’; e per discriminare fra una lezione originaria e una lezione derivata non serve un sistema di ‘regole’, ma la conoscenza del contesto, della lingua, del retroterra culturale, delle fonti dell’autore. La conservazione degli ‘errori’ – intesi come forme non rispondenti alla grammatica classica – può essere plausibile e giustificata, quando ve ne siano gli estremi; ma in altri casi certo non lo è, e un’insistenza eccessiva su questo punto, che enfatizza la differenza degli usi medievali rispetto a quelli classici, è fuorviante. Nel pubblicare alcuni Colloquia anglosassoni e irlandesi – opere fra loro piuttosto eterogenee –, Scott Gwara dichiara che la conservatività è necessaria in quanto questi testi derivano (o deriverebbero) «from an oral rather than written tradition»; per questa ragione l’editore dichiara di aver corretto «only when the transmitted reading makes no sense» (Latin Colloquies from Pre-conquest Britain, edited from Oxford, St. John’s College, Ms. 154 and from Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 865 by Scott Gwara, Toronto 1996, p. 22). I solecismi del latino proverrebbero cioè dal sostrato anglosassone; anche se, a ben vedere, questa stessa oralità finisce uccisa dal fatto che possediamo tali testi proprio in quanto, e solo in quanto, sono stati scritti. Del resto l’editore decide di ignorare totalmente gli interventi di un correttore pressoché contemporaneo al copista, al punto di non segnalarli neppure in nota.
Esula dalle finalità di questo contributo formulare un giudizio complessivo sulla collana, a quasi mezzo secolo dalla sua fondazione; ma qualche osservazione si può fare. La prima è che la serie di Toronto, indipendentemente dell’opinione che si può avere sulla metodologia adottata, ha avuto il merito di mettere a disposizione del pubblico alcuni testi poco noti, o anche inediti, contribuendo ad aumentare le nostre conoscenze nel campo della latinità medievale. La collana ha seguito una via editoriale che non ci sentiamo di condividere; le obiezioni a suo tempo formulate da vari studiosi non ci sembrano superate, né ci pare che i prodotti realizzati abbiano indicato delle soluzioni pratiche a problemi che erano stati allora prospettati in sede teorica. Proprio per la sua piena adesione a una linea filologica a quel tempo innovativa, e per la coerenza con cui tale linea è stata mantenuta nel tempo, la serie di Toronto permette ora di comprendere il difficile equilibrio che comporta una strategia che miri al pieno rispetto del singolo manoscritto, in quanto documento storico: perché il richiamo all’‘originale’ sembra pressoché ineludibile – almeno in quanto il codice ‘reale’ che si pubblica si determina nel suo valore su base comparativa, grazie al confronto con gli altri documenti analoghi, in una catena cronologia in cui l’anello più importante è quello di partenza –, e perché la fruibilità del testo per il lettore d’oggi implica comunque compromessi e semplificazioni, che finiscono per ledere, e in aspetti significativi, la piena e fedele rappresentabilità del documento.
L’utilità scientifica è indubbia, e ci sembra che nella lunga storia della collana anche la consapevolezza della discussione sia progressivamente aumentata. Restano due problemi, difficili da risolvere, che non riguardano tanto i risultati o il metodo, quanto la prospettiva di approccio e le
sue conseguenze. Il primo è che una collana di ampia diffusione, che propone volumi a prezzo modesto e in lingua inglese, tende a costituire una vulgata: i testi lì pubblicati saranno quelli abitualmente citati, tanto più per le opere delle quali non è disponibile un’edizione recente. Al di là dei ragionevoli scopi della collana, perciò, sarebbe necessario in questi casi una chiara avvertenza su quali siano i limiti del testo pubblicato, senza confonderlo con quello che normalmente viene chiamato ‘edizione critica’. Una tale avvertenza potrebbe ovviare anche al secondo problema, che è quello della consapevolezza dell’editore. Scorrendo le prefazioni delle edizioni che abbiamo esaminato si ha spesso la percezione che gli studiosi che le hanno curate, specialmente se giovani, ritengano il metodo che stanno usando – quello di scegliere un manoscritto unico, e di non modificarlo mai finché possibile – come il più scientifico dei metodi, e financo l’unico possibile per la pubblicazione di testi medievali. Non è così, ovviamente, e tutti lo sappiamo; ma sarebbe bene che lo riconoscessero anche loro.