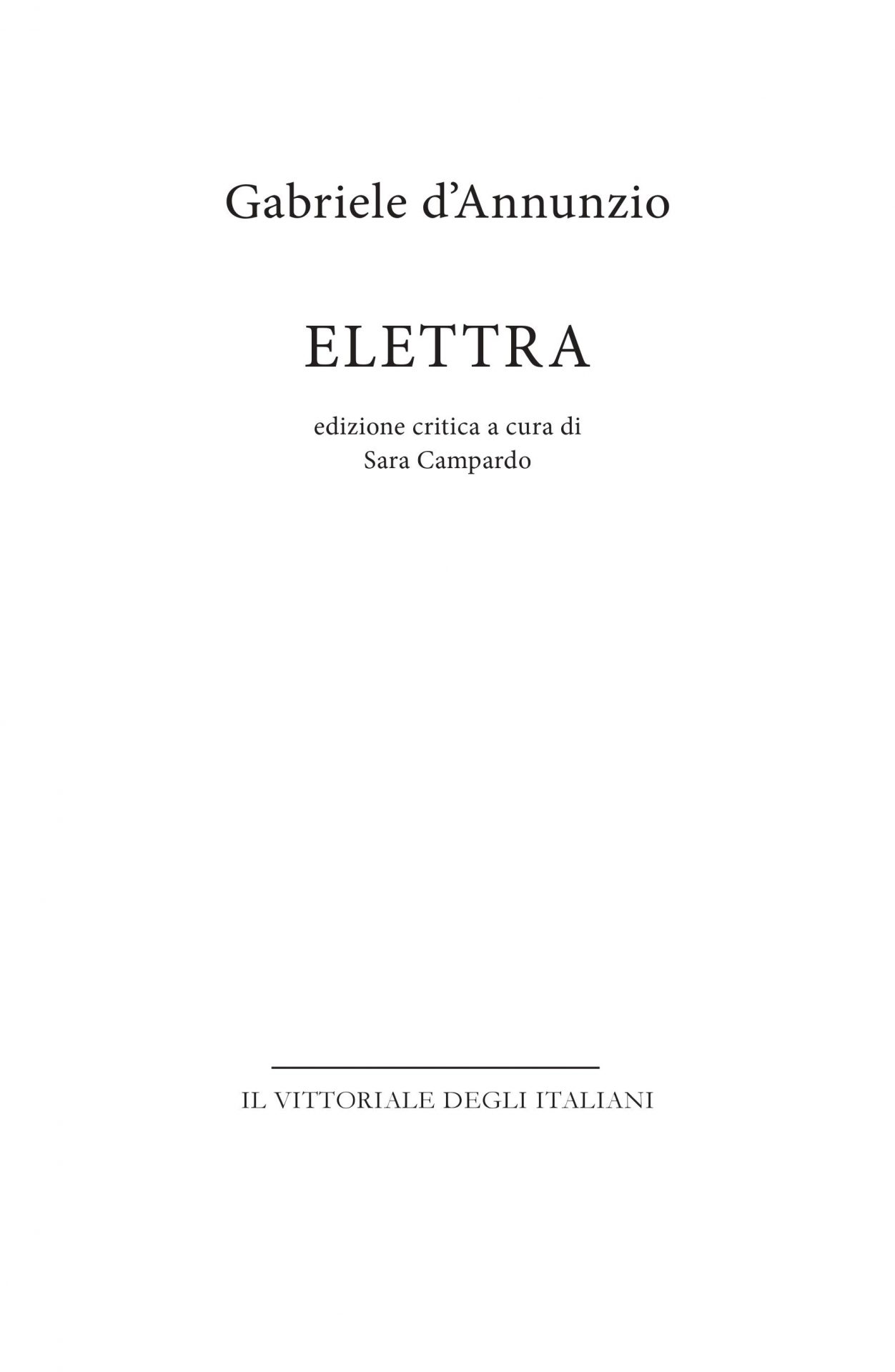Autore dell’opera*: Gabriele D’Annunzio
Titolo dell’opera*: Elettra
Ambito cronologico*: età contemporanea / XX secolo
Ambito linguistico*: italiano
Tipo trasmissione dell’opera *: a stampa
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione: edizioni a stampa
Titolo edizione*: Elettra
Curatore edizione*: Sara Campardo
Tipo edizione*: edizione critica
Sede di pubblicazione*: Il Vittoriale degli Italiani
Anno di pubblicazione*: 2017
Lingua di pubblicazione: italiano
Dati bibliografici completi: G.D’Annunzio, Elettra, edizione critica a cura di Sara Campardo, Il Vittoriale degli Italiani, 2017
Autore recensione/scheda*: Carla Riccardi
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
1.
• prima edizione dell’opera*: Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, libro II, (Elettra e Alcione), con un disegno di Giuseppe Cellini, Milano, Treves, 1904 (ma 1903)
• successive edizioni vivente l’autore: Elettra, con un disegno di Adolfo De Carolis, Milano, Treves, 1906; Edizione nazionale Opera Omnia 1928; edizione «L’Oleandro» 1934
• per le edizioni qui sopra elencate il testo è stato rivisto dall’autore o da altro soggetto riconosciuto? Sì, dall’autore
• edizioni postume: Mondadori 1939; Versi d’amore e di gloria,vol.II, Mondadori 1950 (riprendono l’edizione Treves del 1904)
2.
• precedente edizione critica del testo*: NO
• precedente edizione scientifica di riferimento*: G. D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, 2 voll., a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 1984
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
«Per l’edizione critica è stato utilizzato come testo base l’ultimo uscito in vita a cura del poeta, quello pubblicato dalla fondazione dell’Oleandro nel 1934. In realtà tra le varie stampe non vi sono comunque molte divergenze, se non per alcune varianti grafiche o interpuntive» (p. XXXV). Si deve dunque ritenere che le ragioni della scelta che non sono precisamente indicate siano da attribuirsi a una maggiore accuratezza editoriale del testo, anche se l’editio princeps non sembra né trascurata, né fitta di refusi, data l’attenzione ossessiva del poeta per la stampa dei suoi testi. O il testo del 1934 è stato scelto più probabilmente seguendo il criterio dell’ultima volontà dell’autore.
4.
• criteri di edizione*
Illustrati in un paragrafo a parte sinteticamente e con chiarezza. La curatrice «distingue tra storia e preistoria testuale. Fanno parte della preistoria tutti quegli appunti manoscritti di d’Annunzio che testimoniano la presenza di una progettualità delle liriche nel loro divenire. Questi testimoni, per cui si fa rimando all’Appendice, sono tutti conservati all’Archivio del Vittoriale, ove sono suddivisi in E, elenchi di titoli e progetti strutturali; L, liste lessicali, appunti botanici; M, «motivi», abbozzi, appunti tematici, T, passi dei taccuini» (p. XXXV). La storia elaborativa è così schematicamente indicata:
- A minuta autografa
- B bella copia autografa
- rv edizione in rivista
- bz bozze di stampa
- tr1 Elettra – Alcione, Milano, Treves, 1904 (ma dicembre 1903)
- tr2 Elettra, Milano, Treves, 1906
- nz Elettra, Istituto Nazionale per la edizione di tutte le opere di Gabriele d’Annunzio, Verona, Mondadori, 1928
- ol Laudi, Roma, per l’Oleandro, 1934
Seguono le indicazioni di lettura dell’apparato.
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Sono forniti nell’introduzione. In particolare viene descritto il metodo di lavoro di D’Annunzio, un lavoro condotto per blocchi, lasciando spazi vuoti nei mss per l’inserimento di altri materiali già approntati (taccuini o altro). Così si rileva che spesso le minute costituiscono una lectio ne varietur: venivano inviate direttamente in tipografia. D’Annunzio lavorava su fogli sciolti per poter sostituire con facilità redazioni rifiutate o aggiungerne. Molti fogli, recuperati dal segretario, costituiscono abbozzi, appunti, prime stesure preziose per ricostruire l’iter compositivo. Percorso che viene ricostruito molto analiticamente nel capitolo Dal manoscritto alla princeps e le successive stampe.
6.
• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*
I manoscritti di Elettra sono stati consultati a Roma, presso la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele II” e a Gardone, presso l’Archivio Personale del Vittoriale degli Italiani, al Fondo Gallenga Stuart della Biblioteca dell’Università per Stranieri di Perugia solo per una copia calligrafica dei sonetti dedicati a Perugia, tra le Città del silenzio.
7.
7.
• tipo di apparato/i*: genetico distinto in due fasce: la prima per le varianti interne alla minuta, la seconda per le lezioni tra minuta, bella copia, edizione in rivista e tra le edizioni che hanno preceduto la stampa per l’Oleandro del 1934. La distinzione tra fasce sempre all’interno di un apparato genetico rende chiara la distinzione tra fasi. La distinzione tra varianti evolutive (per le correzioni avvenute immediatamente, prima della prosecuzione della stesura) e varianti sostitutive (per le correzioni di precedenti lezioni concluse) può dar conto di una elaborazione in più fasi della minuta, anche se può rimanere il dubbio su interventi cronologicamente diversi.
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina
8.
• presenza di note / commento al testo*: NO
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
L’introduzione ripercorre le tappe compositive illustrandole con utili prospetti cronologici, analizza compiutamente la struttura e i temi delle varie sezioni ricostruendo l’operazione di composizione del testo da parte dell’autore, studia il metodo di lavoro dell’autore basandosi sull’edizione del 1934 testo critico scelto per l’edizione, ripercorre l’itinerario dai manoscritti alla princeps, sono descritti i criteri di edizione, seguiti dal catalogo dei manoscritti e delle dizione a stampa. Il capitolo dedicato alla genesi del libro ricostruisce la storia dei singoli testi dalla prima ideazione alle edizioni singole alle stampe in volume, riassumendone il contenuto e fornendo indicazioni metriche. Un’Appendice contiene Elenchi di titoli, Liste lessicali, appunti botanici, «Motivi», abbozzi, appunti tematici, Passi dei Taccuini. Ovvero tutto il materiale che è servito a D’Annunzio per la composizione dei testi, secondo un metodo di lavoro consolidato e riscontrabile in tutte le sue opere.
10.
• ulteriori eventuali considerazioni
L’edizione è preziosa perché completa l’edizione critica delle Laudi. È condotta con molta precisione e rispetto alla precedente edizione nei «Meridiani» Mondadori, altrettanto importante per le note storico-critiche e il commento, documenta puntualmente tutto il lavoro di approssimazione ai testi.