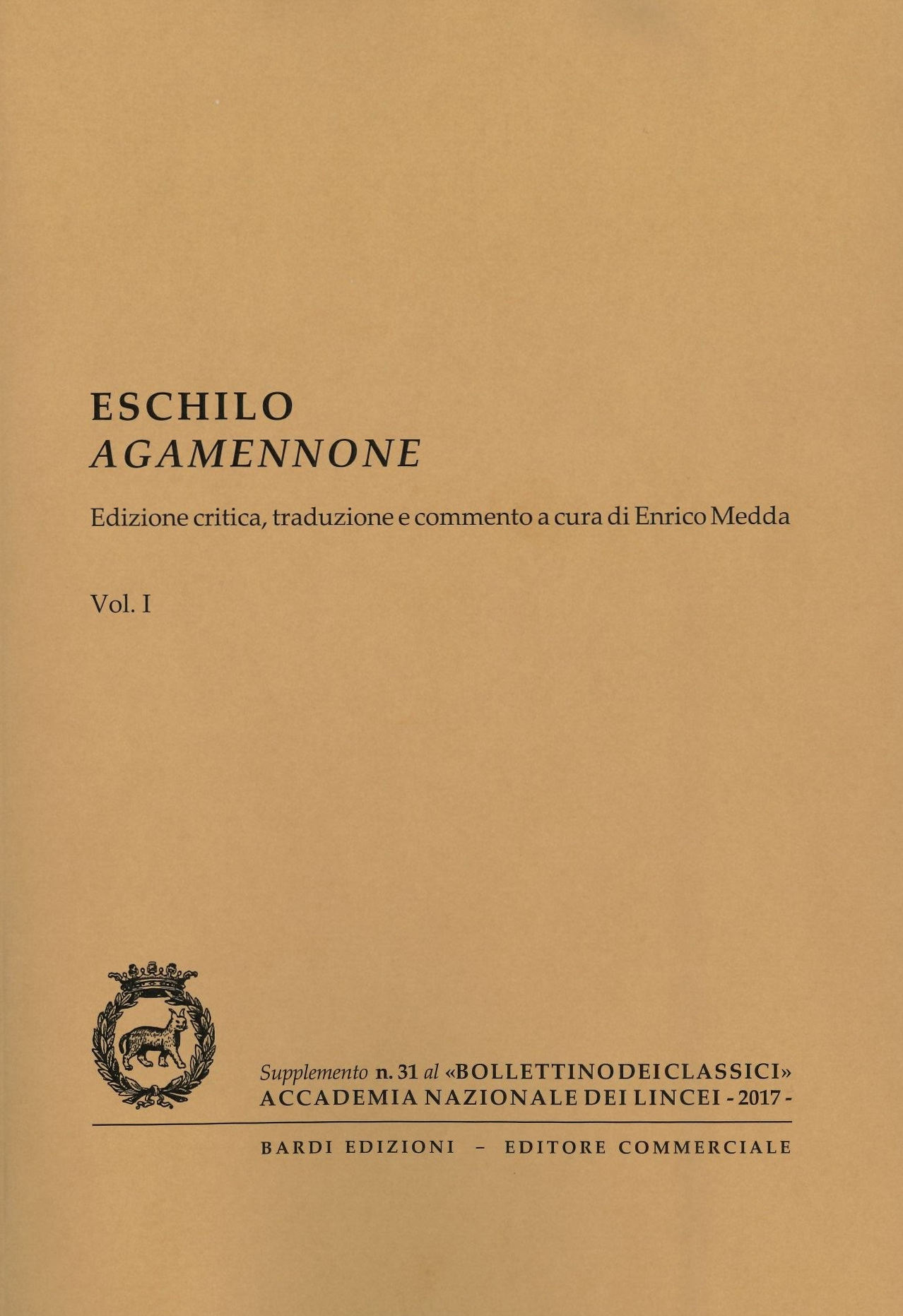Autore dell’opera: Eschilo
Titolo dell’opera: Agamennone
Ambito cronologico: Antichità / V secolo a.C.
Ambito linguistico: greco antico
Tipo trasmissione dell’opera: manoscritta di estensione media (senza autografi)
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione: papiri, manoscritti bizantini, tradizione indiretta
Titolo edizione: Agamennone
Curatore edizione: Enrico Medda
Tipo edizione*: edizione critica ricostruttiva
Sede di pubblicazione: Roma, Bardi Edizioni
Anno di pubblicazione: 2017
Lingua di pubblicazione: italiano
Dati bibliografici completi: Eschilo, Agamennone. Edizione critica, traduzione e commento a cura di Enrico Medda, tomi I-III, Roma, Bardi Edizioni, 2017 (Supplemento n. 31 al «Bollettino dei classici» – Accademia Nazionale dei Lincei) ISSN: 0391-8270, ISBN: 978-88-218-1152-4
Autore recensione/scheda: Stefano Martinelli Tempesta
Tipologia di contributo: recensione
Dati bibliografici della recensione/scheda: OEC
- DESCRIZIONE DELL’EDIZIONE
Si tratta del primo volume di una grande impresa ecdotica, condotta da studiosi italiani, francesi e catalani, coordinati da Vittorio Citti, Pierre Judet de la Combe e Carles Miralles, che si propone di pubblicare una nuova edizione critica, fondata su un nuovo esame della tradizione, dell’intero corpus eschileo. Nell’ambito di tale iniziativa si segnala il Colloquio internazionale tenutosi presso l’Accademia Nazionale dei Lincei nel maggio 2016, i cui atti sono apparsi nel 2019 come n. 32 della serie dei Supplementi al «Bollettino dei Classici»: Reinterpretare Eschilo. Verso una nuova edizione dei drammi. La presente edizione, non inferiore per mole e per impegno alla monumentale edizione di Eduard Fränkel (tre volumi apparsi a Oxford nel 1950 e poi, in seconda edizione, nel 1962), si articola in tre tomi: il primo contiene una esauriente introduzione storico-letteraria, i prolegomena all’edizione critica, il testo critico con traduzione a fronte, un conspectus metrorum e la bibliografia; il secondo e il terzo contengono un amplissimo commento e gli indici.
Nell’introduzione storico-letteraria il curatore (Enrico Medda = M.) affronta in maniera esauriente e aggiornata tutte le questioni relative alla data della prima rappresentazione, che ci è nota grazie all’argumentum (primavera del 458 a.C. sotto l’arcontato di Filocle) e al suo contesto storico connesso, nella fattispecie con la vicenda politica di Efialte; alla tradizione del mito sulla morte di Agamennone prima di Eschilo e sulle peculiarità della trattazione eschilea; all’analisi letteraria del dramma; alla messa in scena in tutti i suoi aspetti teorici e concreti, dalla gestione dello spazio e del tempo, ai movimenti dei personaggi, agli oggetti di scena. La traduzione, per scelta consapevole e a mio avviso condivisibile, privilegia sempre la massima fedeltà al dettato originale, sacrificando talvolta la chiarezza, evitando, in questo modo, di aggirare o di nascondere le difficoltà di un testo estremamente complesso. L’amplissimo commento mostra una costante e minuziosa attenzione ai problemi testuali – sempre affrontati anche alla luce della storia degli studi –, che si intrecciano in maniera indissolubile alle questioni interpretative: assai significativo, a tal proposito, il caso dei versi 182-183 (vd. l’esauriente commento di M., II, pp. 134-135) dove una minima differenza di accento è in grado di cambiare drasticamente il tono e, di conseguenza, il senso dell’intero passo, trasformando una frase rassicurante del coro (‘C’è, in qualche modo – που – c’è una benevolenza degli dèi’) in una domanda piena di angoscia (‘dov’è – ποῦ – la benevolenza degli dèi?’).
- TRADIZIONE DEL TESTO
M. tratta in modo esauriente dell’argomento distinguendo, opportunamente, tra storia antica del testo e tradizione manoscritta medievale (rispettivamente I, pp. 187-198 e 198-217). La fase più antica della tradizione di Eschilo, come, più in generale, dei testi teatrali, nella fattispecie tragici, presenta problemi di non facile soluzione. Il primo riguarda la fase più antica della trasmissione: non è possibile stabilire, infatti, se l’origine della diffusione libraria dei testi sia da connettere a copioni teatrali d’uso o a una vera e propria edizione preparata dall’autore per la diffusione pubblica. Inoltre – ma questo è un problema che riguarda tutti i testi attici anche in prosa prodotti tra quinto e quarto secolo – le copie più antiche, anteriori alla riforma ortografica che va sotto il nome dell’arconte Euclide (403-402 a.C.) grazie alla quale si adottò universalmente l’alfabeto ionico, utilizzavano l’antico alfabeto attico nell’ambito del quale i segni Ο e Ε corrispondevano, rispettivamente a ο, ω, ου e a ε, η, ει, con possibili interpretazioni erronee della catena grafica nel passaggio al nuovo sistema ortografico. Bisogna anche fare i conti con un problema fondamentale che riguarda la mise en page delle parti liriche dei testi teatrali, che nella fase più antica si presentavano in scriptio continua senza
tenere in alcun conto la distribuzione colometrica dei versi lirici (come possiamo intuire, per esempio, dall’antichissimo P. Berol. inv. 9875, del IV secolo a.C., contenente i Persiani di Timoteo). Rischi non trascurabili di alterazione venivano, infine, dagli attori/registi che riproponevano in scena nuove rappresentazioni degli autori più apprezzati, non di rado inserendo interpolazioni e modifiche. Una certa fluidità testuale nel corso della prima fase della trasmissione dei testi teatrali spiega l’iniziativa presa da Licurgo intorno al 330 a.C., testimoniataci da un passo delle Vitae decem oratorum pseudo plutarcheo (841F-842A): fu promossa un’edizione autorevole dei testi di Eschilo, Sofocle ed Euripide, alla quale avrebbero dovuto attenersi tutti coloro che avessero voluto riproporne nuove rappresentazioni. Famoso è l’episodio raccontato da Galeno (In Hipp. Epid. III, XVIIa, p. 606 Kuhn), secondo il quale un Tolomeo, probabilmente l’Evergete I (246-233 a.C.), avrebbe chiesto in prestito ad Atene i libri di Sofocle, Eschilo ed Euripide, lasciando una cauzione di quindici talenti, alla quale poi avrebbe rinunciato tenendosi gli originali e restituendo delle magnifiche copie. A prescindere dall’attendibilità del racconto, certo se ne può vedere il riflesso del fatto che ad Alessandria fossero confluite, accanto ad altre, copie autorevoli del testo dei tragici, sulle quali poi lavorarono i filologi alessandrini, tra i quali un posto di rilievo spetta ad Aristofane di Bizanzio al quale la tradizione attribuisce l’introduzione della divisione colometrica dei testi lirici, prima copiati in scriptio continua. In questa fase della trasmissione si stabilì certamente il canone degli autori migliori, ma non ancora la selezione di sette drammi per Eschilo e Sofocle, poi passata alla tradizione medievale; come si può dedurre dalle testimonianze papiracee, nella fattispecie i vari rotoli di contenuto eschileo copiati dal cosiddetto ‘scriba 3’ di Ossirinco, ancora nel II secolo d.C. si potevano realizzare iniziative ‘editoriali’ comprendenti drammi più numerosi e diversi da quelli trasmessi al medioevo bizantino. La selezione dei sette drammi – che vale soltanto per Eschilo e Sofocle, soltanto in parte per Euripide – non sarà semplicemente l’esito di scelte connesse con la scuola, ma anche il frutto di dinamiche di Einzelüberlieferung e di accorpamenti verificatisi gradualmente in epoca tardoantica durante il passaggio cruciale dal rotolo a codice.
La tradizione diretta antica dell’Agamennone è rappresentata da un unico papiro del II secolo d.C., P.Oxy. XIII 2178, che consta di due frustuli (vv. 7-17, 20-30) copiati dal medesimo ‘scriba 3’ di Ossirinco che ha copiato altri frammenti di rotoli papiracei eschilei appartenenti ai Sette contro Tebe e ad altre tragedie perdute riconducibili a un’unica iniziativa ‘editoriale’.
Diversamente dalla cosiddetta ‘triade bizantina’ (Prometeo incatenato, Sette contro Tebe, Supplici), la tradizione medievale e umanistica ell’Orestea e nella fattispecie dell’Agamennone non è ampia: in tutto nove manoscritti tra i secoli X/XI e XVI, di cui soltanto cinque indipendenti e, pertanto, da utilizzare in maniera sistematica per la constitutio textus. Da un lato un codex vetustus, il celebre Laur. Plut. 32.9 (M; X/XI secolo; lacunoso: vv. 1-310, 1067-1159), con tre apografi successivi alla fomazione delle lacune (Laur. San Marco 222, del XIV secolo; Bonon. 2271, della fine del XV o dell’inizio del XVI; Guelf. 88 Gud. gr., del 1495 ca.) dall’altro tre manoscritti riconducibili ad un comune capostipite (τ), sul quale – nella fattispecie sulla facies metrica e colometrica – si è esercitata l’attività emedatoria di Demetrio Triclinio: il Marc. gr. Z. 616 (coll. 663; ca. 1320-1325; sigla G; con i vv. 1-45, 1095-1673), il Laur. Plut. 31.8 (poco dopo il 1320; sigla F; completo; suo apografo è Roma, Bilbioteca Nazionale, gr. 5, del XVI) e il Neap. II F 31 (ca. 1325; sigla T; completo; autografo di Demetrio Triclinio). Tra questi due poli si colloca un manoscritto, il Marc. gr. Z. 468 (coll. 653; fine del XIII secolo; sigla V; con i vv. 1-348), proveniente dalla biblioteca del cardinale Bessarione,
la cui collocazione stemmatica non è pacifica. La presenza di accordi in lezione erronea sia con M sia con τ (o con uno o più dei suoi apografi) ha condotto gli studiosi a proporre, esclusa concordemente la dipendenza da M, tutte e tre le possibilità stemmatiche che possono spiegare una simile situazione: V è gemello di M (tradizione bipartita; A. Turyn); V è gemello di τ, poi rivisto da Triclinio (τc; tradizione bipartita; M.L. West); V rappresenta un ramo di tradizione indipendente sia da M sia da τ (tradizione tripartita; C.J Brennan). La valutazione è resa difficile dall’esigua porzione di testo conservata in V e in M, ma M. dimostra in modo convincente almeno l’insostenibilità della tesi di West, secondo la quale gli accordi in errore tra M e V sarebbero in realtà errori comuni a tutta la tradizione emendati talora già in τ, talaltra da Triclinio in τc. Fra le due restanti ipotesi stemmatiche, di per sé possibili, M. cautamente propende per uno stemma tripartito: da un lato gli errori che congiungono V a τ sono per lo più poligenetici, dall’altro ci sono alcuni casi in cui l’errore di M non si spiega a partire dalla lezione esatta presente in V e in τ e, inoltre, fatte salve un paio lezioni esatte tràdite soltanto da V (vv. 117 e 119), c’è un passo (v. 141) nel quale la lezione giusta (il raro e difficilmente congetturabile ἀέπτοις) è presente in V e F, mentre lo scolio ci dice che l’erroneo ἀέλπτοις di M doveva essere già nell’antigrafo, che, quindi, ben difficilmente avrebbe potuto essere il modello di V (su tutto questo vd. E. Medda in «QUCC», n.s. 90, 2008, pp. 41-64). Si tratta di argomentazioni ragionevoli, anche se non del tutto stringenti, e l’incertezza permane, soprattutto in considerazione dell’esigua porzione di testo valutabile; in ogni caso, viste le dinamiche della tradizione, anche con uno stemma tripartito le scelte ecdotiche non si possono fondare su criteri
meccanici.
- TESTO DELL’EDIZIONE CRITICA E RAGIONI DELLE SCELTE ECDOTICHE
La qualità e l’affidabilità della tradizione medievale dipendono in larga misura, anche se per vie non sempre chiaramente visibili, dalle vicende più antiche della storia del testo, le cui vicissitudini appena evidenziate spiegano la notevole problematicità del testo tràdito e la difficoltà della sua costituzione.
Nella fattispecie, la questione più spinosa e di assai ardua soluzione è quella relativa alla colometria delle parti liriche: quanto è affidabile la colometria dei manoscritti medievali? Secondo una parte degli studiosi la colometria dei manoscritti e dei papiri post-tolemaici risale in ultima analisi al lavoro dei filologi Alessandrini, che avrebbero avuto a disposizione manoscritti con la notazione musicale delle parti liriche, in base alla quale avrebbero stabilito testo e colometria delle loro edizioni. Conseguenza di tale convinzione è che nella constitutio textus si dovrebbe ripristinare la colometria dei manoscritti a scapito di quella degli editori moderni basata sulla moderna scienza metrica sviluppatasi tra i secoli XVIII e XIX. Secondo altri studiosi soltanto quest’ultima dovrebbe orientare gli editori nella presentazione colometrica dei versi lirici, senza tenere in alcun conto di quanto si trova nei manoscritti.
M., il quale non è convinto che gli Alessandrini disponessero di manoscritti forniti della notazione musicale delle parti liriche, mantiene, tuttavia, una posizione – a mio avviso del tutto condivisibile – di equilibrio: bisogna sempre partire dalla considerazione di quanto si conserva nei manoscritti, tenendo conto del fatto che la tradizione risale, in fondo, al lavoro di «eruditi antichi che conoscevano la produzione tragica meglio di noi, e che in base alle loro cognizioni metriche potrebbero aver correttamente analizzato i difficili testi in scriptio continua pervenuti alla biblioteca» (I, p. 227). Tuttavia, sottolinea M., non si deve essere ‘conservatori’ a tutti costi e astenersi dal modificare la colometria dei manoscritti, laddove necessario. Nella fattispecie, le condizioni della tradizione testuale dell’Agamennone, per il quale la maggior parte del testo è trasmessa soltanto dai manoscritti che discendono dalla recensio Triclinana, sono peculiari: una delle caratteristiche principali di questo ramo di tradizione è, infatti, proprio la disposizione colometrica esito delle scelte che Triclinio aveva operato in base alle proprie convinzioni maturate nell’ambito dei suoi studi metrici. Laddove il confronto con l’antico e autorevole M è possibile, si riscontrano casi in cui le scelte colometriche tricliniane sono palesemente sbagliate, come nel caso della prima sizigia della parodo (di tutto ciò M. fornisce ampio ragguaglio testimoniale e critico nel conspectus metrorum e nelle discussioni di problemi metrici che precedono ogni sezione del commento).
Questo atteggiamento di ‘critica aperta’, che parte dal dato della paradosi e valuta ogni singolo caso come fosse «un mirocosmo a sé» (I, p. 225) secondo le problematiche di lingua, stile e metrica, non senza tenere conto del contesto e delle esigenze dettate dalla drammaturgia e dalla messa in scena, informa tutte le scelte ecdotiche della presente edizione, che è molto chiara e precisa nella presentazione del testo con le tre stringhe di apparato: quella dei testes abdhibiti, che consente di sapere sempre quali sono i testimoni manoscritti sui quali si fonda la costituzione del testo; quella dei testimoni indiretti, che parte dalla fondamentale raccolta fornita dall’edizione teubneriana di Martin L. West (1990 [19982]), ma la arricchisce con nuove acquisizioni; quella con l’apparato critico vero e proprio, che M. sceglie di presentare, salvo eccezioni dettate dalla necessità di evitare ambiguità, in forma negativa.
M., anche in questo caso sviluppando ulteriormente una delle caratteristiche dell’edizione di West, ha compiuto meticolose indagini allo scopo di attribuire al πρῶτος εὑρετὴς (e alla precisa fonte originaria: manoscritto o postillato, nel caso di congetture o commenti inediti, prima sede di pubblicazione per quelle edite) ogni intervento congetturale riferito in apparato: come M. sottolinea molto opportunamente, «non si tratta […] di un gioco erudito: lo scopo è la ricostruzione […] del percorso storico-critico che ha portato il testo ad assumere la forma che lo caratterizza nelle edizioni che ci sono oggi famigliari. […] Il lettore potrà così ricollocare, se lo desidera, gli interventi originali nel contesto culturale in cui essi furono prodotti […]» (I, p. 225).
Siamo, insomma, di fronte a un’edizione scientifica perfettamente concepita e fondata su basi critiche e metodologiche solidissime, che rappresenta il culmine degli studi eschilei degli ultimi sessant’anni, e che promette di essere l’edizione di riferimento per gli studi del nuovo secolo sul teatro di Eschilo e, nella fattispecie, sull’Agamennone.