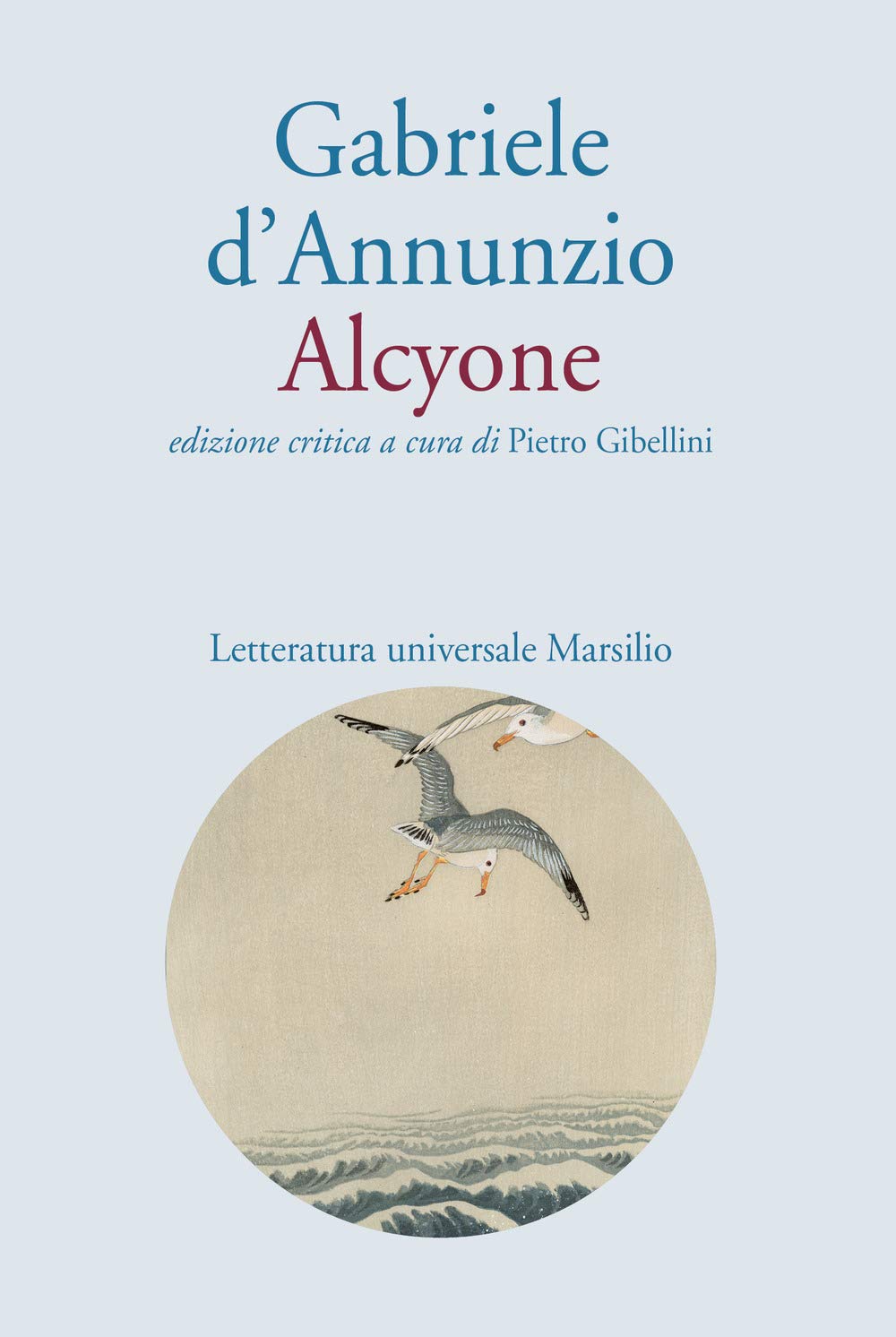Autore dell’opera: Gabriele D’Annunzio (1863-1938)
Titolo dell’opera: Alcyone
Altri titoli con cui l’opera è nota: Alcione
Ambito cronologico: età contemporanea / secolo XX
Ambito linguistico: Italiano
Tipologia di trasmissione dell’opera: a stampa con edizioni d’autore e non d’autore
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione: manoscritti autografi, edizioni a stampa
Titolo edizione: Alcyone
Curatore edizione: Piero Gibellini
Tipologia di edizione: edizione critica
Sede di pubblicazione: Venezia, Marsilio Editori
Anno di pubblicazione: 2018
Lingua di pubblicazione: Italiano
Dati bibliografici completi: G. D’annunzio, Alcyone, edizione critica a cura di Pietro Gibellini, Venezia, Marsilio Editori, 2018, ISBN 9788829100059
Autore recensione/scheda: Giacomo Fabbri
Tipologia di contributo: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda: OEC
Informazioni aggiuntive: questa scheda è parte del lavoro richiesto agli studenti per l’esame di Filologia editoriale (a.a. 2023/24), di cui è titolare la prof.ssa Virna Brigatti
1.
• prima edizione dell’opera*:
Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi (Elettra e Alcione), libro III, con xilografie di Giuseppe Cellini, Milano, Treves, 1904 (ma 1903)
• successive edizioni vivente l’autore
- Alcione, Milano, Treves, 1908;
- Alcione, Edizione nazionale Opera Omnia, 1927;
- Alcyone edizione “L’Oleandro”, 1931;
- edizione “L’Oleandro”, 1934 (in edizione complessiva di Laudi)
• per le edizioni qui sopra elencate il testo è stato rivisto dall’autore o da altro soggetto riconosciuto (se questa informazione è nota)?
Sì, dall’autore
• edizioni postume:
Dato il cospicuo numero di edizioni postume (circa settanta), di seguito sono riportate quelle rilevanti nel sistema editoriale, tra cambi di editore e collane; per queste ultime si riporta la prima pubblicazione in ciascuna:
- Alcyone, Milano, Mondadori (Le Pleiadi), 1939
- Alcyone (in Laudi), Bologna, Zanichelli, 1941, con introduzione e commento di Enzo Palmieri
- Alcyone, Milano, Biblioteca Moderna Mondadori, 1948
- Alcyone, Milano, Gli Oscar Mensili Mondadori, 1966
- Alcyone, Milano, Oscar Mondadori, 1982, a cura di Federico Roncoroni
- Alcyone, Milano, GUM Mursia, 1995, a cura di Maria Bertinotti; introduzione di Giorgio Bàrberi Squarotti
- Alcyone, Milano, I grandi libri Garzanti, 1995, introduzione e prefazione di Pietro Gibellini; note di Maria Belponer
- Alcyone, Milano, I grandi classici della poesia Fabbri, 1999, introduzione di Bianca Garavelli
- Alcyone, Milano, Corriere della Sera (supplemento La grande poesia), 2004, prefazione di Antonio Debenedetti
• edizione corrente e testo su cui si basa
Alcyone, Milano, Oscar Mondadori, 2020, a cura di Federico Roncoroni (quinta ristampa).
Il testo è basato su quello dell’edizione del 1931 (“L’Oleandro”), indicazione presente nella sezione “Bibliografia” posta alla fine del testo: «Per la presente edizione abbiamo seguito il testo de “I Classici Contemporanei Italiani” di Mondadori che a sua volta riprendeva, emendato dalle poche pecche, il testo dell’edizione 1931 per il Sodalizio dell’ “Oleandro”».
• primi testimoni noti dell’opera*:
Prima della princeps sono apparse le seguenti poesie:
- “Nuova Antologia”, Roma, 16 Novembre 1899 pp. 193-213: L’annunzio, Canto augurale per la nazione eletta (in Elettra), La città del silenzio (in Elettra), Bocca D’Arno (in Alcyone), La sera fiesolana (in Alcyone); 16 novembre 1900: L’oleandro; Roma, 1 agosto 1902, pp. 385-397: L’otre; Roma, 1 novembre 1903, pp. 3-11: La Tregua
- “Il Giorno”, Roma, 1 luglio 1900: La tenzone (col titolo La tregua)
- “Flegrea”, Napoli, 5 ottobre 1900, pp.1-6: Il Novilunio (col titolo Il Novilunio di settembre)
- “Il Marzocco”, Firenze, 16 giugno 1901: Ditirambo III; Firenze 31 maggio 1903: La morte del cervo
- “Novissima”, Milano, 1902: Le Ore marine; Firenze, 15 novembre 1903: Il Commiato
- “La settimana”, Napoli, 3 agosto 1902: La spica; Napoli, 17 agosto 1902, pp.481-483: L’ulivo
- “La rassegna internazionale”, Roma, 1 settembre 1902, pp.257-271: Il ditirambo I
- “Il secolo XX”, Milano, novembre 1902, pp. 498-499: L’ulivo; Milano, novembre 1903: La sera fiesolana
- “Leonardo”, Firenze, 14 gennaio 1903: Anniversario orfico
- “Shelley”, Viareggio, 13 settembre 1903: Anniversario orfico
- “Giornale d’Italia”, Roma, 27 settembre 1903: Nicarete e A Nicarete
2.
• precedente edizione critica del testo*:
G. D’annunzio, Alcyone, edizione critica a cura di Pietro Gibellini, Milano, Edizione nazionale delle opere di Gabriele D’annunzio Mondadori, 1988
• precedente edizione scientifica di riferimento*:
G. D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, 2 voll., a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Meridiani Mondadori, 1982-1984
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
«il testo della presente edizione si fonda sull’ultimo pubblicato in vita dell’autore». Viene comunque segnalato che fra le stampe non vi sono varianti significative, e che sono da considerare scarse e marginali «le differenza registrate fra la lezione del volume e quella degli anticipi di molte liriche, fra il 1899 e il 1903, su giornali o riviste». Sebbene l’editio princeps non risulti trascurata, probabilmente il testo del ’34 viene adottato in quanto ultima volontà d’autore e portatore di titolo aggiornato (Alcione > Alcyone).
4.
• criteri di edizione*
Ben illustrati all’interno della nota al testo. Sono condivisi con l’edizione critica precedente: la distinzione tra varianti evolutive (|) e sostitutive (); la rappresentazione delle correzioni con criteri cronologici e non topografici, ovvero «in base alla successione delle varianti e non alla loro posizione sul foglio»: infatti «La resa diplomatica dell’autografo risulterebbe poco utile, e soprattutto non sufficiente a chiarire ciò che più mi preme: la successione temporale delle lezioni concorrenti». Viene modificata la rappresentazione tipografica delle varianti rispetto all’edizione critica 1988. Se prima la lezione ne varietur veniva posta all’inizio, ora si procede al contrario, indicando in successione le varianti sino a quella definitiva. Diverge inoltre, oltre che negli apporti della trentina di autografi prima sconosciuti (21 minute e 8 belle copie), nella separazione fra preistoria e storia testuale. La prima viene documentata a parte nell’appendice.
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
La nota al testo riporta i criteri seguiti per l’edizione, aggiungendo una cronologia compositiva dell’opera e la spiegazione delle sigle per comprendere l’appendice. Nella nota al testo si fa riferimento al metodo di lavoro dell’autore: «D’Annunzio stende la poesia su grandi fogli sciolti, di carta a mano spessa e filigranata, sostituibili quando troppo pasticciati; su foglietti più piccoli abbozza singoli versi o emistichi, verga sintagmi alternativi da introdurre in spazi bianchi delimitati nei versi da due leggerissimi puntini». Era solito correggere barrando con una riga orizzontale ed inserendo la nuova nell’interlinea superiore, raramente nella inferiore: «La storia di una poesia alcionia prevede dunque generalmente la stesura di una minuta, poi di una bella copia, sostituita da ritagli di rivista in caso di pubblicazione anticipata, infine le stampe in volume». Viene detto inoltre che l’autore raramente corregge dopo la chiusa della lirica.
6.
• fonti archivistiche consultate dal curatore*
I manoscritti di Alcyone sono stati consultati a Roma, presso la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele II” [R] (Fondo “Dannunziana”) e a Gardone [G], presso l’Archivio Personale del Vittoriale degli Italiani: «Gli autografi sono conservati in cassette, contrassegnate da un numero romano e da una cifra araba (da 1 a 5). Ogni cassetta contiene varie cartelle, contraddistinte da una cifra araba, e corrisponde ai numeri-lemmi dell’Inventario dei manoscritti di Gabrielle D’Annunzio (in «Quaderni dannunziani», fasc. XXXVI-XXXVII, 1968)». Sono stati inoltre rinvenuti a Firenze [F], in archivio contemporaneo del “Gabinetto G. P. Vieusseux”, alcuni autografi fra cui la bella copia di Ditirambo III e quella di Versilia. A Imperia [I], in Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio”, si trova la minuta autografa di L’oltre. A Venezia [V], fondazione “Giorgio Cini”, autografi di La tenzone e La loggia. Infine, si fa riferimento ad una serie di collezioni private [cp]: «si tratta di autografi pervenuti in passato di cui non si ha più avuto notizia; non si sa, pertanto, chi li abbia acquisiti».
7.
• tipo di apparato/i*:
genetico diviso in due fasce, con distinzione tra varianti evolutive e sostitutive: «Le prime furono operate dal poeta all’istante lasciando in tronco la stesura del verso»; «Le varianti sostitutive subentrano invece a lezioni consolidate». Quelle evolutive segnano un passaggio da un frammento ad un testo, le sostitutive da un testo a un altro testo. La prima fascia segnala la più corposa quantità di varianti presenti interne alle minute. La seconda fascia, riportale varianti tra i testimoni seguendo il criterio di un tradizionale apparato negativo: dopo il numero di verso della lezione ne varietur, delimitata da quadra chiusa, si registrano le lezioni divergenti degli altri testimoni, contrassegnati dalle rispettive sigle.
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina
8.
• presenza di note / commento al testo*: Sì
• tipo di note / commento*: L’ampio commento è ciò che separa maggiormente questa edizione critica dalla precedente. Per ogni lirica viene proposta una sinossi della storia compositiva e degli argomenti-temi trattati dall’autore al suo interno. A seguire, quasi ogni verso presenta appunti che spaziano tra parafrasi, approfondimenti filologici, indicazione di fonti letterarie da Dante a Pascoli e gli “echi dei versi alcionii rintracciabili nei principali poeti novecenteschi (da Gozzano a Montale et ultra)”. Si trovano anche spiegazioni con rimandi ad elementi biografici ritrovati in scritti precedenti o lettere private autografe, proposte di interpretazione.
• posizione delle note / commento*: a fondo volume (pp.479-862)
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
L’edizione dà conto nella prefazione dei motivi che hanno spinto il curatore a voler lavorare ad una nuova edizione critica del testo e delle aggiunte rispetto alla precedente (commento a fine testo, appendice, schede metriche). L’ampia introduzione segue il processo compositivo del libro III delle Laudi fino all’editio princeps, riportando le ispirazioni autoriali per i singoli componimenti e le fasi della composizione per ognuno di essi. La nota come già detto riporta i criteri di edizione, la cronologia delle liriche, approfondimenti sul metodo di lavoro dell’autore. Si incontra poi una legenda delle sigle presenti in apparato e un più sintetico elenco del catalogo dei testimoni (di cui si dava già conto nell’edizione 1988), con l’aggiunta dei nuovi manoscritti sopraggiunti nei trent’anni che separano le due edizioni critiche. In fondo al volume l’appendice dà conto della preistoria del testo, tra cui liste lessicali, “motivi”, abbozzi e passi dei taccuini. Segue il commento sopracitato, alla stesura del quale collaborano Giulia Belletti, Enrica Gambin e Sara Campardo. Infine viene data per ogni lirica la scheda metrica in una sezione apposita