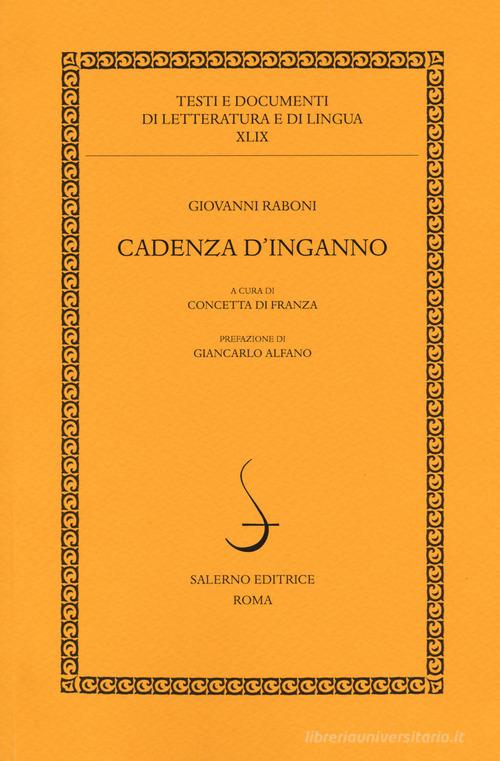Autore dell’opera*: Giovanni Raboni (Milano 1932 – Fontanellato, Parma, 2004)
Titolo dell’opera*: Cadenza d’inganno
Ambito cronologico*: XX secolo
Ambito linguistico*: italiano
Tipologia di trasmissione dell’opera*: a stampa con più edizioni di autore
Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione: dattiloscritti, pubblicazioni in rivista, testimoni a stampa parziali (precedenti la princeps), edizioni complete, edizioni antologiche (successive la princeps)
Titolo edizione*: Cadenza d’inganno
Curatore edizione*: Concetta Di Franza
Tipologia di edizione*: edizione critica e commentata
Sede di pubblicazione*: Roma, Salerno Editrice
Anno di pubblicazione*: 2023
Lingua di pubblicazione: Italiano
Dati bibliografici completi: Giovanni Raboni, Cadenza d’inganno, a cura di Concetta di Franza, Roma, Salerno, 2023, collana «Testi e documenti di letteratura e di lingua», XLIX, ISBN 978-88-6973-677-3, pp. XCIII-325.
Autore recensione/scheda*: Lorenzo Morviducci
Tipologia di contributo*: scheda
Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC
1.
• prima edizione dell’opera*: Giovanni Raboni, Cadenza d’inganno, Milano, Mondadori, «Lo Specchio», 1975 (CI).
- successive edizioni vivente l’autore
a) Giovanni Raboni, A tanto caro sangue. Poesie 1953-1987, Milano, Mondadori, 1988 (ATCS): autoantologia dell’intera produzione poetica di Raboni fino al 1988. Sono presenti alcuni testi di Cadenza d’inganno con varianti d’autore.
b) Giovanni Raboni, Tutte le poesie (1951-1993), Milano, Garzanti, 1997 (TP97): accoglie buona parte delle varianti presenti in A tanto caro sangue e ne introduce di nuove; modifica la mise en page.
c) Giovanni Raboni, Tutte le poesie (1951-1998), Milano, Garzanti, 2000 (TP00). Riprende il testo e la mise en page dell’edizione precedente.
• edizioni postume:
a) Giovanni Raboni, L’opera poetica, a cura e con un saggio introduttivo di Rodolfo Zucco e uno scritto di Andrea Zanzotto, Milano, Mondadori, 2006 (OP): viene riproposta la lezione della princeps (CI) in quanto nel volume è riprodotto integralmente ATCS. La scelta è dovuta alla volontà di evitare ripetizioni di testi identici, secondo un’esigenza espressa dallo stesso Raboni al curatore in una lettera del 2003 (cfr. p. 238).
b) Giovanni Raboni, Tutte le poesie. 1949-2004, a cura di Rodolfo Zucco, Torino, Einaudi, 2014 (TP14); Cadenza d’inganno è riprodotto secondo la lezione presente in TP97 e TP00.
• edizione corrente e testo su cui si basa: TP14
• primi testimoni noti dell’opera*:
a) materiali dattiloscritti: cfr. punto 6.
b) pubblicazioni in rivista: «Letteratura», V, 1958, 33-34, pp. 51-56 (Le1958); «il verri», IV, 1960, 5, pp. 78-79 (Ve1960); «Quaderni piacentini», V, giugno 1966, 27, p. 54 (QP1966); «Paragone», XVII, ottobre 1966, 20, pp. 117-118 (Pa1966); «Nuovi Argomenti», aprile-giugno 1967, 6, pp. 67-69 (NA1967); «La Fiera letteraria», XLIII, 1968, 7, pp. 12-13 (FL1968); «Nuovi Argomenti», gennaio-marzo 1969, 13, pp. 36-41 (NA1969); «Paragone», XX, 1969, 228, pp. 57-58 (Pa1969); «Studi cattolici», XIII, 1969, 105, p. 851 (SC1969); «Nuovi Argomenti», gennaio-marzo 1970, 17, pp. 75-76 (NA1970); «Nuovi Argomenti», 26, 1972, pp. 86-87 (NA1972); «Almanacco dello Specchio», 4 [marzo] 1975, a cura di Marco Forti, con la collaborazione di Giuseppe Pontiggia, Arnoldo Mondadori, pp. 233-240 (Al1975).
c) Edizioni parziali confluite in CI: Giovanni Raboni, L’insalubrità dell’aria, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1963 (IA); Giovanni Raboni, L’intoppo, Miano, Vanni Scheiwiller, 1967 (In); Giovanni Raboni, Economia della paura, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1970 (EP).
2.
• precedente edizione critica del testo*: NO
• precedente edizione scientifica di riferimento*: OP, dove l’apparato critico di Cadenza d’inganno, costituito dalle sole stampe (in volume, parziali o su riviste), è alle pp. 1465-1517; per il testo utilizzato in questa edizione cfr. punto 3.
3.
• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*
L’edizione adotta il testo proposto in TP97 e poi in TP00. La curatrice ha scelto di rispettare l’ultima volontà d’autore e di offrire la lezione del testo che Raboni aveva elaborato «per il più vasto pubblico della fine degli anni Novanta, quella con cui anche le nuove generazioni hanno conosciuto e amato il libro, quella di maggior diffusione nel tempo, anche grazie a due ristampe e due edizioni» (p. 241). La precedente scelta di Rodolfo Zucco di riproporre la lezione della princeps in OP, parimenti legittima ed avallata dallo stesso autore prima della morte, rispondeva infatti all’esigenza di evitare la ripetizione di testi identici all’interno dell’opera completa (in quanto esso accoglie l’autoantologia ATCS).
4.
• criteri di edizione*
La lezione messa a testo, come si è detto, è quella di TP97 e TP00, nelle quali si trova espressa l’ultima volontà d’autore. Il guadagno di questa scelta è duplice: da un lato, si propone l’approdo del processo di rielaborazione del testo, «non eclatante, forse, ma continuo» (p. 241) e documentato nelle sue fasi dall’apparato critico; dall’altro, si restituisce la forma che ha avuto maggior impatto sulla ricezione del testo.
Per quanto concerne l’apparato critico, esso è articolato «in due livelli» (p. 243). Da una parte la descrizione bibliografica dei vari testimoni collocata in fondo al volume (pp. 244-268), ordinata secondo le diverse tipologie di materiali (dattiloscritti, pubblicazioni in rivista, edizioni parziali, edizioni complete, edizioni antologiche). Dall’altro, l’apparato critico vero e proprio dei testi che presenta a piè del testo la fascia delle varianti, con numero del verso e trascrizione della porzione testuale soggetta a mutamento delimitata da parentesi quadra chiusa, e seguita dalle lezioni che se ne discostano individuate dalle sigle dei testimoni, sia dattiloscritti che a stampa, ordinate in senso cronologico (in corsivo e tra parentesi tonde i chiarimenti dell’autrice). In calce ad ogni componimento si trova, disposto su due righe, l’elenco dei testimoni secondo un ordine cronologico (la prima per i testimoni a stampa e la seconda per i dattiloscritti). È presente, dove necessario, una terza riga con le funzioni di illustrare la collocazione del testo in gruppi o sezioni, di chiarire, con riferimenti a documenti di vario genere (come scambi epistolari), il passaggio da una sede all’altra e i rapporti con gli altri testi, di avanzare ipotesi di datazione, di specificare la presenza di dediche, note ed epigrafi. La curatrice fa parco uso di simboli, limitati al chiarimento delle scansioni versali, strofiche e in paragrafi, o per segnalare l’introduzione dei numerosi documenti epistolari utilizzati.
5.
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)
Nella Nota al testo (in particolare alle pp. 241-242) l’autrice fornisce alcune notazioni interpretative di critica delle varianti relative al movimento correttorio di Cadenza d’inganno. Nell’insieme, le varianti d’autore, sia dattiloscritte che a stampa, testimoniano «di una misurata ma costante tendenza rielaborativa alla riduzione», tanto che è possibile parlare – eccezion fatta per quanto concerne la lirica Le storie (cfr. p. 242) – di «varianti costantemente “in levare”» (ibidem). In particolare, la lettura delle varianti presenti in apparato rende «visivamente percepibile il movimento discreto e costante che va dal (più) disteso allo scorciato, dal (più) evidente all’enigmatico», presentando al contempo l’allontanamento da un’«impostazione raziocinante e falso-dialogica […]» verso la voce lirica «indebolita e limitata, ma allineata alla persona biografica dell’autore, che costituisce il maggior elemento di coerenza testuale del libro» (ibidem). In definitiva, l’applicazione degli strumenti della filologia d’autore a questo complesso organismo testuale permette di cogliere in modo netto un «usus scribendi che declina la relazione occasione-scrittura in quella perenne dialettica tra le opposte tensioni della riconoscibilità e del depistaggio che è forse la chiave della poesia di Cadenza d’inganno» (ibidem). Alle pp. 270-274 sono inoltre presenti due Tavole di concordanza delle edizioni: una dalle pubblicazioni in rivista e dalle plaquettes fino alla princeps (pp. 270-272) ed una dalla princeps fino alle edizioni postume (pp. 273-274).
6.
• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*
Si indicano i fondi archivistici consultati e sono indicati, laddove se ne dia il caso, i dattiloscritti utilizzati per la costituzione dell’apparato:
- Archivio della trasmissione «L’approdo», Centro Teca Aperta, Sede Rai, Firenze.
- Archivio storico Arnoldo Mondadori Editore, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano: presenza del dattiloscritto di Economia della paura (EP1).
- Archivio Privato Giovanni Raboni, Milano: presenza di un dattiloscritto dell’Insalubrità dell’aria (IA4).
- Archivio Vittorio Sereni, Biblioteca Comunale, Luino (VA).
- Fondo Carlo Betocchi, Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti», Gabinetto «G.P. Vieusseux», Firenze: presenza di tre testimoni dattiloscritti di Insalubrità dell’aria (IA1, IA2, IA3) e di una prima stesura dattiloscritta di Le case della Vetra (CV1), dove compaiono alcuni testi poi inclusi in Cadenza d’inganno.
- Fondo Speciale Luciano Anceschi, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna. Fondo Vanni Scheiwiller, Centro Apice, Università degli Studi, Milano: presenza del dattiloscritto de L’intoppo (In1).
7.
• tipo di apparato/i*: genetico, orizzontale
• posizione dell’apparato*: a piè di pagina
8.
• presenza di note / commento al testo*: Sì
• tipo di note / commento*:
Ogni componimento è preceduto da un ampio cappello introduttivo e da una Nota metrica (con l’eccezione dei testi prosastici). Nel primo, trovano posto molteplici informazioni: sulla datazione e sulle occasioni private e pubbliche alla base dei componimenti, sulla collocazione macro-testuale, sui temi affrontati e sulle peculiarità stilistiche. Nelle note metriche, alle informazioni sulle scansioni versali e sulle rime, sono unite considerazioni ritmiche e analisi sulle altre figure di suono che contribuiscono alla coesione formale dei testi.
Le note di commento si appuntano su gruppi di versi o singole espressioni e forniscono, oltre ai necessari commenti linguistici, l’individuazione di costanti stilistiche e singole figure retoriche, di luoghi intertestuali (con particolare riferimento alla tradizione poetica occidentale moderna, ai classici italiani e alla poesia novecentesca italiana), di loci paralleli interni all’opera raboniana e singole notazioni sulla natura visivo-cinematografica dei componimenti.
• posizione delle note / commento*: a piè di pagina
9.
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*
Il volume è accompagnato da una prefazione a cura di Giancarlo Alfano (pp. XI-XVII) che si sofferma su vari aspetti: il rapporto storia-poesia che innerva il macrotesto del libro, la cui tenuta è garantita dall’esperienza singolare del soggetto, empirico e lirico, intorno a cui si articolano le occasioni poetiche; la presenza «di questioni e temi che avrebbero attraversato i successivi venticinque anni della sua esperienza poetica» (p. XV); la centralità dell’ambientazione urbana in Cadenza d’inganno e il costante riferimento al cinema, che concorre a «sottolineare sia la profonda visività della poesia raboniana, sia il suo interesse per una resa moderna della esperienza soggettiva» (p. XVI).
È presente una ricca introduzione della curatrice (pp. XIX-XCIII) articolata in otto paragrafi. Gli aspetti maggiormente indagati sono l’originale vocazione di Cadenza d’inganno ad assumere le forme dell’«inchiesta impossibile» (pp. XIX-XXVIII) su un materiale sia privato che pubblico, definita «una sorta di adynaton, realizzazione dell’inattuabile valenza conoscitiva della poesia» (p. XX); l’articolato dibattito sulla poesia tra anni Sessanta e Settanta (pp. XXVIII-XXXVI); la posizione che la poesia di Raboni occupa nel delicato momento di passaggio storico-letterario, in cui il linguaggio lirico si fa maggiormente inclusivo nei confronti della realtà e della storia, indagata anche attraverso numerosi riferimenti alla produzione di critico militane del poeta (pp. XXXVI-XLVIII); la scelta del titolo e le sue ricadute ermeneutiche sulla «strategia» testuale adottata (pp. XLVIII-LII); i principi che sottendono alla progressione di senso del macrotesto, variegato e apparentemente caotico, ma invece orchestrato in senso diaristico (pp. LII-LVIII); l’evoluzione nella postura dell’io, che è chiave di volta della struttura macro-testuale(pp. LLVIII-LXV); il valore civile della poesia raboniana (pp. LXV-LXXIV); il difficile equilibrio tematico (pp. LXXIV-XCI) che il libro riesce a raggiungere bilanciando i suoi temi (familiare, amoroso, civile) apparentemente in contraddizione, anche attraverso l’uso di una «strategia eminentemente visiva» (p. LXXV) che fa perno sul «montaggio» (p. LXXVIII) di matrice cinematografica ma anche psico-analitica, nei termini della condensazione onirica (p. LXXXI) di frammenti ricomposti in un’unità enigmatica, di cui sono tic stilistici sono l’ossimoro (pp. LXXXVI-LXXXVII) e l’uso di una metrica «collocata tra canone e libertà» (pp. LXXXVII-XCI).
Sono presenti due Tavole di concordanza delle edizioni (cfr. punto 5).
È presente un’appendice che raccoglie una trascrizione dell’intervista a Giovanni Raboni condotta da Vittorio Sereni in merito A cadenza d’inganno e andata in onda alla RSI il 30 marzo 1976 (pp. 277-279, dove è anche presente un QR-code per ascoltarla online) e un’intervista a Giovanni Raboni del 2004 condotta dalla curatrice del volume, già pubblicata come Intervista a Giovanni Raboni «Italianistica», XXXIII, fasc. 3, 2004, pp. 125-135 (qui alle pp. 280-296).
Concludono il volume una Bibliografia (pp. 299-313), l’Indice degli autori e delle opere (pp. 317-321) e l’indice del volume (323-325).